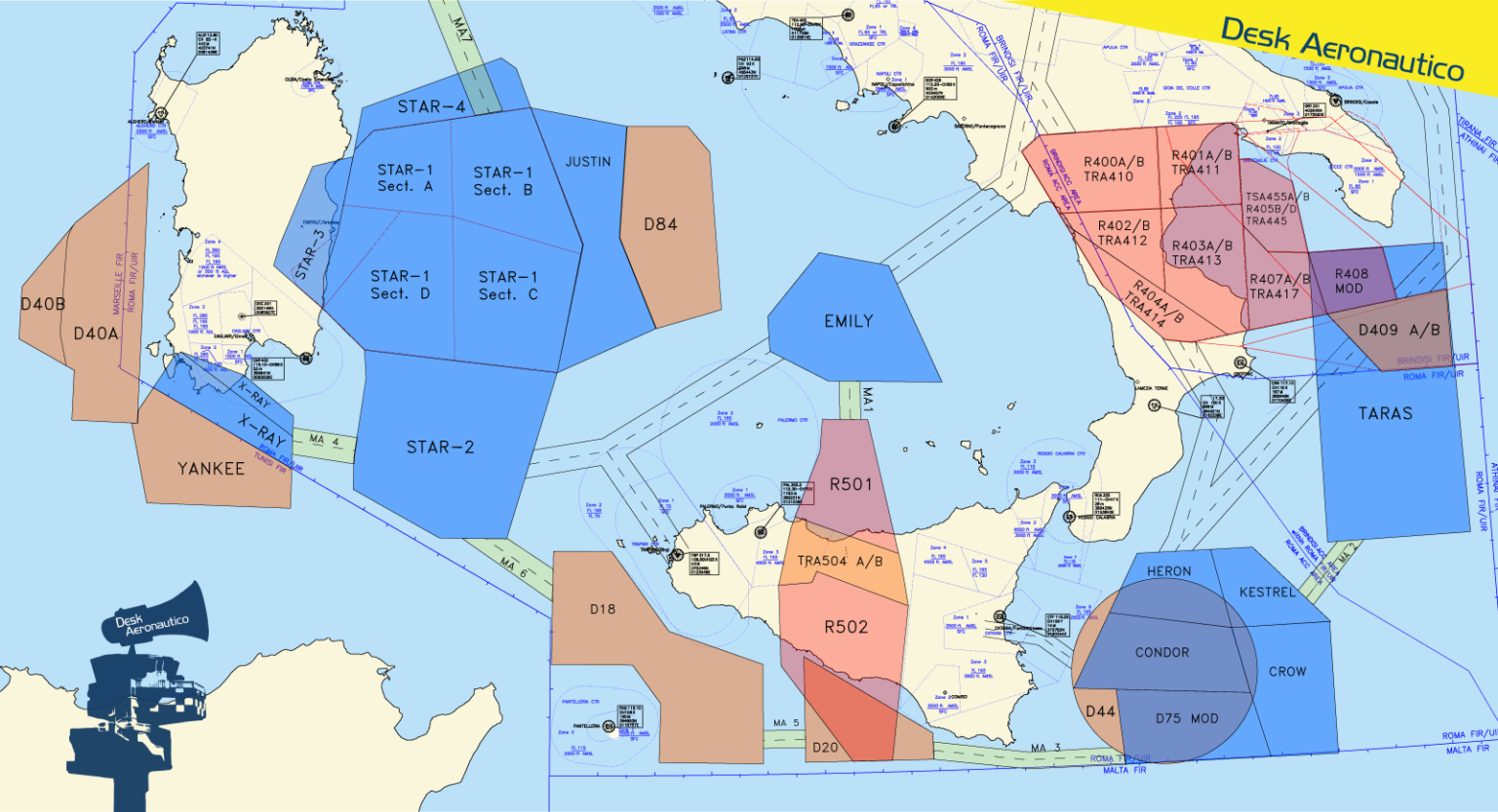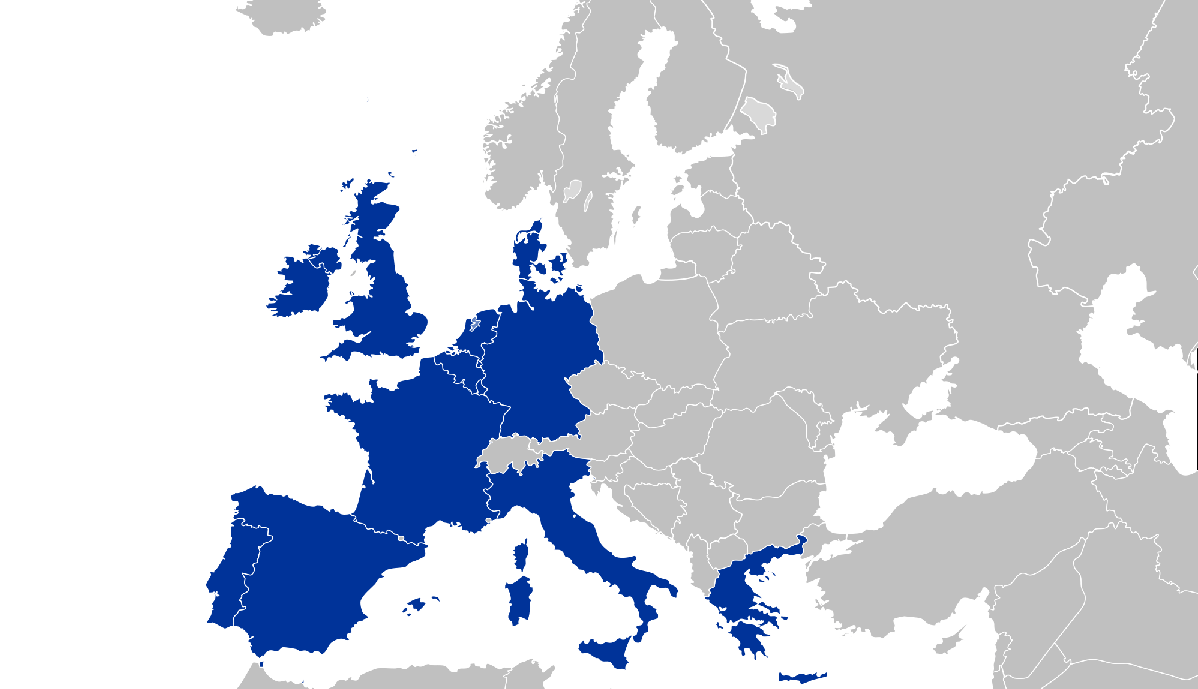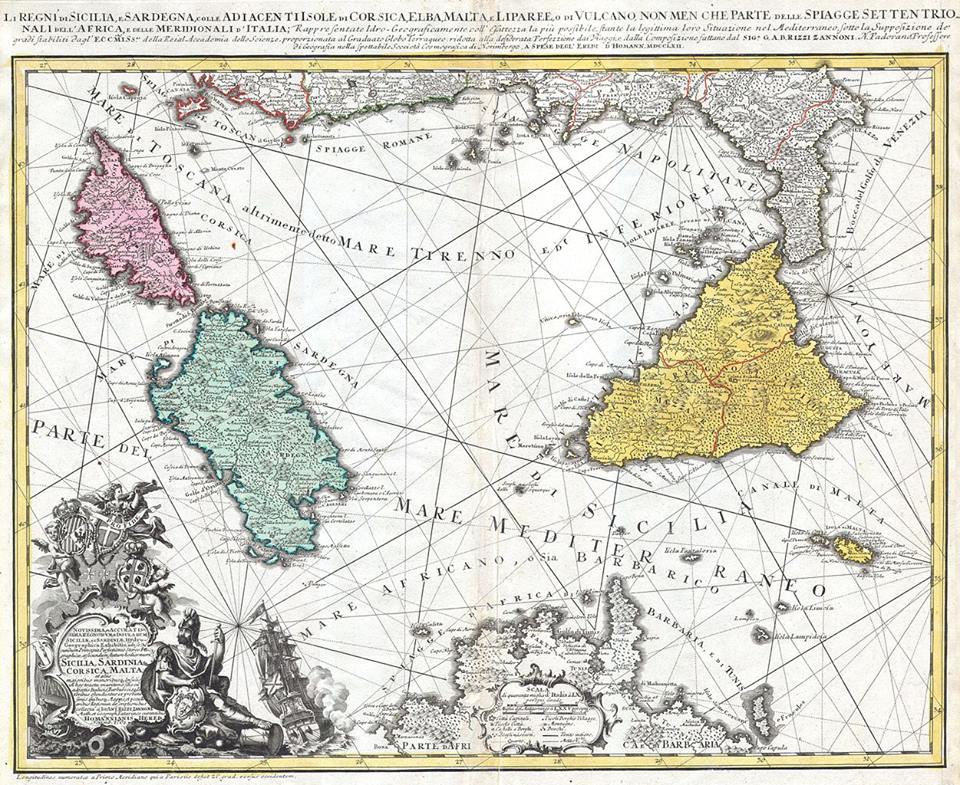Il contributo che pubblichiamo offre una serie di approfondite riflessioni giuridiche, antropologiche e filosofiche a margine del Trattato di Lisbona, a partire dall’idea di un ontologico desiderio di cittadinanza quale vocazione e condizione unificante del genere umano e quale presupposto di ogni autentica integrazione comunitaria, quindi anche del processo di integrazione e dell’identità europea.
di avv. Massimo Asero – esperto di diritto dell’Unione europea, teorico del diritto europeo
I – Identità europea, processo di integrazione e cittadinanza a cavallo tra secondo e terzo millennio.
Il processo di integrazione europea rinviene le sue ragioni più prossime nelle drammatiche esperienze del Novecento, secolo che per esse è divenuto breve e “ultimo giorno” della storia, a volere così parafrasare la nota teoria che di quella denunciava la fine. A volere ricercare oltre le ragioni più antiche e profonde del progetto europeo sembra invece di dovere collocare il suo senso più autenticamente costitutivo e radicale nell’orizzonte descritto dalla domanda identitaria fondamentale, che riguarda insieme il diritto e la politica, la storia e la cultura, la religione e l’antropologia del vecchio continente, ed è una domanda ontologica, che insiste al di là di ogni pur drammatico succedersi di eventi: che cos’è l’Europa?[i]
Questa domanda interroga a fondo la condizione umana della postmodernità, emersa con tutta evidenza e drammaticamente a seguito delle esperienze totalitarie dello scorso secolo[ii], e si caratterizza e specifica proprio in relazione a quella condizione. Non è un caso, infatti, e si può ritenere costituiscano in definitiva le fondamenta più autentiche e solide dell’intero processo di integrazione europea dei nostri giorni, che le dinamiche identitarie della postmodernità nascano e si sviluppino lungo quel filo rosso che attraversa la riflessione filosofica del Novecento sulla crisi della modernità e, sin dai primi anni sessanta, dedica una crescente attenzione ai problemi dell’agire umano tanto in riferimento alla vita individuale che all’appartenenza ad una comunità civile ed alla costituzione di una comunità politica. In sintesi, il dibattito giuspubblicistico continentale, che prende le mosse dall’area culturale di lingua tedesca e vieppiù si allarga trovando anche significative convergenze con la riflessione oltre Oceano, si concentra sui problemi della morale, della società, della politica e del diritto con l’obbiettivo di guardare oltre la crisi che ha travolto la razionalità moderna e tornare a riflettere sull’uomo[iii]. A tale scopo esso finisce per evidenziare la necessità di una riabilitazione della morale e del cittadino nella ritrovata consapevolezza, che è specialmente propria della originaria componente neoaristotelica del movimento, della fondamentale unità ontologica con l’uomo che è data nello zoon politikon; mentre al di là dei margini della polis rimangono significativamente il non-uomo e l’oltre-uomo[iv], le belve e gli dei[v]. E proprio la appartenenza ad una comunità civile e la costituzione di una comunità politica, lo si dice en passant e in una primissima approssimazione, fonda le (o rinvia alle preesistenti?) categorie della cittadinanza e dell’estraneità, che, nella loro interdipendenza, manifestano l’esigenza di affrontare il rapporto con l’altro[vi] lungo la direttrice che congiunge i percorsi identitari individuali e collettivi; e tradizionalmente afferma e rafforza l’appartenenza, al di là di ogni diversità tra i membri di un gruppo, proprio grazie e in virtù del consolidamento dell’esclusione di altre forme di diversità. Queste ultime, infatti, per il fatto stesso di essere tenute ai margini della Città, sono considerate comunque più radicali, non integrabili nella comunità politica di riferimento e per lo più neppure assimilabili… Individuando in tal modo lo schermo insuperabile che separerebbe, al di là di ogni buon proposito, ai nostri giorni codificato giuridicamente essenzialmente attraverso l’istituto della naturalizzazione, l’uomo dal cittadino, di ogni epoca[vii].
È quella ora assai fugacemente richiamata la direttrice che il dibattito continentale europeo più accorto, in significativa sintonia peraltro con la riflessione condotta al di là dell’Atlantico, ha inteso proporre per affrontare in generale i problemi dell’Ordine nelle società postmoderne, tra fine del secondo e inizio del terzo millennio[viii], in quei giorni di passaggio che segnano uno dei rari momenti di interpunzione della storia nei quali i vecchi modelli di ordine sono ormai logori ma non sono ancora definiti quelli nuovi in grado di sostituirli[ix]. Giorni nei quali sia i processi identitari individuali che quelli collettivi, attraverso i quali ultimi si realizza lo sviluppo, in forma di progressive integrazioni e sintesi unitarie, delle comunità politiche esistenti e la costituzione di nuove forme comunitarie, pongono nuove e fondamentali domande di senso che denunciano i limiti della razionalità moderna e la crisi dei modelli di scientificità che questa aveva “cucito addosso” alle scienze pratiche di matrice aristotelica, economia, politica e diritto, tutte slegate da ogni genetico legame alla morale e all’etica. E non vi è dubbio che proprio tra i nuovi modelli che la postmodernità scopre e sperimenta per esprimere e dare forma al fenomeno dei processi integrativi, al di là del logorato retaggio simbolico della sovranità nazionale, sia esemplare per quanto da vicino ci riguarda, e riscuote un sempre crescente interesse per la possibilità di riproduzione in altri ambiti del pianeta, proprio il modello (prima della Comunità e, soprattutto, adesso) dell’Unione europea.
È questa, ma si procede consapevolmente per via di sommarie ricostruzioni e di astrazioni sintetiche, la via che conduce, ha condotto, alla grande rivoluzione dell’Occidente, quella che non conosce distinguo tra Parigi e Filadelfia, il nuovo Ottantanove, quello che, per richiamare ancora Francis Fukuyama, avrebbe dovuto addirittura segnare (e condurre al) la fine della storia[x].
E, per riprendere il caso della Comunità e poi dell’Unione europea, la fine disegnata dall’Ottantanove dei popoli, almeno da quelli occidentali[xi] determina il progressivo sgretolamento e infine la caduta del Muro tra est e ovest[xii], dei muri sovrani tra identità individuali e collettive[xiii], identità forse ormai rassicuranti e consolidate ma progressivamente erose e de-strutturate dai tratti propri della postmodernità e con essa della incombente mondializzazione, dei Muri tra le due Città, tra l’Europa e l’Asia, e segna un punto di non ritorno rispetto alla riflessione sulle identità. Non vi è dubbio, in tale senso, che la costruzione prima, e la permanenza poi, del Muro definivano i confini delle Polis, le identità collettive e le appartenenze dei cittadini dell’una e dell’altra e insieme, proprio all’interno dell’equilibrio tra i due contrapposti blocchi, e degli stati nazionali che ne facevano rispettivamente parte, stabilizzavano, per così dire, le identità individuali grazie ai meccanismi di inclusione ed esclusione che esso permetteva. La cittadinanza moderna costituisce, infatti, all’interno dell’orizzonte della sovranità che ne è condizione di senso, un criterio giuridico con il quale definire la appartenenza, e corrispondentemente l’esclusione, e costituire le identità all’interno della contrapposizione tra noi e gli altri. Criterio che comunque è inscritto nell’Ordo artificialis della modernità e si sostanzia per ciò in un riconoscimento del cui potere è titolare, secondo le varie ricostruzioni teorico-epistemologiche del diritto e della politica, ora il sovrano quale detentore della decisione, ora la Norma dell’ordinamento giuridico che neutralizza il momento costituente e definisce (dovrebbe definire, al di là delle stesse indicazioni di Kelsen, di cui si dirà oltre) essa stessa la cittadinanza e le norme che ne regolano l’attribuzione nella loro qualità di materia essenzialmente costituzionale. Proprio in tale orizzonte però, ed è questa una delle ragioni di crisi che percorre la Modernità, il cittadino è privato di quella dignità che ne faceva l’alter ego dell’uomo e lo Stato perde la legittimazione ontologica che era inscritta nel suo appartenere, attraverso le dinamiche originarie della sussidiarietà, ad un ordine naturale.
In questo contesto, che evidenzia tutta la sua problematicità nelle domande sul senso dello stato, sulla frattura tra nazione ethnos e nazione demos, il criterio giuridico con il quale la modernità aveva affrontato la definizione dell’appartenenza finisce per evidenziare una serie di contraddizioni e domande insolute sul cittadino, ormai mero suddito: fino a che punto si è uomini, per esempio, quando non si è cittadini[xiv], riflette Hannah Arendt, che della sua condizione di apolide (stateless) ha a lungo fatto, per così dire, l’incarnazione di una denuncia? O davvero la soluzione, negli esiti perversi cui ha condotto nel corso del Novecento, finisce per essere peggiore del problema che intendeva risolvere e chi non è cittadino è solo schiuma della terra?[xv]
Comunque sia, la caduta dei Muri e la perdita delle coordinate geopolitiche e spaziali che avevano rappresentato l’ordine costituito in quel mosaico internazionale nel quale l’Europa non era più il centro e cuore pulsante del disegno, ha prodotto uno schock antropologico e una nuova crisi della coscienza europea rinnovando l’interesse per le domande identitarie : anzitutto, ancora una volta, che cosa è l’Europa?
L’impatto della mondializzazione sul nascente Ordine occidentale, figlio per l’appunto della «fine della storia» e della conseguente affermazione di un modello unico – sia economico, quello di ispirazione liberista, che politico, quello delle democrazie occidentali – è a ben guardare, come si dirà una opportunità più unica che rara per l’Europa di tornare ad essere fulcro del mosaico globale. E’ la possibilità, per così dire, di rientrare in gioco e partecipare a pieno titolo alla discussione del nuovo Ordine mondiale, del quale era fautrice e protagonista sino agli eventi del Novecento; è in tale direzione ri-affermare la propria identità, che ha attraversato caratterizzandola già la prima mondializzazione[xvi] e definito l’Ordine mondiale, proporre la propria visione e il proprio modello politico, giuridico, economico, antropologico, tout court, alla ricerca di una normatività e di una decisione adeguate alla sfida per quella che a tutt’oggi può dirsi una prolungata fase costituente sovranazionale in cui le coordinate tradizionali sono appunto state messe fuori gioco dalle dinamiche del diritto economico internazionale e della tecnologia, particolarmente nelle sue applicazioni cibernetiche, informatiche e finanziarie, che alimentano le nuove Reti del potere transnazionale e mettono in grave difficoltà le dimensioni della sovranità del diritto statuale e della politica tout court.
La riflessione sui processi integrativi e sui modelli di Ordine postmoderni apre pertanto la strada al recupero delle lezioni del passato, all’unità prospettica dell’Europa con l’Altro, in relazione al quale solo trova definizione la propria identità – in un orizzonte ontologico che è anzitutto geologico, riguarda significativamente la terra, il Territorio – ma poi è anche identità culturale e religiosa. Basti pensare particolarmente a tale riguardo, e queste sono davvero le radici profonde dell’Europa, a quell’Europa il cui centro era proprio nell’area mediterranea, oggi significativamente al centro della nuova soggettività della Unione per il Mediterraneo che è pensata come braccio, “armato” della propria storia e identità, per avviare un percorso possibile per i problemi dell’area euromediterranea; basti pensare cioè all’Europa delle quattro colonne, la Grecia classica e le tre grandi culture religiose monoteiste, l’islamica, l’ebraica e la cristiana, che insieme ne costituiscono le fondamenta e sono chiamate a sorreggerla, ponendo le basi per un nuovo Ordine che mette a capo del problematico rapporto con la diversità il riconoscimento reciproco che si accompagna all’affermazione di significato che è di ogni persona, nella comune appartenenza alla famiglia umana, nucleo fondamentale da cui avviare una nuova sussidiarietà. Ancora, proseguendo nella descrizione di quell’orizzonte ontologico che permette di definire l’Europa, non è dubbio che esso riguarda perciò anche il Popolo, i popoli, e insieme ai Cittadini gli Uomini, e il loro Ordine, che tra gli uni e gli altri non conosce fratture[xvii].
E l’Altro è nello specifico Asia, della quale è sorella in Esiodo, ma insieme è anche Africa, essendo Europa altresì nipote di Libia in Ovidio, parentele e affinità genetiche che sottolineano insieme la ontologica Unità nella diversità, che poi è in definitiva il senso più profondo della via intrapresa con la creazione della Unione per il Mediterraneo, adesso per ciò stesso considerato il “braccio della Unione europea per una politica dell’accoglienza”[xviii].
E il Nuovo Testamento della Unione europea rappresenta proprio l’edificio, la Casa comune dei popoli europei, la cui costruzione si è reso possibile ed anche necessario avviare una volta abbattuti i muri della separazione tra gli uni e gli altri. Quei nuovi processi integrativi propongono e rappresentano nella forma di dinamiche identitarie complesse le risposte che di fronte alla postmodernità, alla mondializzazione e alla crisi radicale dell’Ordine, che è perdita di ogni localizzazione del Sovrano, prima ancora e più che autentica decapitazione del medesimo[xix], strategicamente “rifugiato” tra le Reti della postmodernità, il diritto pubblico e la geopolitica propongono sotto la significativa egida dell’economia… O, per dirla in poche parole, il tentativo di rispondere alla nuova, parimenti epocale, crisi della coscienza europea.
Tornano di nuovo in mente per tale via alcune delle conclusioni più significative di un celebrato studio di Paul Hazard che analizza proprio la coscienza europea segnalando in particolare quella (altra) crisi che, a cavallo tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, produsse il passaggio da una civiltà fondata sull’idea del dovere ad una fondata sull’idea di diritto: i diritti della coscienza individuale, i diritti della ragione, i diritti dell’uomo e del cittadino. Crisi senza pari nella storia della coscienza europea e che avrebbe preparato la rivoluzione francese.
E le conclusioni della puntuale indagine di Hazard segnalano significativamente la natura problematica e, per così dire, senza fine del processo identitario dell’Europa e insieme dunque la complessità della sua storia e del suo percorso di autocomprensione.[xx] Questo dato è confermato ove si assuma la prospettiva di analisi odierna, collocati come siamo a ridosso della fine di un millennio e con lo sguardo già immerso nel nuovo da ormai un decennio.
In questo senso, infatti, per un verso l’immaginario collettivo attribuisce forti valenze simboliche alla fine di un millennio, le quali finiscono per suggerire o addirittura imporre l’opportunità di bilanci individuali e soprattutto collettivi della condizione umana. Per l’altro, l’inizio di un millennio assume il significato di un momento di svolta per la storia dell’umanità, là dove per l’appunto nuove trame si intessono con le tele della storia e della coscienza d’Europa e nuovi ordini, ancora non meglio definiti, si cerca di sostituire a quelli ormai inadeguati che hanno caratterizzato la Modernità.
Sicché, come già si è accennato, le domande che intendiamo porci, in quel crocevia della storia tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio, sono in definitiva ancora una volta quelle che segnano ogni processo di definizione delle identità individuali e collettive e dei processi integrativi che accompagnano le dinamiche culturali, politiche e giuridiche di una civiltà, e dunque: che cosa è l’Europa? E, insieme, riprendendo, parafrasandolo, il titolo dello studio di Hazard: a che punto è la crisi della coscienza europea?[xxi]
In questo senso, la elaborazione del progetto di costituzione per l’Europa e, dopo la mancata approvazione del “Trattato che adotta una Costituzione”, la firma a Lisbona del “trattato di modifica” per l’Unione europea (dicembre 2007), rappresentano una cartina di tornasole per esaminare gli sviluppi più recenti del processo di integrazione europea. E a ben guardare, se per un verso è ormai certo lontano il fantasma della guerra, esse rivelano ancora la medesima anima che già le acute conclusioni di Hazard segnalavano: una forma contraddittoria, ad un tempo rigida e incerta e insieme un pensiero sempre insoddisfatto. Non sembra, infatti, esservi modo migliore per definire il succedersi, nel breve volgere di pochi anni, di un processo costituente formale, ispirato al progetto di costruire una una Grundnorm europea che formalizzasse in un testo costituzionale ciò che già era nella costituzione sostanziale europea, a livello e tra le maglie dei trattati, e affrontasse una volta per tutte i problemi del cosiddetto “deficit democratico” e della governance europea, e di un trattato, quello firmato a Lisbona ed ancora non entrato in vigore[xxii], nel quale insieme alla cancellazione dei simboli[xxiii] della integrazione europea emerge una logica significativamente definita anticostituzione[xxiv].
A scanso di equivoci, e come rileva autorevolmente Giuliano Amato, che ha rappresentato il nostro Paese alla Convenzione europea in qualità di vicepresidente, l’Europa non è, non pensa se stessa (solo) come un mercato, e questa consapevolezza era già progetto nelle intenzione dei Padri costituenti europei quando decisero di costruire l’Europa a partire da un mercato comune, soluzione meramente strumentale e di ripiego rispetto all’obiettivo reale, quello di un’unione politica, secondo un intendimento esplicito in Spinelli, e cui era favorevole lo stesso Schumann, ma ostacolato dal “no”, significativamente opposto proprio dai francesi[xxv].
Con la caduta del Muro di Berlino vengono infine in essere le condizioni per realizzare, accanto e oltre alle nuove forme di integrazione economica, il disegno di una Unione europea quale forma entro la quale avviare e comprendere le nuove dinamiche politiche integrative nel Vecchio continente. E il progetto pone significativamente l’istituzione della cittadinanza europea al centro della riflessione sull’identità europea, che è, lo si è già accennato, discussione sulla postmodernità e all’interno di questa particolarmente dibattito sui modelli di Ordine nell’età della mondializzazione e con essi sui processi identitari individuali e collettivi e sulle nuove dinamiche integrative che a quei processi si accompagnano. La vera scommessa europea nasce qui. Al di là del ruolo predominante della techne e dell’economia, che ha annichilito all’interno della tripartizione delle scienze pratiche tanto il diritto che la politica, la cittadinanza europea può divenire il segno di una ri-abilitazione della categoria concettuale del cittadino tout court e della Politica, ad essa legata da un rapporto ontologico che la Modernità ha rescisso. E non è casuale, infatti, che a Maastricht venga altresì “riesumata” la sussidiarietà, pure in una direzione e valenza concettuale assai problematica – che riflette ancora una volta le mille anime contrastate della coscienza europea…[xxvi] Istituti tutti che non a caso hanno poi cominciato ad animare anche i dibattiti nazionali e a fecondare gli ordinamenti giuridici costituzionali.
In questa azione di ricerca genealogica e concettuale, che è ritrovamento delle proprie radici più profonde e scommessa sulla propria identità, ci sono i germi per fronteggiare la globalizzazione e la sua capacità destrutturante di ogni identità, e creare un sentimento di appartenenza all’Unione, che è presupposto per lo sviluppo di un demos europeo. La ri-abilitazione della cittadinanza, oltre le accuse di ipocrisia e di filisteismo, mosse rispettivamente da Marx e Nietsche, e alla ricerca di una sua declinazione che recuperi l’identità riconciliata di Europa con l’Altro, è la sola via perché l’Europa possa effettivamente avanzare la sua proposta politica e aprire le porte ad una piena convivenza tra sentimento di appartenenza e integrazione che da sempre ha costituito il DNA delle nazioni europee, come segnalano con la consueta profondità le parole di Ortega Y Gasset:
“ciascuna delle nostre nazioni, in quanto società particolare, possiede fin da principio due dimensioni. Nell’una di queste dimensioni ciascuna vive in seno alla grande società europea costituita dal grande sistema di usi europei, a cui, molto impropriamente, diamo il nome di “civiltà europea”. Nell’altra dimensione, ciascuna si comporta secondo il repertorio dei suoi usi particolari, cioè differenziali. Ora, se abbracciamo con un solo colpo d’occhio tutto il passato occidentale, noi rileviamo che esiste un certo ritmo nella predominanza di una delle due dimensioni sull’altra».[xxvii]
II – «Desiderai essere un cittadino»: storie della coscienza europea tra continuità sussidiaria dell’uomo nel cittadino e carattere borghese…
Sin qui ho tratteggiato il legame tra processo di integrazione e identità europea a cavallo tra secondo e terzo millennio lungo quel sottile filo rosso rappresentato dalla riflessione sulla postmodernità; ho segnalato, in particolare, all’interno di quest’ultima, il composito dibattito sulla Riabilitazione della filosofia pratica, richiamando anzitutto la originaria componente aristotelica. Occorre peraltro ribadire che entrambe meriterebbero approfondimento ben più articolato giacché è fondato ritenere che esse costituiscano il cuore del dibattito sulla postmodernità, da cui in qualche modo hanno preso vita, per così dire, le arterie fondamentali e più vitali della discussione sulla globalizzazione postmoderna, nei suoi versanti giuridico, politico, economico, etico e in definitiva antropologico tout court. Ma anche della stessa riflessione sulla appartenenza ad una comunità civile e sulla costituzione di una comunità politica che ha accompagnato lo sviluppo, se non anche la stessa creazione, di nuovi modelli per esprimere e dare forma al fenomeno dei processi integrativi, al di là del logorato retaggio simbolico della sovranità nazionale, tra i quali esemplarmente proprio il modello (prima della Comunità e adesso) dell’Unione europea.
Si è fatto cenno, in tale senso, che proprio la discussione sulla pratica, sull’agire dell’uomo, tanto nella sua dimensione individuale che collettiva, conduce in definitiva ad individuare nell’istanza (ri)fondativa il segno essenziale ultimo della postmodernità. E tale ri-costruzione muove significativamente, in quella che certo non a caso è stata definita anche filosofia della polis, dal cittadino, nello sforzo teorico di una ri-abilitazione che è il presupposto necessario, nella strategia dei teorici della riabilitazione, per tornare a riflettere sull’uomo[xxviii].
Si tratta dunque di mettere in discussione le scienze pratiche singolarmente considerate e nel loro rapporto per definirne l’orizzonte epistemico proprio di ciascuna. La categoria concettuale della cittadinanza è a questo proposito emblematica e rivela tutta la problematicità di quel rapporto e la necessità di una sua ridefinizione. Il rapporto tra diritto e politica e, lungo la sottile linea rossa che li separa, quello tra diritto naturale e diritto positivo, mette in gioco a tale riguardo la continuità ovvero la frattura tra diritti dell’uomo e diritti del cittadino lungo la direttrice che congiunge la problematica identitaria descritta dall’istituto della cittadinanza – autentico e decisivo punto di convergenza tra identità individuali e identità collettive – alla riflessione moderna e postmoderna sulla sovranità: se tutti nasciamo uomini perché mai ogni uomo non dovrebbe poi avere, tra quelli umani, e parafrasando Hannah Arendt, il diritto al fondamentale diritto alla cittadinanza? E che cosa giustifica, nella identica condizione umana dei postulanti, l’attribuzione esclusiva di una sfera di diritti a coloro che appartengono alla Città, ne sono cittadini? O in altri termini, modificando il punto di osservazione, quale statuto dell’apolide, del rifugiato e infine dello straniero tout court ne salvaguarda l’umanità?
E’ lungo questo scenario problematico che si gioca il senso del processo riabilitativo del cittadino nella sua difficile continuità con la domanda identitaria fondamentale sull’uomo. Domanda che, all’interno della crisi della coscienza europea ha una valenza duplice: per un verso, ri-abilitare la nostra identità di uomini e cittadini europei e per l’altro affrontare il rischio che ogni processo di riabilitazione del cittadino porta con sé: definire l’appartenenza e consolidare una identità collettiva e le identità individuali che vi confluiscono ma ad un tempo pagare il prezzo dell’esclusione più o meno radicale di ogni altro. E rischiare di eludere per tale via la domanda che la crisi dei modelli di ordine e dei modelli integrativi della nostra epoca reca in sé, nella difficoltà di realizzare una precisa actio finium regundorum… dei confini estremi della città, delle periferie che segnano i limiti ultimi della appartenenza e oltre i quali si configura l’esclusione e con essa si scorgono i tratti dello straniero: chi è (sarebbe) lo straniero se il cittadino è (diventasse) globale? E, reciprocamente, chi sono (sarebbero) i cittadini in una società senza stranieri?
Nella prima direzione, della riabilitazione della nostra identità di uomini e cittadini europei, emblematico è l’insegnamento di Schmitt, per il quale “Si potrebbero analizzare tutte le teorie dello Stato e le idee politiche in base alla loro antropologia, suddividendole a seconda che esse presuppongano, consapevolmente o inconsapevolmente, un uomo «cattivo per natura» o «buono per natura».” e, citando adesivamente H. Plessner: «non esiste nessuna filosofia e nessuna antropologia che non sia rilevante politicamente […] filosofia e antropologia, in quanto sapere specificamente orientato al tutto, non possono neutralizzarsi»[xxix].
L’identità europea conosce in particolare due modelli, due antropologie politiche e giuridiche del cittadino di riferimento, l’uno essenzialmente fondato su un modello di ordine naturale, l’altro, al contrario, sulla costruzione artificiale dell’ordine[xxx].
In questo senso ho utilizzato nel titolo della mia relazione una celeberrima frase tratta dalla clausola testamentaria di uno dei più insigni giuristi del XIX secolo, Theodor Mommsen, che esprimeva per l’appunto il desiderio di cittadinanza, inappagato e ormai non più realizzabile per il celebre studioso romanista. Le dense parole dello studioso tedesco, scritte nel 1899 su un foglio di carta da lettere, evidenziano la problematicità della categoria del cittadino e delle sue molteplici determinazioni e insieme la fecondità della riflessione filosofico-giuridica quale via per porsi inoltre, indirettamente, un interrogativo di portata più ampia, sul senso della politica all’interno della modernità:
«Io non ho mai avuto e mai agognato posizione e influenza politica; ma nel mio intimo, e, credo, con ciò che in me è di meglio, sono sempre stato un animal politicum, e desideravo di essere un cittadino (borghese, nella traduzione di Sternberger). Questo non è possibile nella nostra nazione nella quale il singolo, e sia pure il migliore, non trascende il servizio nelle file e il feticismo politico. Questo straniamento interno dal popolo cui appartengo, mi ha indotto in tutto e per tutto a non presentarmi con la mia personalità, per quanto mi fosse in qualsiasi modo possibile, dinanzi al popolo tedesco, che non stimo.[xxxi]»
E’ questo il singolare lascito di Mommsen, ripreso anche nel titolo da Dolf Sternberger in un denso studio e poi in un saggio dedicato agli aspetti del carattere borghese[xxxii], e che ha attratto anche l’attenzione della dottrina italiana[xxxiii]. La radicalità del messaggio dell’insigne studioso è peraltro tanto più evidente in quanto esso serve ad un tempo a proporre un approfondimento categoriale del termine politica, che è indispensabile per comprenderne sino in fondo la complessità e giustificare l’altrimenti incomprensibile presa di distanze dal popolo tedesco, e attraverso il quale solo è inoltre possibile individuare gli slittamenti semantici e le metamorfosi del concetto del politico che ad essi si accompagnano. E’ lo stesso Sternberger, assai affine nella formazione ad Hannah Arendt, la compagna di studi di Heidelberg, a sottolineare che ciascuna parola ha un significato, e che non è detto tuttavia che comporti un concetto. In uno studio dedicato proprio al vocabolo politica ed al concetto del politico, selezionato dallo stesso scrittore per una raccolta apparsa postuma, si sottolinea che parlare del vocabolo politica significa interrogare il significato, i significati, la storia del suo significato… “Ma occupandoci di scienza, per esempio di scienza politica, non ci accontenteremo dell’uso delle parole, dell’uso del vocabolo «politica» e del vocabolo «politico» nelle sue accezioni abituali, quotidiane. Noi intendiamo trovare un concetto della politica, un concetto del politico…”.[xxxiv] Ed è proprio attraverso un tale studio genealogico-concettuale che l’insigne Autore ci consente di comprendere il senso più autentico della disposizione testamentaria mommseniana, segnalando lo slittamento semantico che nel passaggio al latino e poi alle lingue moderne ha prodotto la rottura del legame linguistico tra lo Stato, i cittadini e gli affari e le istituzioni statali-civili.[xxxv] Lo stesso Sternberger, nello studio dedicato agli aspetti del carattere borghese, identifica appunto il Bürger con il borghese, diversamente da quanto fa Giorgio Pasquali nel tradurre in italiano la clausola testamentaria di Mommsen, laddove il vocabolo tedesco è reso con cittadino: desiderai essere un cittadino, appunto, e non, invece, un borghese. Tornano ad emergere dunque i segni della crisi di identità che attraversa la coscienza europea nei secoli…
La parola tedesca Bürger ha infatti un duplice significato: essa individua tanto il citoyen (cittadino) della Rivoluzione francese che il bourgeois (borghese). La confessione di Mommsen apparirebbe così, nelle parole del filosofo e teorico tedesco, due volte paradossale.
Anzitutto perché esprimerebbe un rammarico, quello di non essere riuscito ad essere un borghese, in evidente contrasto con le devastanti critiche di Marx e Nietzsche, il primo dei quali ha marchiato la borghesia con l’infamante carattere dell’ipocrisia, e il secondo dei quali ha tributato allo spirito e alla morale borghese il carattere del filisteismo; e contro la critica dei bohémiens e dei letterati e dello stesso fronte critico interno alla borghesia medesima. Dopo le quali tutte assai difficile appare pensare possa esservi qualcuno che voglia ancora fregiarsi (o macchiarsi…) con un simile appellativo.
Ma poi anche per il fatto che sono proprio i primi decenni del nuovo Impero, nei quali pure si collocano l’esperienza di vita e il formarsi del desiderio che lo stesso Mommsen considera irrealizzato nell’approssimarsi della fine dei suoi giorni, a segnare il periodo più florido e di maggiore potenza della coscienza borghese e delle sue realizzazioni, e in cui dunque più agevole sarebbe stato portare a compimento quel desiderio.
Non è questo, evidentemente, il senso della disposizione testamentaria di Mommsen: il suo desiderio di cittadinanza è ben altro da una adesione allo spirito borghese, quello spirito conformemente al quale la politica rovinerebbe addirittura il carattere. Esso è desiderio di riabilitare la radice più profonda della coscienza politica europea: la naturale politicità dell’uomo che è espressa nella formula aristotelica dello zoon politikon. Il discrimine tra le due visioni è dato dal senso dell’appartenenza alla comunità: l’antropologia politica posta a fondamento del pensiero occidentale, che costituisce le autentiche radici dello ius publicum europaeum e con esso della stessa dinamica integrativa politica e culturale dei popoli europei[xxxvi], trova un solido fondamento nella struttura ontologica della natura. In tale cornice, Aristotele descrive la nascita della città muovendo appunto dall’orizzonte di senso della naturale politicità dell’uomo che si lega ontologicamente alla propria insufficienza a se stesso, quale trova compiuta espressione nel concetto di sussidiarietà – concetto che anima l’intera costruzione aristotelica e significativamente rappresenta uno dei principali istituti chiamati a fondare la costruzione politica dell’Europa da Maastricht in poi, vale a dire da quando proprio quella insufficienza di ciascuno, identità individuale o collettiva, a se stesso di fronte agli altri, ha prodotto lo sgretolamento dei muri e aperto la via a nuove dinamiche integrative in nome delle radici comuni dei popoli europei…
E’ proprio nella necessità di subsidium che è dell’uomo – e nel naturale Ordine che in esso trova espressione – che il desiderio di cittadinanza di Mommsen trova piena e compiuta espressione. E proprio perché fondato su un bisogno, sulla propria insufficienza, esso è un dovere prima ed insieme ad una rivendicazione di diritto. Provo in tale direzione a recuperare il percorso argomentativo di Aristotele. Esso prende le mosse a tale proposito dal presupposto platonico che l’individuo, preso da sé, non è sufficiente a se stesso. Se l’uomo bastasse a se stesso non ci sarebbero le unità sociali, dalla famiglia allo stato. E d’altra parte, proprio per questo, la società non ha un diritto proprio ma serve gli individui.
Per questa ragione – è questo il primo movimento in cui si traduce l’assunto della naturale politicità – nella costruzione di Aristotele l’uomo e la donna si uniscono per fini riproduttivi e il padrone e il servo lavorano insieme a partire da diverse disposizioni, in quanto la loro unione è ciò per cui entrambi possono sopravvivere. Così è naturale anche l’origine della famiglia, comunità sociale fondamentale che si costituisce per la vita di tutti i giorni, in cui i figli nascono già come membri di tale comunità e tale loro appartenenza si giustifica, secondo lo stesso principio naturale, per il loro stato di assoluto bisogno e di dipendenza dai propri genitori. Da questa deriva il villaggio, la prima comunità volta a soddisfare un bisogno non strettamente giornaliero, attraverso la costituzione di nuovi nuclei familiari ad opera dei figli, che abbandonano la primigenia indigenza assoluta per conoscere le forme in cui la incapacità di bastare a se stesso si manifesta nella condizione di uomo, e dei figli dei figli, e dalla loro unione. L’unione di più villaggi infine genera la città, che sorge per rendere possibile la vita e sussiste per produrre le condizioni di una buona esistenza.
Il cerchio si chiude: perciò ogni città, continua Aristotele, “è un’istituzione naturale se lo sono anche i tipi di comunità che la precedono, in quanto essa è il loro fine; cioè diciamo che la natura di ciascuna cosa è quello che essa è quando si è conclusa la sua generazione […] Ora, lo scopo e il fine sono ciò che vi è di meglio; e l‘autosufficienza è un fine e quanto vi è di meglio.” (corsivo mio)
Certo, come pure è stato osservato, questo naturalismo esprime una sussidiarietà che con terminologia moderna potremmo chiamare prettamente orizzontale; per quanto a noi interessa, tuttavia, è altrettanto evidente che ad un tempo esso giustifica la stessa sussidiarietà verticale, quale forma della organizzazione su più livelli di governo della sfera politica nazionale o internazionale. Infatti, in questa originaria declinazione, il principio sussidiario implica la concezione della comunità o della società come un ausilio e sostegno per l’individuo, e delle più elevate forme di comunità e società come aiuto e supporto per le forme inferiori e in ultima analisi per l’individuo[xxxvii]. Ma questo segnala ad un tempo la priorità logica, e per così dire inscritta nel codice genetico, della sussidiarietà orizzontale rispetto a quella verticale e la comune derivazione dalla dimensione di servizio all’individuo e al raggiungimento della autosufficienza di questo che si persegue a livello di ogni comunità sociale intermedia e più in là delle comunità politiche con finalità generali nella ricerca del bene comune di tutti gli associati [xxxviii].
Pertanto, la formazione di ulteriori comunità sociali intermedie o di nuove comunità politiche affonderebbe le sue radici nell’aiuto e più chiaramente nel bisogno immediato di aiuto degli individui e in via mediata delle società o delle comunità politiche intermedie, anche nazionali, in relazione alla intelligenza ed al conseguimento di un bene comune che ha carattere sempre più globale, e della conseguente unione per formare nuovi livelli di governo, com’è per il caso della stessa Unione Europea. Rispetto alle quali, in termini aristotelici, la doverosa attenzione per una dimensione orizzontale della sussidiarietà va coordinata con la assai più presente e frequente declinazione di quella verticale nella comune funzionalità di tutte le aggregazioni sociali e politiche agli individui, dalla cui incapacità di bastare a se stessi traggono origine secondo l’ordine naturale delle cose[xxxix]. Al di là (di) e contro ogni corruzione del proprio carattere borghese che evidentemente riguarda una ben diversa e più superficiale radice della politica che, nello slittamento semantico che abbiamo prospettato, altro non può dare che… frutti geneticamente modificati…
C’è almeno un’altra considerazione che occorre svolgere. Si tratta di rispondere alla possibilità di una lettura organicista del pensiero di Aristotele – la quale segnala l’assorbimento dell’individuo all’interno della comunità politica – e così lo smarrimento dell’uomo, e per quanto più da vicino ci riguarda la sua irripetibile individualità nella con-fusione col cittadino – e si nutre tra l’altro della tesi aristotelica secondo la quale “nell’ordine naturale la città precede la famiglia e ciascuno di noi. Infatti tutto precede necessariamente la parte” ed insieme “è chiaro che la città è per natura e che è anteriore all’individuo, perché se l’individuo, preso da sé, non è autosufficiente, esso sarà rispetto al tutto nella stessa relazione in cui lo sono le altre parti”.
Tale ricostruzione, che segue nel testo della Politica l’uso di una analogia tra l’individuo e le comunità pre-politiche e gli organi del corpo umano in grado di compiere le loro attività solo dentro l’organismo cui appartengono, e che pure annovera importanti consensi[xl], non mette conto che la genesi della Città si radica nella condizione umana individuale, che ne è il presupposto antropologico e insieme l’orizzonte di riferimento. L’uomo è – lo si ripete – un animale politico siccome egli è alla ricerca di una autosufficienza che, in quanto individuo uomo, non ha. Per tale ragione, c’è in tutti lo stimolo a costruire una delle naturali comunità descritte da Aristotele – e particolarmente la polis, nella quale emerge la propria specificità di essere non semplicemente naturale ma politico che può realizzare il proprio fine individuale più alto proprio attraverso una partecipazione attiva e cosciente che consente di comunicare con gli altri a mezzo del discorso e dell’attività politica[xli]. Rispetto ad un assorbimento dell’individuo nella comunità, vale qui, insomma, nella prospettiva di un ordine naturale immanente, quanto pure si può osservare a proposito dell’ordine metafisico cristiano della Città di Dio, che certo preesiste ad ogni singola esistenza umana e ne è il fine ma non sacrifica l’individuo e la sua libertà di scelta: l’uomo conserva la propria assoluta indipendenza ed assume le proprie decisioni senza vincoli di fronte allo stesso Ordine metafisico di Dio, il quale in un apparente paradosso è invece “soggetto” al libero arbitrio dell’individuo. Ma la specificità e la piena realizzazione di sé coincide senza residui con un libero arbitrio che si svolga in coincidenza della libertà “decisa” per lui dall’Ordine divino nel quale si inscrive il progetto individuale assegnato a ciascuno.
D’altra parte, anche la critica aristotelica a Platone e all’anonima relazione di comunione di donne, bambini e proprietà conferma l’assenza di una ipostatizzazione della comunità politica. Nel libro secondo della Politica, dedicato proprio ai limiti della comunanza, Aristotele giunge a confermare che l’orizzonte ontologico nel quale si inserisce la naturale costruzione della polis è naturalmente funzionale allo scopo per il quale gli individui, e le comunità sociali intermedie, si sono uniti per costituirla: il raggiungimento dell’autosufficienza. Rispetto ad essa una unità minore e il mantenimento della dimensione di servizio della polis e delle comunità sociali all’individuo consegue logicamente ed è condizione della stessa esistenza di una autentica comunità politica naturale[xlii].
Non vi è dubbio che le dinamiche storiche e i processi integrativi e dis-integrativi cui esse danno corso condizionano la percezione delle identità individuali e collettive e con esse la elaborazione di dottrine politiche diverse che si radicano come detto in discorsi sull’uomo e dunque modelli antropologici differenti. Lo Stato moderno nasce in tal senso a compimento di un movimento centripeto determinato da istanze pacificatrici e neutralizzanti dei conflitti civili e religiosi interni. A seguito della pace di Westfalia, la versione politica della sovranità, elaborata da Hobbes, si astrae dalla determinata congiuntura storico-politica e tuttavia muove da un modello antropologico che certo si lega alla diffusa conflittualità dei tempi in cui è concepito: homo homini lupus.
L’identità europea e la crisi della coscienza europea. C’è dunque un’altra identità che l’Europa ha affermato e che occorre richiamare all’interno di una riflessione sulla cittadinanza, che proprio in tale contesto si manifesta come una delle parole chiave per la comprensione del pensiero moderno. La critica ad Aristotele è chiara ed esplicita e riguarda anzitutto l’antropologia di riferimento, quale presupposto della teoria politica. L’uomo è un animale più pronto al conflitto che non alla socialità (e alla politicità) per cui le comunità politiche possono nascere solo a seguito di un contratto: insomma lo Stato non è per natura ma per arte; la naturale politicità sarebbe peraltro contraddetta anche dal fatto che le comunità politiche traggono origine (solo) ad un certo punto della storia[xliii]. Prescindendo qui da approfondimenti che pure meriterebbero grande attenzione[xliv], risulta evidente che la teoria della sovranità assoluta declina il rapporto tra autorità e libertà sacrificando la seconda alla prima, sino ad invertire la polarità del rapporto tra pubblico e privato e a delimitare il campo di esercizio delle libertà medesime al più nella sfera privata[xlv].
La scomparsa dello zoon politikon, insomma, si accompagna alla costruzione di nuovi confini della politica, e l’ordine alla cui base si pone il contratto stipulato con il Leviatano – assai significativamente rappresentato come mostro a cento teste a simboleggiare un pluralismo sociale che mette capo ad un potere diffuso e in qualche modo già spartito – è un ordine non più naturale ma costruito sulla volontà del sovrano, di fronte alla quale il civis, cittadino, è paradossalmente suddito del suo stesso prodotto. Alla luce di tale novità, risulta rivoluzionata anche la logica da cui muove ogni teoria della sussidiarietà, secondo cui ogni potere è legittimo se costruito ed in quanto sia necessario sussidio all’uomo-cittadino. E’ questo l’ambito in cui si costruiscono le libertà dei moderni come libertà dallo Stato: la politica corrompe il carattere borghese e il tradizionale scopo dell’eudaimonia, la felicità, si trasforma nel diritto personale dell’uomo ad aspirare alla felicità segnando la migrazione nella sfera individuale e soggettiva del privato[xlvi]. Questo peraltro non toglie i meriti e le esigenze storiche della costruzione dello stato moderno come risposta alle istanze di realizzazione di un nuovo Ordine europeo attraverso l’attribuzione allo stesso di alcuni caratteri essenziali, vale a dire impersonalità, originarietà e assoluta indipendenza, in quanto superiorem non recognoscens, sulla base territoriale che descrive i confini e l’appartenenza ad una comunità ordinata di stati, ciascuno parimenti dotato di sovranità esclusiva.
E’ nel nuovo contesto segnato dall’emergere dello stato assoluto che si sviluppano le altre, almeno storicamente meno profonde, radici, che costituiscono altrettante matrici della riabilitazione della sussidiarietà nell’ambito della politica europea, la liberale e la federalista[xlvii], e con essa della stessa cittadinanza.
Elaborate tuttavia all’interno del nuovo modello antropologico-politico di riferimento nel quale si inscrive la teoria della sovranità, esse corrono il pericolo di rimanerne, per così dire, condizionate “geneticamente”[xlviii]. Sicché la loro azione è comunque quella di rivendicare all’individuo spazi che il nuovo, artificiale, ordine gli ha sottratto nel diverso statuto antropologico di suddito che gli ha assegnato. Questo è particolarmente evidente per le prime formulazioni teoriche del pensiero liberale, si pensi anzitutto a Locke e Smith, che “spoliticizzano” l’orizzonte della libertà, annettendolo alla sfera privata (per l’appunto priva della politica, del publicum) e, di conseguenza, riducono la libertà a libertà negativa dallo Stato, sancendo corrispondentemente il divieto di intervento dello Stato in quell’ambito. A tale declinazione politica, si lega, come è noto, quella economica, giacché l’economia è la sfera legata alla amministrazione della casa e, dunque, appartiene a quella intimità, propria per l’appunto della sfera domestica, nella quale si realizza la libertà dell’uomo che rivendica la medesima declinazione negativa di libertà dallo Stato.
Quindi proprio l’orizzonte nel quale si collocano fa luce sulle ragioni del forte individualismo che si accompagna a tali formulazioni, sicché la funzione regolatrice dei rapporti sociali assegnata al mercato può essere svolta solo all’interno di una società di individui e in contrasto con il naturale corporativismo di tutte le comunità sociali, che rappresentano soggettività meramente derivate e secondarie, e avrebbero inevitabilmente finito per ostacolarne il corretto funzionamento[xlix]. Ed è lungo questa direttrice che prende corpo lo spirito borghese, che per l’appunto manifesta un estraneamento dalla politica, della quale giunge a denunciare il tratto di corruttore del proprio carattere, smarrendo così insieme all’originario senso della libertà anche quello di una Politica che non conosce fratture tra l’uomo e il cittadino.
In questo senso, proprio l’Europa di Lisbona apre ad una forma di riabilitazione della politica ed insieme della categoria concettuale della cittadinanza attraverso il principio di sussidiarietà, nella sua nuova declinazione, finalmente anche espressamente orizzontale[l]. Questa dovrebbe rappresentare, per così dire, l’atto di sdoganamento della società civile, la riapertura di quei canali in cui è stata costretta la contrapposizione tra stato e società civile, nata e rivendicata in nome della concezione moderna della libertà, dapprima nella forma dell’astensione dello stato dall’intervento e poi, in nome dei principi dello stato sociale, anche in quella di un intervento limitato tuttavia a superare gli ostacoli all’esercizio delle proprie libertà. Riattivando la dialettica tra dovere e diritti, e la priorità logica e cronologica del primo, dialettica propria dell’originario senso del subsidium che traduce l’insufficienza dell’uomo a se stesso[li], la naturale politicità dell’uomo e il suo irrinunciabile desiderio di cittadinanza…
III – Mondializzazione e sovranità: globalizzazione dei diritti e cittadinanza europea
In questa duplicità di storie – che è storia della crisi della coscienza europea e della domanda identitaria individuale e collettiva sottesa alle dinamiche, tanto dis-integrative quanto integrative, che attraversano il XX secolo sino ad affacciarsi sul primo decennio del terzo millennio – si inserisce, caratterizzandola e condizionandone sostanzialmente il corso ulteriore, la contingenza storica della globalizzazione o meglio mondializzazione. Questa incide profondamente sull’orizzonte di senso della politica, del diritto, dell’economia e dello stesso discorso sull’uomo tout court, in particolare condizionando l’orizzonte di senso della cittadinanza, quale istituto che da un lato determina e consolida l’appartenenza ad una determinata comunità politica ma dall’altro corrispondentemente sancisce l’esclusione. La teoria della sovranità, nella declinazione che caratterizza la costituzione degli stati-nazione, aveva in particolare inteso risolvere il problema principalmente attraverso l’individuazione di due criteri giuridici che definiscono l’identità del cittadino in relazione al diritto secondo il sangue e secondo la terra[lii]. Così l’altro, lo straniero, era «semplicemente» colui che non ha la medesima nazionalità: in tale prospettiva tanto la decisione sovrana sull’unità politica quanto la norma fondamentale dell’ordinamento giuridico segnano la contiguità di diritto e politica, che caratterizza in definitiva strutturalmente tanto le teorie di diritto pubblico decisioniste à la Schmitt che quelle figlie di una dottrina pura del diritto à la Merkl e à la Kelsen, e garantiscono in forme diverse l’unità interna dello stato…[liii] ma a costo di produrre due ferite assai profonde nell’identità giuridica, politica, culturale e antropologica dell’uomo europeo[liv]: il suddito, di cui si è già detto, e lo straniero, che però è di fatto anche l’apolide[lv] e l’appartenente a minoranze, primi cugini secondo la definizione di S. Lawford Childs richiamata da Hannah Arendt[lvi], ed allora vede negata la sua stessa umanità, è escluso dalla comunità umana[lvii].
La mondializzazione interviene però ad offrire un nuovo incontro epocale con l’altro che si realizza con la caduta dei Muri. Questa pone nuovamente all’Europa un problema di identità: sembrerebbe che, dal punto di vista geopolitico, si possa costruire un ordine ma la globalizzazione ha già intaccato l’ordine, sta già attaccando le radici della sovranità attraverso l’erosione di quelle che sono le sue categorie di riferimento nella teoria dello stato moderna: popolo, territorio ed appunto governo. L’attacco più radicale è al territorio, ma poi tale attacco incide in definitiva anche sul rapporto che definisce – proprio attraverso l’istituto della cittadinanza – le identità individuali e collettive nazionali[lviii] E’ un processo che porta ad avvertire un senso di prossimità planetaria e si realizza anzitutto per “grazia” delle nuove evoluzioni della tecnica[lix], che conferiscono alla techne un ruolo sempre più importante nella condizione umana e modificativo della stessa natura dell’agire umano tout court[lx], particolarmente nella forma delle tecnologie informatiche. Queste accrescono anzitutto la mobilità di tutte le unità economiche e così determinano una progressiva interdipendenza economica, che si avverte tanto a livello regionale che globale e si accentua proprio in relazione alla velocità con cui possono essere realizzate le operazioni. Rispetto ad una tale velocità operativa peraltro ci sarebbe da chiedersi quali determinazioni legislative sovrane – e di conseguenza anche quale partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà dello stato come momento di espressione delle identità democratiche collettive e delle dinamiche integrative di una certa singolare comunità politica nazionale, per quanto schmittianamente in forma di provvedimenti motorizzati[lxi] – possano essere al pari di veloci colpi di click con i mouse dei propri computer collegati virtualmente ai mercati di tutto il pianeta.[lxii]
Non basta. La mondializzazione non è solo globalizzazione dei mercati; essa riguarda anche la comunicazione, la cultura, l’ideologia liberale, la politica[lxiii], e all’insegna del nuovo politeismo determina interdipendenze in ognuno di questi settori; interdipendenze che riscrivono la geografia del potere statuale[lxiv] e ne fanno l’espressione di una serie di accordi, limitazioni più o meno concordate, partecipazioni a diversi organismi internazionali, ma anche nazionali e regionali, che descrivono la costellazione postnazionale e la sovranità postmoderna[lxv].
Da questo punto di vista non vi è dubbio, infatti, che la crisi della sovranità, anzitutto come crisi della fiscalità (per l’impossibilità di localizzare i grandi capitali sovranazionali con la loro rete delocalizzata, che fa sistema in frode ad ogni etica contributiva capitalista) mina profondamente lo Stato sociale europeo. Altrettanto sicuro è che nessuno Stato, pur se egemone a livello geopolitico, può progettare e realizzare sino in fondo una politica economica che influenzi a piacimento le dinamiche sistemiche e a rete della globalizzazione. E’ inoltre certo – e ciò incide profondamente sull’orizzonte di senso dell’istituto della cittadinanza, quale sottile filo rosso che definisce il confine tra l’affermazione della appartenenza e la esclusione dell’estraneità – che la stessa contrapposizione amico-nemico perde pregnanza nella globale interdipendenza delle sovranità depotenziate postmoderne. E’ vero, ancora, che le stesse identità nazionali sono progressivamente de-strutturate dalla diffusione di valori e culture transnazionali, che sembrano quasi “assecondare” le “velocità aggregative e disaggregative” dei pixel; è vero pure e procede nella medesima direzione, costituendo un altro evidente segno della riconfigurazione della sovranità in divenire all’interno del nuovo laboratorio europeo, che la stessa funzione del battere moneta, prerogativa essenziale della sovranità, è stata sottratta proprio nel caso dei Paesi interessati dal processo di integrazione europea alle banche nazionali ed affidata alla banca centrale europea. Vero è insomma, che anche la sovranità assume forme reticolari, e a geometrie variabili secondo le rapide dinamiche della mondializzazione. Vero è inoltre che essa si rimodula, acquista nuove identità, proprio nelle cooperazioni tra stati e nelle aperture a soggettività nuove, in forma di unioni, organismi internazionali e quant’altro, oltre che nell’altra apertura – verso l’interno – al pluralismo istituzionale, che incontra le sensibilità e gli interessi nella loro dimensione locale segnalando le nuove prospettive entro cui si inscrive (al di là del retaggio simbolico della sovranità) la declinazione postmoderna dell’appartenenza, alle comunità politiche particolari e poi a quelle sussidiarie e vieppiù generali. O in altre parole vero è che il (non) sovrano non decide da solo, perché non è nelle condizioni di farlo, che l’unità politica non si conclude entro lo stato e che la sovranità è (esiste) solo in quanto sia inclusiva[lxvi].
Allora, la crisi della coscienza europea – che è crisi della localizzazione dell’ordine, e anzitutto della unitarietà di un ordine internazionale fondato sui criteri di Westfalia, su sovranità nazionali che tutte parimenti non conoscono o non dovrebbero conoscere superiore – è una crisi che, nonostante ogni perdurante tentativo in contrario, anche all’interno del laboratorio politico e giuridico dell’Unione europea, probabilmente non si può affrontare con gli (i soli) strumenti che abbiamo, con le categorie fondanti dello jus publicum europaeum.
Il vero punto di svolta è allora, tornando alle osservazioni iniziali, il senso della condizione umana, l’identità umana quale intaccata e messa in crisi dai fenomeni dell’accelerazione di velocità delle nuove tecnologie, dall’annullamento (tendenziale se non infinito) della dimensione spaziale e di quella territoriale – e basti pensare ancora alle comunicazioni e alle transazioni economiche e finanziarie nelle quali pure è evidente il denominatore comune assunto dalla techne in questo processo postmoderno di convergenza tra accelerazione ed annullamento delle dimensioni spaziale e temporale, che ancora una volta muove dai campi dell’economia e della finanza e condiziona significativamente la definizione del senso dell’agire umano in tutti gli ambiti delle scienze pratiche, particolarmente della politica e del diritto nella loro problematica relazione con l’economia e con l’etica[lxvii].
Penso alla cosiddetta globalizzazione del diritto, che pure ho richiamato significativamente nel titolo della relazione. La vera globalizzazione del diritto (perciò cosa al momento ben diversa dal pieno riconoscimento a livello sostanziale del fondamentale diritto umano ad avere diritti) è in realtà, se non solo certo principalmente, una estensione alle nuove forme e velocità in cui la postmodernità ha reso possibile concludere le transazioni economiche (in particolare quelle finanziarie), del diritto economico internazionale. Perché certo quella convergenza tra velocità e annullamento delle distanze aprono ulteriormente le frontiere nazionali dell’economia, verso le quali il diritto economico internazionale era peraltro da sempre stato insofferente. E ancora una volta il diritto economico internazionale mostra di essere assai più elastico e capace di gestire i canali che vengono creati dalle nuove tecnologie e di muoversi agilmente attraverso essi. Non è pertanto un caso che, dal punto di vista della globalizzazione dei diritti o del diritto, il versante in cui questa può ritenersi essere già cominciata, ed essere pure rapidamente giunta a buon punto, è proprio quello della cosiddetta lex merchatoria[lxviii]. Ed è un diritto che, assai significativamente, vede per così dire travolta la dimensione della validità come propria dimensione costitutiva e si fonda, anzitutto, prevalentemente su quella dell’effettività. Ma qui evidentemente sono gli interessi dei grandi “mercanti” internazionali a farla da padroni…
Le nuove forme di comunicazione offerte dalla tecnologia informatica sembrano a loro volta potenzialmente capaci di de-strutturare progressivamente le identità consolidate e porre la persona – nella sua quotidiana esperienza che è formazione dinamica di identità – al centro di un processo di con-fusione di tratti e valori inter-culturali la cui provenienza e il cui radicamento non è più il (un solo e definito) territorio ma il globo nella sua (fisica e metaforica) sfericità[lxix]. In questo contesto, la riflessione filosofico-giuridica sul desiderio di cittadinanza, e con essa sulla ri-abilitazione della categoria concettuale del cittadino quale si inscrive in particolare all’interno della riflessione sulla postmodernità e all’interno del processo di integrazione europea con cui l’Europa affronta la nuova crisi della propria coscienza, costituisce indirettamente una via per porsi un interrogativo di portata più ampia, sul senso della politica all’interno della modernità. Domanda sulla cui problematicità siamo stati avvertiti da Hannah Arendt: d’accordo che al quesito se la politica abbia ancora un senso si può rispondere semplicemente che il senso della politica è la libertà, ma ciò non soddisfa l’interrogativo più radicale, legato appunto agli sviluppi della modernità: la politica, e insieme ad essa la nostra condizione umana di cittadini, ha ancora un senso?
Ora è vero che l’istituto della cittadinanza costituisce solo un tassello del politico, ma è altrettanto vero che esso appartiene, per così dire, alla sua linea mediana, avendone tra l’altro in comune il baricentro, costituito appunto dal nesso necessità-libertà e dal suo rapporto incrociato con il binomio pubblico-privato quale si configura nello svolgimento storico che dalla filosofia politica classica conduce sino a quella moderna.
La nostra identità, e l’identità singolare di ciascuno, è destinata in tale direzione a divenire frutto di un fluire di umanità diverse, di storie e culture che – si pensi ancora e non solo metaforicamente ai veloci colpi di click che non conoscono confini territoriali – si offrono alla percezione ed elaborazione della individualità di ciascuno verso nuove dinamiche integrative collettive post-territoriali[lxx]. In questo senso, assai importante è altresì prendere atto che le dinamiche identitarie sono chiamate a muovere dal riconoscimento del proprio fondamento nel rapporto esistenziale io-altro, all’interno di processi che accostano gli uni, individui e comunità politiche, agli altri, attraverso una logica dinamica che mi sembra si possa con qualche efficacia definire dell’inter, una (dia)logica che si specifica per il rifiuto di ogni sclerotizzazione radicale di identità consolidate e affida al dialogo inter-culturale, inter-religioso, inter-nazionale il processo di progressiva acquisizione di una sempre meglio definita identità umana. Questo significa, richiede, che le culture in gioco devono essere caratterizzate da una identità abbastanza forte per sfuggire al pericolo dell’assimilazione della più debole da parte di quella dominante[lxxi] in un ormai anacronistico conflitto di civiltà. Che all’interno della politica dell’Occidente, come ha da ultimo dimostrato la politica della precedente amministrazione americana di Geroge W. Bush (che qualche proselito ha fatto pure da noi nel Vecchio continente) è peraltro la tentazione riduzionista più forte di un’Europa che ha assimilato già l’altro nella prima mondializzazione, quella del 1492, pagando un prezzo altissimo- tanto nel numero impressionante di vittime, prossimo agli ottanta milioni di esseri umani, che nell’impoverimento del proprio patrimonio di diversità antropologiche[lxxii]. E che non a caso muove formalmente dalla ricerca interna di Unità nella diversità verso un compiuto processo di integrazione dei popoli europei, e che sperimenta sostanzialmente tutte le difficoltà di una dinamica integrativa nella quale sono chiamate a convergere le diversità nazionali, pure nel rispetto reciproco segnato dal riconoscimento del fondamentale principio di sussidiarietà.
Se le dinamiche dis-integrative e i processi identitari collettivi (in qualche misura anche ri-aggregativi delle identità frammentate) che si accompagnano alla costruzione dei Muri fra Est e Ovest negli anni successivi alla fine del conflitto mondiale e all’inizio della guerra fredda, non possono che muovere dall’economia e accantonare l’idea – pure presente nei Padri fondatori delle Comunità – di una Unione politica in un’Europa all’epoca divisa in blocchi, è la caduta di quei muri (pure già erosi insieme alle sovranità statali nazionali dalle dinamiche globali dell’economia) a dare il là alla ri-costituzione di un processo identitario europeo attraverso dinamiche di progressiva integrazione delle realtà sovrane separate dalle vicende della Storia dalla comune madre Europa. L’ultimo interrogativo del nostro studio si colloca all’interno dei movimenti centripeti suddetti, realizzati attraverso una serie di successivi allargamenti che quali a loro volta hanno richiesto intense e delicate fasi di calibratura tra i patrimoni costituzionali formali e sostanziali degli ordinamenti giuridici e politici degli stati candidati all’adesione e il patrimonio condiviso dell’Unione[lxxiii] – quale determinato riscoprendo nella evoluzione nomodinamica dell’ordinamento europeo le radici comuni dell’Europa.
Si tratta di affrontare il tema del senso di una strategia di ri-abilitazione della Politica e del cittadino nella attuale fase di mondializzazione postmoderna che si propone di giungere a coniugare istanze globali e sensibilità locali. In altre parole, bisogna sinteticamente chiedersi: a che punto è la crisi della coscienza europea e quali possibilità l’istituzione della cittadinanza europea apre per fronteggiare la crisi di Ordine che caratterizza la nostra epoca e per consentire una più ampia apertura alla globalizzazione dei diritti, che muova dal coniugare il diritto alla identità civica con modelli (di ordinamenti giuridici sovrani) inclusivi di cittadinanze? O, in altre parole, per consentire una globalizzazione dei diritti che permetta di dare senso all’istituto della cittadinanza nei giorni in cui il sovrano, se pure non è stato decapitato, sembra assente o è, anch’egli, globale?
In questa cornice, nel processo di politicizzazione dell’Unione economica avviato a Maastricht, la decisione dell’Europa è come detto quella di istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei Paesi dell’Unione e con ciò stesso portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. In tale modo, dunque, i cittadini sono finalmente riconosciuti in concreto, almeno formalmente, come il vero fondamento di ciascuna e tutte le comunità politiche dell’Unione, in conformità al principio di sussidiarietà.
All’interno di tali dinamiche integrative, proprio dentro il contesto sin qui descritto e caratterizzato dal fenomeno della mondializzazione e con esso dalla crisi delle sovranità nazionali e delle stesse categorie concettuali fondamentali del diritto pubblico europeo si sviluppano interrogativi di difficile soluzione sul piano teorico e tecnico-giuridico.
Anzitutto: è possibile ancora, kelsenianamente, rimettere alla delimitazione dello spazio in cui l’ordinamento giuridico ha validità, secondo le indicazioni prescrittive stabilite a sua volta dall’ordinamento internazionale, la definizione dell’unità dello stato e particolarmente dell’identità collettiva del popolo?
La scelta dell’ordinamento europeo, come noto e come logicamente giustificato per la ampia caratterizzazione intergovernativa e nazionale della procedura di produzione del diritto, procede in una direzione diversa, in un ambiguo compromesso dinamico tra sovranità dell’ordinamento europeo, progressivamente definita di fatto e attraverso una coraggiosa opera giurisprudenziale, e rispetto delle sovranità nazionali, quale affidato, appunto, alla declinazione del principio di sussidiarietà da Maastricht in avanti. Sicché è cittadino europeo, e perciò titolare dei diritti a tale status connessi ma anche dei doveri, anzitutto di partecipazione attiva, dei quali il cittadino è titolare (lo si ribadisce richiamando quanto già detto in tema di sussidiarietà e presumendo che a quella originaria concezione intenda richiamarsi infine l’Europa in cerca delle sue radici, tanto classiche che cristiane), chiunque sia cittadino di uno degli stati membri dell’Unione europea[lxxiv]. L’unità personale dell’ordinamento europeo che definisce l’appartenenza alla comunità europea è così unità nella diversità e pertanto risulta affidata alle determinazioni sovrane di ciascun ordinamento nazionale degli stati membri dell’Unione e non ad una distinta definizione sintetica che definisca una nozione autonoma. Tuttavia, proprio perché di unità deve trattarsi, se pure nella diversità, l’Unione europea ha interesse a sovrintendere alle logiche che sul piano dell’integrazione politica nazionale conducono a decisioni restrittive o di apertura in ordine alla concessione della cittadinanza[lxxv], come pure rileva la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione (1º maggio 2001 – 30 aprile 2004) [lxxvi].
Nello stesso documento, peraltro, in conformità a quanto detto sulla strategia ri-abilitativa del cittadino all’interno del disegno politico e culturale europeo, si sottolinea che proprio in relazione alle vicende che hanno interessato il processo costituente europeo (con la bocciatura del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa) sarebbe un segno importante far ripartire il dibattito sul futuro dell’Unione proprio da una misura concreta e significativa quale quella sulla cittadinanza, come simbolo della volontà di valorizzare l’esistenza di una comunità politica e territoriale per rafforzare il contratto di fiducia tra l’Unione e i suoi popoli.
Alcune riflessioni sul tema della cittadinanza europea a margine del trattato di Lisbona si impongono perciò prima di prospettare delle brevi conclusioni.
Desidero anzitutto specificare la ragione della mia scelta, di lasciare appunto ai margini della trattazione l’ultimo atto del processo di integrazione europea, nonostante esso sia chiamato a rimettere in moto il medesimo dopo il traumatico stop al processo di costituzionalizzazione formale dell’Unione. Come ho già avuto modo di sottolineare altrove[lxxvii], l’art. 6 del Trattato di Lisbona, prevedendo alternativamente: o una procedura articolata nella ratifica degli Stati membri e nel successivo ingresso in vigore alla data del 1 gennaio 2009 o un ingresso successivo per il primo giorno del mese seguente il deposito dell’ultimo strumento di ratifica, è risultato un maturo frutto della prudenza, saggiamente ispirata dalle incertezze dell’attuale fase del processo integrativo e che ha finito per confermare il proverbiale detto…
Proprio per questo, non essendo esso ancora vigente sarebbe stato impossibile sviluppare un discorso sul diritto positivo; inoltre, e comunque, ad una pur sommaria lettura del testo del trattato, risulta chiaro che non vi sono sostanziali modifiche in ordine al tema della cittadinanza europea.
C’è però un dato che può essere interessante, a partire dal quale cercherò di prospettare un orizzonte di riflessione e alcune brevi conclusioni. Il dato che mi pare rilevante nell’economia dello studio che si sta compiendo è quello della redistribuzione dei seggi del Parlamento europeo, resasi necessaria in conseguenza del recente allargamento a 27 (stati membri) dell’Unione. Come noto, l’Europa ha in tale occasione deciso di mutare la base di riferimento assunta per la determinazione della nuova composizione del Parlamento europeo: sicché essa sarebbe dovuta essere sin dall’ingresso in vigore del trattato di Lisbona quella dei cittadini e non più della popolazione. Tale modifica avrebbe evidentemente determinato uno svantaggio per quei paesi, tra cui l’Italia, che sono stati sino ad oggi più restii rispetto ad altri alla naturalizzazione[lxxviii].
Per quanto, ad ogni modo, il mancato ingresso del trattato di Lisbona entro la data delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbia comportato che la distribuzione dei seggi per il periodo 2009-2014 avverrà sulla base delle disposizioni del trattato di Nizza, il tema è comunque di estremo interesse perché la soluzione scelta nella capitale portoghese sembrava essere concretamente il segno della volontà di intraprendere un cammino almeno parzialmente diverso rispetto a quello che concretamente si sarebbe intrapreso di lì a poco in altro ambito quale risposta europea alla crisi dell’Ordine e della sovranità nazionale degli stati in particolare, nel contesto della mondializzazione postmoderna tra fine del secondo e terzo millennio. Intendo fare riferimento al sensibile cambio di rotta di alcuni governi nazionali europei a seguito della recente crisi economico-finanziaria globale: la posizione tedesca appare esemplificativamente emblematica in questo senso di un arretramento della prassi rispetto al dato teorico di un avanzamento «per allargamento» del processo di integrazione europea, che includendo un cospicuo numero di nazionalità sovrane dell’est sembrava in grado potenzialmente di promuovere anche una rimodulazione del senso di ogni appartenenza individuale e collettiva alla comunità politica, oltre i retaggi della moderna sovranità nazionale. Un tale arretramento della prassi si è manifestato concretamente con una chiusura rispetto alle stesse naturali dinamiche sovranazionali dell’economia e della finanza e a protezione delle identità collettive sovrane del «mondo» produttivo nazionale…
Appare interessante, in tale senso, e sembra però esemplarmente significativo delle concrete difficoltà di coniugare dibattito europeo e contesti nazionali (con le loro remore alla cessione formale di posizioni sovrane già però sostanzialmente erose ampiamente) anche il tema delle radici cristiane, oggetto di tante rivendicazioni da parte di ampi settori del dibattito politico italiano in sede di lavori per il trattato che adotta una Costituzione – e poi di tanti rammarichi espressi criticamente dopo il mancato recepimento formale delle stesse nel testo licenziato dalla Convenzione. Rivendicazioni e rammarichi che però poi si fa fatica a coniugare con l’uso di alcune espressioni che quelle radici rinnegano e che esprimono chiusura all’accoglienza e integrazione tra le diverse sponde del Mediterraneo (in cui pure oggi opera l’Unione euromediterranea), espressioni che pure alcuni tra i massimi esponenti politici dell’attuale compagine governativa hanno significativamente pronunciato a pochi giorni dal rinnovo del Parlamento europeo e proprio nel corso e a caratterizzare la relativa campagna elettorale… tra dottor Jackyl e mr. Hyde…[lxxix]
Su questi tema, insomma, il vero problema di fondo è ancora una volta quello di ri-abilitare una unità delle scienze pratiche che ritrovi tanto nella morale individuale che nell’etica pubblica del cittadino (e non solo della classe politica, per intendersi) il denominatore comune in grado di orientare normativamente l’agire umano, altrimenti essendo esposte tanto l’economia che il diritto e la politica alla deriva di un individualismo cieco, incapace di riconoscere nel bene comune il necessario, indispensabile fondamento per una autentica ricerca della felicità individuale, tanto più proprio nell’era in cui ogni cosa che succede in una parte qualsiasi del globo provoca ripercussioni in altre non prevedibili parti del pianeta. E la politica, e con essa quel simulacro del diritto che è il dato positivo e dunque l’espressione di qualunque maggioranza politica, senza controllo alcuno della razionalità e misura dei contenuti di cui è espressione, a richiamare ancora l’espressione platonica nella sua linea di contrapposizione a quella di Schmitt[lxxx], diventa solo il campo in cui ci si contende il dominio sperimentando tecniche sempre più raffinate di captazione del consenso[lxxxi]. In tale contesto, sembra fare discutere assai meno in linea di principio la recente decisione della Spagna di naturalizzare molti immigrati senza consultare i suoi partner[lxxxii], pure oggetto di grande e comprensibile attenzione proprio per il significato politico e strategico assunto da tale decisione sul piano dell’integrazione dell’ordinamento pubblico europeo, sempre in relazione alla nuova definizione numerica della rappresentanza nazionale definita a Lisbona proprio in riferimento alla cittadinanza, secondo quanto si diceva[lxxxiii].
Sembra in definitiva, insomma, che un tale operare concreto finisca più volte per allontanarsi dalle alte aspirazioni teoriche e di ri-abilitazione della Politica e del cittadino, proprio nella sua continuità con l’uomo, cui ha inteso legarsi geneticamente, almeno nel pensiero dei suoi Padri fondatori, il progetto politico europeo. Sicché non meraviglia in tale contesto, che ancora una volta suggerisce di associare metaforicamente la tessitura della coscienza europea a quella della tela di Penelope (poi sistematicamente disfatta ogni notte per il conseguimento del più autentico e sotterraneo fine a servizio del quale pure è in definitiva realizzata) persino la polemica tutta italiana sui comunitari romeni, tanto per rimanere ancorati ai fatti. A proposito dei quali assai difficilmente si ricordano nel dibattito italiano sui significati e orizzonti teorici e pratici del rapporto tra cittadinanza nazionale, cittadinanza europea, fenomeno delle migrazioni tra le sponde del Mediterraneo e identità individuali e collettive (anche in relazione al fenomeno dell’apolidia che tanto si è voluto contrastare dopo i drammatici esperimenti del secolo scorso[lxxxiv]), le vicende degli anni novanta, quando molti cittadini romeni rinunciavano alla cittadinanza per potere godere in Germania dello status di apolidi, assai più conveniente per l’adesione della Germania medesima alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto degli apolidi e la conseguente limitazione della possibilità di adottare provvedimenti di espulsione in assenza di ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Quanto meno romantica, vien da pensare, può apparire l’appartenenza ad una comunità e come è duro calle lo scendere e ‘ l salir per l’altrui scale a chi è costretto a cercare lo pane altrui…[lxxxv]
D’altra parte, le istituzioni europee, e in particolare proprio il Parlamento, non avevano mancato di invitare gli Stati a riflettere sulla possibilità di stabilire un legame più forte tra la residenza legale per un certo periodo di tempo e l’ottenimento della cittadinanza nazionale, e con ciò stesso della cittadinanza europea, prospettando dunque un percorso virtuoso per l’integrazione europea e per l’autentica formazione di un comune demos dei popoli europei[lxxxvi].
E, a questo riguardo, proprio l’istituzione rappresentativa dei popoli europei ha segnalato alla fine del 2005 l’utilità dell’apertura di un dibattito che permetta di definire e precisare il progetto relativo alla cittadinanza dell’Unione in considerazione dei notevoli progressi compiuti dall’Unione europea successivamente al trattato di Maastricht. Poco tuttavia è stato fatto tra Roma e Lisbona, e ad oggi, nonostante il forum europeo di Parigi avesse rilanciato l’idea, già espressa dapprima sotto forma di invito agli Stati membri a riflettere sulla possibilità di stabilire un legame più forte tra la residenza legale permanente durante un periodo di tempo ragionevole e l’ottenimento della cittadinanza nazionale e di conseguenza di quella europea e poi (al punto 28 della medesima proposta di risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2005 sulla quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione) di concedere la cittadinanza europea in funzione della residenza, considerato peraltro che taluni diritti connessi con la cittadinanza dell’Unione sono già conferiti sulla base della residenza[lxxxvii], quale obiettivo finale del processo dinamico che realizzi un’autentica e piena integrazione politica dei popoli europei. Rispetto alla quale, peraltro, quella proposta di risoluzione esprimeva anche l’auspicio di uniformare le procedure elettorali e prevedere l’elezione di una parte dei deputati su liste europee transnazionali presentate dai partiti politici europei già per le elezioni del 2009…
Quale dunque il senso della cittadinanza europea, quale declinazione della cittadinanza europea può davvero consentire di riabilitare la Politica e tornare a riflettere sull’identità dell’uomo europeo nella sua continuità con il cittadino?
Ebbene, l’orizzonte di senso della cittadinanza che affronta le difficoltà della condizione umana postmoderna e della de-strutturazione delle identità collettive ed individuali non è soltanto (e non può essere più soltanto) una identità storica fondata su delle radici, per quanto profonde, messe intimamente in crisi appunto dai fenomeni della mondializzazione, che, ripeto, varcano i confini meramente informatici – Habermas dice, e certo ha un senso oltre l’espressione meramente contingente, che oggi è sovrano chi è più veloce; la sovranità non è più territoriale, si misura sulla velocità. Ma questa velocità diventa evidentemente un fattore culturale. Allora, il ruolo dell’Europa in questo senso, significativamente – perché non bisogna dimenticare che l’Europa, come pure ho rilevato nel corso del primo paragrafo, entra in una crisi particolarmente significativa della propria coscienza europea con la Grande guerra civile, con le due guerre mondiali: dunque in realtà l’89, il nuovo, nostro ’89, è un’occasione, la mondializzazione è una grande occasione per risolvere il problema identitario – è quello di proporre non tanto una costituzionalizzazione ma un nuovo costituzionalismo con-forme alla (con le forme della) propria identità. E questo nuovo costituzionalismo a mio parere dovrebbe appunto muovere proprio da qui: dovrebbe muovere dall’assunzione della cittadinanza non soltanto come identità storica (dacché quella ripeto è ben radicata ma intimamente messa in crisi nell’età della mondializzazione postmoderna), ma anche come progetto. In questo sono d’accordo con quanto sostiene Archibugi[lxxxviii]: la cittadinanza statunitense può insegnarci qualcosa. E’ chiaro, non entro qui nello specifico della distinzione tra i criteri giuridici di assegnazione della cittadinanza (jus sanguinis e jus soli) e dunque appunto nel merito del valore dell’esperienza statunitense in questo senso[lxxxix]; però, evidentemente il dato che qui importa è che la cittadinanza possa diventare un progetto condiviso. Allora, se è un progetto condiviso, tu ed io siamo cittadini perché condividiamo un progetto.
Io credo in questo senso che la cittadinanza europea possa diventare un progetto condiviso, una identità comune, dove veramente ci sia Unità nella diversità… Sicché la proposta che l’identità europea è in grado di promuovere all’interno del dibattito sulla mondializzazione e sulla ricerca di un nuovo ordine dovrebbe in definitiva muovere dal riconoscimento tanto delle istanze globali che delle sensibilità locali e così costruire un diritto alla identità civica fondato sul principio di sussidiarietà e che per ciò stesso si traduce in virtuose dinamiche inclusive di ogni alterità. In questo senso, esso prende atto e promuove la armoniosa co-esistenza di appartenenze a comunità politiche diverse, su base nazionale infra statuale o sovranazionale (e ultra statuale), che, nella interdipendenza funzionale evidenziata dagli esiti della tecnica e dell’economia oltre che da ambiti della politica – penso esemplificativamente all’ambiente con i suoi problemi che superano certamente le dimensioni nazionali per assumere quelle macro regionali e globali, come accade esemplificativamente per il problema del patrimonio energetico mondiale o della tutela dell’ecosistema dal surriscaldamento globale – ritrovano il fondamento ontologico di ogni sussidiarietà e della stessa perciò naturale politicità dell’uomo, nella insufficienza a se stessi (posta già a fondamento del naturalismo etico-politico di Aristotele). Nel senso che esemplarmente ricordano, e mi sembra opportuno citarle proprio in seno ad un incontro di studi sull’area euromediterranea, i versi di un poeta persiano del XIII secolo, dunque originario di una terra nel cuore dell’Asia che unisce il mondo, la cultura e l’antropologia del Mediterraneo con quelle del subcontinente indiano, che ci permettono di richiamare metaforicamente proprio l’Europa delle quattro colonne che ho indicato come la base identitaria cui fare riferimento per fondare un nuovo Ordine autenticamente costruito sulle radici più profonde dell’Europa. Versi che forniscono molti e profondi spunti di riflessione sul senso dello spazio, del territorio, e sulla sua esclusività all’interno di identità individuali e collettive contrapposte che separano l’identità unitaria del genere umano con porte che possono rappresentare metaforicamente la comunicazione e l’accesso, tra identità individuali come tra identità collettive, ma che tuttavia sembrano destinate a rimanere sempre chiuse per l’insufficienza del medesimo (spazio) e che (così) producono solitudine e privazione; ma che in una visione ricomposta delle identità singolari e collettive, fra individualità ed alterità riconciliate nella ristrutturazione dell’Io[xc] portano a ri-trovare l’Unità dell’Uomo nella diversità dei popoli:
Un uomo venne alla porta della sua amata busso.
Una voce chiese: “chi è?” “sono io”, rispose.
Allora disse la voce: “qui non c’è spazio abbastanza per me e per te”.
E la porta rimase chiusa.
Dopo un anno di solitudine e privazione l’uomo tornò e bussò.
Dall’interno una voce chiese: “chi è?” “Sei tu” rispose l’uomo.
E la porta gli fu aperta”.[xci]
[i] Quanto alla dimensione più propriamente storica di tale domanda, tornano alla mente le parole con le quali P. HAZARD, La crisi della coscienza europea, Torino 1946, pagg. 481, osserva, nelle pagine conclusive della sua analisi sulla crisi europea che tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo avrebbe condotto sino alla rivoluzione francese: «Che cosa è l’Europa? Un accanimento di vicini che si combattono tra loro. Rivalità della Francia e dell’Inghilterra, della Francia e di casa d’Austria; guerra di successione di Spagna. Guerra generale, osservano i trattati di storia, i quali duran fatica a seguire sin nei particolari queste lotte confuse. Gli accordi conducono solo a brevi tregue, la pace non è più che una nostalgia, i popoli sono esausti e la guerra continua». Non vi è dubbio infatti che la Grande guerra civile europea dei Trenta anni, per così volere indicare le due guerre mondiali, confermi esemplarmente la perdurante attualità di quell’analisi anzitutto nella continuità delle rivalità franco-prussiana prima, risalente sino all’esperienza napoleonica e poi al Congresso di Vienna e ancora alle note vicende del telegramma di Eims e all’umiliazione francese ad opera della Prussia di Bismarck, e poi franco-tedesca; rivalità rinfocolata al termine della Grande guerra dal Trattato di pace di Versailles (luogo in certo qual modo simbolo della coscienza europea continentale e delle sue crisi, tra monarchia, Rivoluzione e, per l’appunto conflitti del XIX e XX secolo), che imponeva condizioni proibitive alla Germania addossandole per intero la responsabilità del conflitto e avrebbe rappresentato per ciò stesso una delle principali cause della seconda Guerra mondiale. E la conseguente crisi di identità del Vecchio continente, prodotta da quella Guerra civile condotta significativamente quasi esclusivamente sul proprio territorio, è insieme perdita della prima indiscussa supremazia mondiale; sicché le dinamiche integrative e i processi identitari collettivi che si riattivano nel decennio successivo alla fine del conflitto, e all’interno di un’Europa divisa in blocchi, non possono che rinunciare ad una dimensione immediatamente politica e ripartire dall’economia: l’integrazione economica, con la istituzione delle Comunità europee muove per ciò, significativamente, da quegli interessi economici fondamentali che erano localizzati e concentrati nelle ambite regioni della Alsazia e della Lorena e particolarmente nei bacini della Ruhr e della Saar, causa tra le prime della contrapposizione di interessi e delle dinamiche dis-integrative delle volontà di potenza nazionali del Novecento.
[ii] E che possiamo individuare in forma chiaramente sintetica attraverso la riflessione di L. STRAUSS, Che cos’è la filosofia politica?, tr. it. Urbino 1977, il quale affronta e «attraversa» il tema del giusto e dell’ingiusto, del bene e del male, individuando nel pericolo della «reductio ad Hitlerum» la conseguenza estrema del disinteresse per il tema della società buona.
[iii] Protagonista di un tale rinnovato interesse per la filosofia pratica può considerarsi in particolare, come si accennava nel testo, l’area culturale di lingua tedesca nella quale ha avuto origine un vivace e complesso movimento denominato “Rehabilitierung der praktischen Philosophie”, secondo un’espressione apparsa per la prima volta in K. H. ILTING, Hegels Auseinandersetzung mit der aristoteliscen Politik, in Philosophisches Jahrbuch, LXXI (1963-64), pp. 38-58 e Hobbes und die prahtische philosophie der neuzeit, in Philosophisches Jahrbuch, LXXII (1964), pp. 84-102, poi ripresa in M. RIEDEL, Rehabilitierung der praktischen philosophie, 2 Bde., Freiburg i. Br., Rombach, 1972-74. Tra le opere che acutamente suggerirono le problematiche sulle quali la nuova scienza giuridico-politica era chiamata a porre la propria attenzione dando impulso alla nascita del movimento: H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, tr. it., Milano 1989; G. GADAMER., Verità e metodo, Milano 1983; W. HENNIS, Politik und praktischen philosophie. Eine studie zur rekonstruktion der politischen wissenschaft, Neuwied-Berlin 1963; E. VOEGELIN, Anamnesis. Teoria dello Stato e della politica, tr. it., Milano 1972. Nella letteratura nazionale, hanno inteso ricostruire quel dibattito: F. VOLPI, La rinascita della filosofia pratica in Germania, in Filosofia pratica e scienza politica, a cura di C. Pacchiani, Abano 1980; E. BERTI, La razionalità pratica tra scienza e filosofia, in Il valore. La filosofia pratica tra metafisica, scienza e politica, Padova 1984, pp. 11-26; F. VOLPI, La riabilitazione della filosofia pratica e il suo senso nella crisi della modernità, in IL MULINO a. XXXV, n. 6, novembre-dicembre 1986; F. VOLPI, Tra Aristotele e Kant: orizzonti, prospettive e limiti del dibattito sulla “riabilitazione della filosofia pratica”, in A. C. Viano (a cura di), Teorie etiche contemporanee, Torino 1990, pp. 128-48; G. FORNERO, La Riabilitazione della filosofia pratica in Germania e il dibattito fra “neoaristotelici” e “postkantiani”, in Storia della filosofia, Utet, Torino 1994, vol. IV: La filosofia contemporanea, pag. 199. Una lettura «comparatistica» delle componenti neoaristotelica e neokantiana del dibattito, in relazione alle diverse prospettive di analisi del diritto e della politica in seno alla post-modernità, si trova in A. C. AMATO MANGIAMELI, Tra etica dei “fini” ed etica dei “doveri”. Alcuni percorsi al di qua e al di là dell’Atlantico, in B. Montanari (a cura di), Spicchi di Novecento, cit., pagg. 309-348. Per un’analisi del ruolo che, nell’ambito del pensiero giuridico-politico contemporaneo, ha assunto in particolare la componente originaria del movimento, si consenta infine di rinviare al mio La riabilitazione della filosofia pratica tra moderno e postmoderno. Un possibile itinerario tra la tradizione della filosofia pratica e il neoaristotelismo di Hannah Arendt, in B. Montanari (a cura di), Spicchi di Novecento, cit., pagg. 349-388. In relazione con tali tematiche si evidenzia infine, rinviando doverosamente a più approfondite trattazioni, tutto quell’ambito problematico in cui sembrano in qualche modo convergere la concezione tipicamente moderna dell’agire umano come fare produttivo e il connesso ruolo assunto dalla economia in rapporto alle altre scienze pratiche, da un lato, e dall’altro i processi di mondializzazione con la comparsa di potenze socioeconomiche internazionali che rappresentano, nella loro qualità di gruppi di interesse, nuove potestates indirectae sottratte all’orbita della sovranità statale, e producono un progressivo scompaginamento della sovranità giuridico-politica tradizionale con le sue coordinate spaziali tradizionali – e della stessa capacità normativa delle singole costituzioni e degli ordinamenti giuridici nazionali – cui si affianca e sostituisce sempre più la lex merchatoria di cui si dirà meglio oltre nel testo.
[iv] Come è noto, peraltro, nella costruzione dell’aforisma 125 della Gaia Scienza di Nietzsche proprio l’Oltre-uomo è significativamente conseguenza della morte di dio e questa è emblematicamente annunciata in uno dei luoghi simbolici della globalizzazione, il mercato. Di più, il folle, nuovo Diogene che con la lampada è però in cerca non dell’uomo ma di Dio, ne annuncia infine la morte, assegna ai presenti e a sé la colpa del crimine e lega al compimento di quell’azione troppo grande per l’uomo il dovere di divenire dio egli stesso, al di là del bene e del male, divenendo egli stesso misura di ogni misura – esattamente al contrario di quanto suggerito da Platone per il quale appunto «non l’uomo, ma un dio deve essere la misura di tutte le cose». Insomma, lo Übermensch è creatore del nuovo ordine, artificio umano che contro ogni teologia politica monoteista preannuncia l’avvento di un nuovo politeismo, quello appunto del mercato… Invece nella rappresentazione classica lo Übermensch è altro dall’uomo, che per l’Ordine naturale è animale politico, e non vive nella polis. Ma proprio con l’uccisione di dio, della quale per ri-nascere a nuova vita è chiamato a rendersi protagonista, l’uomo rinnega e distrugge insieme la Città celeste, oltre che in definitiva, tanto nella dimensione della trascendenza che in quella della immanenza, ogni autentica sussidiarietà. Non pare dubbio, infatti, a tale proposito che l’Übermensch proprio in quanto Oltre-uomo non possa conoscere la dimensione ontologica della comunità quale si rinviene nel pensiero classico, che individua e descrive un ordine naturale fondato sul presupposto platonico che l’individuo, preso da sé, non è sufficiente a se stesso, giacché se l’uomo bastasse a se stesso non ci sarebbero le unità sociali, dalla famiglia allo stato; dimensione che trova nella “metafisica dell’immanenza” di Aristotele la sua espressione più alta e compiuta. E’ invece proprio nella categoria concettuale della sussidiarietà che trova espressione il naturalismo etico-politico di Aristotele, per il quale la polis è per natura ed anzi addirittura l’intero della polis precede la parte perché se l’individuo, preso da sé, non è autosufficiente, sarà rispetto al tutto nella stessa relazione in cui lo sono le altre parti. Contro la tesi di un assorbimento senza residui dell’individuo nella comunità, peraltro, Aristotele afferma a chiare lettere la via di mezzo tra comunitarismo organicista e individualismo liberale nella critica a Platone contenuta nel secondo libro della Politica, secondo la quale il pluralismo sociale, le formazioni sociali, e con esse l’individuo, vanno salvaguardate: «è evidente che il tentare di ridurre troppo la città all’unità non è il partito migliore»; insieme egli sostiene che ciò che è meno unitario è preferibile a ciò che lo è di più. Ad analoga conclusione Aristotele giunge riflettendo sulla possibilità di una proprietà collettiva e contrapponendola alla proprietà individuale; tanto ciò è vero che egli sottolinea che l’unità cittadina non potrebbe comunque derivare dalla possibilità che tutti dicano contemporaneamente «questo è mio» o «questo non è mio». E’ questa in fondo una delle ragioni più profonde per le quali Tommaso d’Aquino “legge” Aristotele, ne riprende il pensiero e lo introduce nella modernità. In particolare, emerge la sua potenziale originaria continuità col pensiero cristiano, che ha nella sussidiarietà oggi definita orizzontale, e nella continuità tra Uomo e Cittadino, uno dei tratti essenziali. Vale insomma, nella prospettiva di un ordine naturale immanente, quanto si può osservare anche a a proposito dell’ordine metafisico cristiano della Città di Dio, che certo preesiste ad ogni singola esistenza umana e ne è il fine ma non sacrifica l’individuo e la sua libertà di scelta: l’uomo conserva la propria assoluta indipendenza ed assume le proprie decisioni senza vincoli di fronte allo stesso Ordine metafisico di Dio, paradossalmente «soggetto» al libero arbitrio dell’individuo. Ma la specificità e la piena realizzazione di sé coincide senza residui con un libero arbitrio che si svolga in coincidenza della libertà «decisa» per lui dall’Ordine divino nel quale si inscrive il progetto individuale assegnato a ciascuno. Su tali temi, mi sia consentito rinviare a M. ASERO, Una, nessuna, centomila…? Sussidiarietà: la parola che ha salvato Maastricht e l’Europa di Lisbona, in G. GRASSO LEANZA (a cura di), L’Europa dopo Lisbona, Catania 2009, pagg. 167-223, e particolarmente pagg. 177-179, dove tra l’altro si sottolinea come i tratti della sussidiarietà siano assai utili anche all’interno del problematico disegno delle radici cristiane dell’Europa, tema che ha animato la discussione sui tratti essenziali della Costituzione europea per poi rimanere ai margini del testo proposto, descrivendo quel sottile filo rosso che segnala ambiti di continuità tra la normatività greca del Nòmos e quella ebraico-cristiana del Lògos. Ed anche come sia proprio in questa logica che l’applicazione universale alla teoria dello stato di un principio che affonda le proprie origini proprio nell’etica sociale cristiana quale ispirata dalla teoria filosofica sociale classica troverebbe la più profonda motivazione in relazione alle forme dell’integrazione europea. Proprio per questo il dibattito contemporaneo sui tanti post che contraddistinguono l’attuale stadio della nostra civiltà e cultura giuridica, politica ed economica, in particolare, può utilmente giovarsi di una comprensione della sussidiarietà come una delle chiavi per ri-abilitare il cittadino proprio all’interno del percorso che congiunge la riflessione classica e quella moderna sull’uomo, nella sua dimensione individuale e collettiva.
[v] Rimangono ai margini oppure vengono sospinti, come è accaduto significativamente con gli apolidi e le minoranze, in quella terra di nessuno nella quale, con Hannah Arendt, il vero problema è il riconoscimento dello stesso, fondamentale diritto ad avere diritti.
[vi] Assai interessante su tali temi, l’analisi di J. KRISTEVA, Stranieri a se stessi, Milano 1990, pag. 39, ove si compie una rassegna della storia occidentale e si evidenziano insieme momenti in cui lo straniero è il nemico e momenti in cui si è invece concepito il sogno di una società senza stranieri, al di là di ogni dinamica di mera assimilazione del diverso e attraverso processi di autentica integrazione. In particolare, la scrittrice bulgara osserva che «il problema degli stranieri si pone a un popolo quando, dopo avere attraversato lo spirito della religione, ritrova una preoccupazione etica […] per non morire di cinismo o di colpi in borsa. La figura dello straniero occupa il luogo e il posto della morte di Dio e, per coloro che credono, lo straniero esiste per ridargli la vita» Secondo criteri che la teoria giuspubblicistica moderna ha costruito, per definire l’elemento personale all’interno della teoria dello stato, essenzialmente sui criteri dello ius sanguinis e dello ius soli.
[vii] Occorre tuttavia evidenziare, come pure rileva J. KRISTEVA, op. cit., pag. 9, che ci sono momenti della storia occidentale in cui «lo straniero è stato pensato, accolto o respinto, ma in cui, all’orizzonte di una religione o di una morale, si è anche concepito come possibile il sogno di una società senza stranieri.» Il tema assume certo un particolare rilievo in relazione alla problematica delle radici dell’Europa: è ancora la stessa Autrice, op. cit., pag. 60, a segnalare, al di là del pensiero greco e particolarmente del cosmopolitismo ellenistico, che: «il monoteismo biblico aveva incluso l’estraneità nell’Alleanza divina. … esso aveva inscritto da millenni, alle fondamenta stesse del regno ebraico, gli stranieri capaci di accettare il contratto divino.». Il messaggio cristiano, tra antico e nuovo Testamento, in questo senso pone una serie di interrogativi sul rapporto tra definizione dell’identità dell’uomo e sua specificazione come cittadino di un popolo eletto da Dio, per un verso, e conseguente rapporto con l’altro, l’estraneo al popolo eletto medesimo, lungo quella linea di confine che concepisce l’ammissione alla cittadinanza ma insieme la risolve talora nell’integrazione ma talaltra nella assimilazione, quest’ultima in evidente sfregio di ogni diversa identità precedente.
Per quanto non possa qui che rinviarsi a sedi più opportune per una adeguata trattazione, tra argomentazioni teologiche, giuridiche e filosofico-politiche, ci si limita ad alcune brevi osservazioni utili a definire meglio l’orizzonte ora prefigurato. L’alleanza primigenia è nella creazione, laddove l’atto di amore di Dio è fare «l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza». E tale dono è definizione di identità e assegnazione di cittadinanza del Regno in una piena ed evidente continuità ontologica con l’Uomo, concesso nella fondamentale unità del genere umano, che nella diversità delle forme è impressa con l’atto della creazione all’umanità della donna e dell’uomo. Il compimento del peccato originale è la prima rottura dell’Alleanza offerta da Dio all’umanità intera attraverso Adamo ed Eva e con essa la prima crisi di identità, che è insieme origine, con la cacciata dall’Eden, della distinzione tra la cittadinanza della Città celeste e quella della Gerusalemme terrena. Successivamente la corruzione dell’umanità, secondo quanto indica significativamente il titolo del capitolo sesto della Genesi, addolora il Signore al punto da decidere di sterminare l’uomo, della cui creazione si pente. Noè, tuttavia, trova grazia agli occhi del Signore, che in lui decide di stabilire l’Alleanza (Genesi, 6, 18) e nella sua famiglia rinnova l’umanità. Dunque l’alleanza è per l’intera umanità, quale rappresentata dalle stirpi discendenti da Sem, Cam e Jafet: “Poi Iddio così parlò a Noè e ai suoi figli: «Ecco, io stabilirò il mio patto con voi e i vostri discendenti, che verranno dopo di voi … Io stabilirò il mio patto con voi, e nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio …». Poi Iddio soggiunse: «Questo sarà il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni in perpetuo»”. Non vi è dunque ancora definizione di appartenenza e identità di cittadinanza particolare che ponga il problema del rapporto tra cittadini ed estranei, stranieri rispetto all’alleanza, e apra spazi alle scelte dell’esclusione e dell’inclusione, perché uno è il popolo. Tanto che, si legge proseguendo nel racconto della Genesi, la terra tutta aveva un medesimo linguaggio e usava le stesse parole, col che si intende evidentemente che le cose avevano uno ed un solo nome che intendeva definirne l’essenza. Si colloca qui, ed è oggetto rispettivamente del primo e del secondo libro della Genesi, il passaggio dalla storia dell’umanità a quella del popolo eletto; elezione che muove dalla dispersione dei popoli ancora una volta attuata per punire un peccato di orgoglio – che il principio delle opere fosse l’essere un popolo ed avere un medesimo linguaggio e che di tale unità essi fossero fautori e garanti, nella costruzione della celebre torre, indipendentemente da ogni necessaria alleanza con il Creatore e di ogni Progetto cui l’uomo è destinato. Pur non deportando nessuno, Dio decide perciò di confondere il loro linguaggio e diffondere l’umanità per la terra, in popoli e nazioni. E’ questo il presupposto di una ulteriore alleanza, particolare, con uno dei popoli, che viene eletto in Abramo. Essa contiene tuttavia il segno dell’apertura agli uomini tutti che pure si concreta nella promessa del Redentore offerto prima attraverso il progenitore comune Adamo e ora precisando nella discendenza di Abramo da quale stirpe verrà: «in te saranno benedetti tutti i popoli della terra». Si comprende in fondo anche l’argomentazione di J. KRISTEVA, op. cit., in relazione al tema del popolo eletto e della scelta dell’estraneità, sviluppato da questo A. nella specie particolarmente a pag. 62 ove ella ricorda una tradizione che affronta l’argomento cercando di motivare il perché della decisione di Dio: «“Perché il Santo-Unico (che sia benedetto!) ha scelto Israele? Perché tutti i popoli ripudiarono la Torah e rifiutarono di riceverlo, mentre Israele accetto e scelse il Santo-Unico (che sia benedetto!) e la sua Torah”». E ancora sottolinea come per i rabbini la Torah sarebbe in definitiva rivolta a tutta l’umanità tanto è vero che Mosè la espone in sessantasei lingue. E’ vero che in molti passi della Bibbia si segna il confine tra coloro che appartengono al popolo con il quale Dio ha stretto l’Alleanza in Abramo e coloro che sono estranei ad essa e che chi vi si oppone viene punito e distrutto: «Così parla il Dio degli eserciti: Ho deciso di punire ciò che Amalec fece contro Israele, perché gli si oppose sulla via, quando quello usciva dall’Egitto. Va’ dunque, colpisci Amalec, e vota alla distruzione lui con tutto ciò che gli appartiene» (I Samuele, 15, 2-3). Ma insieme è vero che anche il popolo eletto è straniero in terra d’Egitto e che, per altro verso, degli stranieri sono ammessi: proprio l’Egiziano, per esempio, è ammesso ad entrare nell’assemblea del Signore, alla terza generazione successiva a quella che ha dato ospitalità nel proprio paese al popolo eletto. Dal periodo profetico, poi, Israele diventa luce di tutte le nazioni, l’alleanza è per tutti e il Messia promesso prima ad Adamo e poi ad Abramo esporrà l’alleanza alle nazioni, a tutti quei popoli al di là del mare individuati metaforicamente col termine isole, compresa dunque quella degli europei: “Ecco il mio servo che proteggo, il mio eletto, in cui si compiace l’anima mia; ho posto su di lui lo Spirito mio; egli esporrà la legge alle genti. … Egli esporrà fedelmente la legge e non desisterà, senza scoraggiarsi, finché non abbia stabilito la sua legge sulla terra e la sua dottrina che le isole attendono. Così parla il Signore Dio che crea i cieli e li stende, che forma la terra e i suoi frutti, che dà l’alito al popolo (singolare non plurale!) che la abita e il soffio a quanti la calcano: «Io, il Signore, ti ho chiamato per la (mia) giustizia e t’ho preso per mano, ti ho protetto, ti ho dato come alleanza del popolo, luce delle nazioni, per aprire gli occhi ai ciechi…» (Isaia, 42, 1-7). Nel nuovo Testamento, tuttavia, Israele rompe l’alleanza e la Nuova alleanza che le si sostituisce è rivolta a tutti gli uomini che riconoscono Cristo. Basti leggere il prologo di Giovanni per individuare nel segno della incapacità di riconoscere il Signore della Città la nuova frattura tra cittadinanza della Gerusalemme celeste, laddove l’Uomo è cittadino nella continuità di pensiero e azione che è del Lògos, e la cittadinanza nella Gerusalemme che è del mondo, frattura che conduce ad una Nuova alleanza in cui trova espressione l’Amore infinito di Dio verso coloro che desiderano accoglierlo e per ciò solo diventano cittadini del popolo dei figli di Dio: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui, neppure una delle cose create è stata fatta. … La luce, quella vera, che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. Era nel mondo, e il mondo fu creato per mezzo di lui, ma il mondo non lo conobbe. Venne fra la sua gente, e i suoi non lo ricevettero. Ma a quanti lo accolsero, a quelli che credono nel suo nome, diede il potere di diventare figlio di Dio; i quali, non dal sangue, né da voler di carne, né da voler dell’uomo, ma da Dio sono nati» (Giovanni, Prologo, 1,1-13). Tra cittadini della Gerusalemme celeste e di quella terrena si traccia il confine tra appartenenza ed estraneità al mondo, come risulta nel Vangelo di Giovanni, 15, 18-18-19: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo: or, perché non siete del mondo, ma anzi, scegliendovi, io vi ho fatto uscire dal mondo, per questo il mondo vi odia.».
Le identità particolari non costituiscono dunque un ostacolo alla comune appartenenza al popolo di Dio, cui rinunciare per aderire all’alleanza come pare in alcuni passi dell’Antico Testamento secondo la tradizione ebraica: l’episodio della discesa dello Spirito Santo e il dono delle lingue, nella direzione esattamente opposta a quella della confusione di Babele, a seguito del quale gli apostoli annunciano la parola di Dio e sono compresi da tutti i popoli rappresentanti il mondo allora conosciuto, dimostra che il solo denominatore capace di unire l’Uomo nella comune cittadinanza della Gerusalemme celeste è la parola di Dio (Atti, 2, 6-11). Ma questa viene portata a tutti, raggiunge ogni identità linguistica, e insieme ogni identità giuridica, politica, culturale e in una parola ogni antropologia in cui a partire dalla diversa identità linguistica causata dalla confusione di Babele si è progressivamente manifestata la diversità degli uomini e dei popoli nei talenti individuali e comunitari delle identità singole e collettive loro assegnate dal Progetto di Dio (si vedano altresì a tale riguardo Mt 28, 19 e Apocalisse V, 9-10) – profilo assai interessante sul piano della stessa identità dell’Unione europea e che appare fondare le posizioni critiche di chi, come Green, sottolinea la necessità di una lingua comune per l’Europa. E, infine, ancora sulla superiore unione dell’Uomo e del cittadino, nella consapevolezza della contestuale estraneità alle divisioni del mondo, si veda la lettera a Diogneto, V, 1-5: «I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia … Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito e nel resto, testimoniano un modello di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. … Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo.».
[viii]Su tali temi, si segnala in particolare nella dottrina filosofico-politica italiana di fine millennio, ex multis, per la sistematicità dell’indagine: G. MARRAMAO, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica, Torino 1995.
[ix] E’ in questo senso l’analisi di John L. Gaddis della prospettiva storico-internazionale negli anni della fine della guerra fredda come punto di svolta paragonabile ai precedenti del 1789-1794, 1917-1918 e 1945-1947, in J. L. GADDIS, The Cold War, the Long Peace, and the Future, sta in M. J. Hogan (a cura di), The end of the Cold war: Its Meanings and Implications, Cambridge 1992, pag. 22.
[x] A questo proposito, la diagnosi della fine della Storia, che secondo la nota analisi dello storico americano Francis Fukuyama sarebbe stata segnata dagli eventi del 1989, il nostro Ottantanove, con la caduta dei regimi comunisti dell’Europa… dell’Est, sembra in qualche modo richiamare, per così dire a livello delle paure collettive e conseguenti interpretazioni psicoanalatiche delle letture critiche che della realtà storica si propongono, quel mito della fine del mondo che ha rappresentato l’incubo collettivo dell’umanità prossima all’anno Mille. Sul tema dell’ «altro 89 e la finta “fine della Storia”», si veda A. TANZI, Evoluzioni e involuzioni di un diritto internazionale poco cosmopolita, in Cosmopolis, 1/2006, sta in http://www.cosmopolisonline.it/tanzi.htm, la quale tra l’altro sottolinea come la natura consapevolmente provocatoria dell’espressione di Fukuyama facesse riferimento alla storia come «evoluzione dialettica come alternata interazione e conflittualità tra diversità» e mirasse a sottolineare l’affermazione di un unico modello economico e politico-istituzionale, quello del liberismo e delle democrazie occidentali.
[xi] Sul significato e la genesi della globalizzazione, in questa direzione, emblematiche sono le acute riflessioni di Zolo, il quale segnala come la globalizzazione ha una radice antica e, a differenza di Amartya Sen, che fa risalire il fenomeno ai grandi movimenti rinascimentali, come la prima globalizzazione a ben pensarci è un movimento verso est. Più in particolare in un libro di alcuni anni or sono, D. ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Bari-Roma 2006, si sottolinea anzitutto come quando parliamo di globalizzazione si dia per scontato che si tratti di un fenomeno economico laddove, invece, sarebbe più giusto distinguere aspetti diversi e dunque introdurre una specie di cartografia dei cambiamenti che la globalizzazione induce a livello planetario. Con questo A., poi, è necessario distinguere tre posizioni analitiche: un atteggiamento apologetico, la globalizzazione come via maestra per il benessere collettivo e l’armonia, anche politica planetaria, alla sola condizione che non ci sia alcun intervento politico e giuridico-normativo, posizione che si basa su un nucleo teorico di fondamentalismo liberale; una posizione critica, che muove da posizioni marxiste e nega la stessa idea di globalizzazione, che sarebbe uno pseudo-concetto, uno sviluppo fisiologico del capitalismo classico verso posizioni imperiali, la via per disfarsi delle sovranità statali e dare vita ad un mercato ampio quanto il mondo stesso; infine, ed è la posizione che annovera tra i suoi sostenitori Gallino, Stiglitz, Hirst e lo stesso Zolo, una posizione per così dire intermedia che ascrive al fenomeno della globalizzazione tanto aspetti positivi che aspetti negativi; tra i primi, individua in particolare il processo di integrazione globale dell’economia che ha oggettivamente prodotto un incremento della produzione di ricchezza proprio in relazione all’affermazione del mercato globale rispetto ai sistemi marxisti di economia pianificata, e nonostante vi siano profili critici in relazione alla produzione di esternalità – fenomeno pure di grande rilievo proprio per la sua capacità di incidere negativamente sulle dinamiche integrative dello stato sociale. Tra gli aspetti negativi della globalizzazione, d’altro lato, si deve annoverare il fatto che non si tratta affatto di un fenomeno globale ma invece di una realtà che collega (solo) alcuni ambiti continentali, ovviamente Stati Uniti, Europa, Giappone, mentre lascia sostanzialmente fuori tutta l’Africa, molti paesi latino-americani, il Brasile e molti paesi dell’Asia centrale, come per esempio l’Afghanistan.
[xii] Che l’economia manifestasse un proprio potere integrativo al di là dei muri che separavano l’Est dall’Ovest è testimoniato esemplarmente dalla vicenda dell’ENI di Enrico Mattei, con la sua apertura ai rapporti commerciali, più e prima che politici, con l’Unione sovietica. Come è noto, all’accordo del 4 dicembre 1958, con il quale l’ENI stipula il primo contratto di acquisto di petrolio grezzo dal governo russo, segue infatti, alla fine dello stesso dicembre, l’incontro con vari esponenti del governo sovietico, tra cui Gurov, Kuznestov, Malinin e un significativo consolidamento dei rapporti che prelude per un verso all’ampliamento del contratto dell’anno successivo e per l’altro, nel 1960, come pure è ricordato da fonti della stessa ENI, in «Mattei e la Russia (1958-1960)», in www.eni.it/it_IT/attachments/azienda/storia/pillole/Mattei_Russia.doc, all’assunzione dell’accordo di un diverso significato. La situazione politica internazionale registrava ulteriori tensioni e la temperatura della “guerra fredda” era per così dire ai minimi ma Mattei si muove all’interno di una logica di politica economica aziendale e nazionale che travalica i confini della dis-integrazione segnata dai muri e si spende attivamente per l’organizzazione del viaggio del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi a Mosca, ciò che provoca lo sconcerto del partito di maggioranza e degli ambienti ecclesiastici ma produce la richiesta dell’ente statale sovietico per le esportazioni, la Sojunefte export, di partecipazione dell’ENI alla costruzione dell’oleodotto Caucaso-Mare del Nord e la sigla dell’accordo con il Ministro per il Commercio estero Potolicev il successivo 11 ottobre. Sul sottile filo rosso che congiunge e pure segna i rispettivi confini di economia e politica nazionale e internazionale, con l’inter-agire, all’interno di dinamiche integrative e dis-integrative che segnano la storia delle identità individuali e collettive dell’umanità, di sovranità superiorem non recognoscentes, eppure tante volte dimezzate, è proprio quell’accordo a segnare una frattura con gli USA, testimoniata dal documento richiamato dalla stessa fonte sopra citata e rappresentato dal New York Times del novembre 1960, che accusa il Presidente Mattei “di non mantenere i patti stipulati nel dopoguerra, di avere rotto gli equilibri del mercato dei prodotti petroliferi, scavalcando e danneggiando con la sua egoistica autonomia non solo gli interessi delle grandi Compagnie ma anche di avere compromesso futuri equilibri politici”. Dinamiche sostanziali a capo di un ordine economico e politico che certo, pur di segno e in un contesto storico, politico ed economico diversi, anche l’Europa oggi formalmente fondata sul libero mercato continua a conoscere di fronte ai fallimenti della economia finanziaria, se solo si pensa alla recente trattativa sulla Opel e al ruolo di primo piano svolto dal governo tedesco nella scelta della Magna, appoggiata dall’amministrazione russa con il consenso del Presidente statunitense, a preferenza della FIAT, in tale contesto significativamente “lasciata sola”, poi affermandosi da parte del nostro Presidente del consiglio che non era stato chiesto alcun intervento, dal Governo italiano che, tra Pilato, Machiavelli e Adam Smith ha scelto di non provare neppure a sostenere la candidatura dell’azienda torinese e, mi si permetta di notarlo, insieme ad essa del sistema produttivo industriale italiano. Nonostante ogni proclama sulle politiche programmatiche per fronteggiare la crisi…
[xiii] Quanto poi il tema incida profondamente sulla autocoscienza individuale segnando concretamente la propria esistenza attraverso la lacerazione del senso di appartenenza è testimoniato esemplarmente da una delle pellicole tedesche più interessanti e apprezzate dal pubblico degli ultimi anni, Good bye, Lenin! (2003), di Wolfang Becker, nella quale è evidenziato il conflitto tra attaccamento nostalgico, affettivo di tanti cittadini della Repubblica democratica tedesca a quella che è stata per anni la loro Patria – e nella derivazione etimologica del vocabolo dal termine pater è facile individuare il senso più radicale di quanto stiamo qui osservando. Osserva L. TORNABUONI, nella recensione del film, in La Stampa, 5 maggio 2003, che la pellicola: «affronta in chiave comica il tema (o il problema) del comunismo morto che non vuol morire, della Germania orientale che non si rassegna a scomparire nonostante siano passati anni dall’unificazione del Paese, della Repubblica democratica tedesca che rimane nel cuore, nelle abitudini, nelle nostalgie dei suoi ex cittadini.», tanto che ad una madre colpita da infarto e rimasta lungamente in coma a cavallo della caduta del muro di Berlino, il figlio, avvertito dai medici della assoluta necessità di non creare scompensi emotivi certamente fatali, non dice nulla del Muro alla madre, mette in scena nella stanza dell’ammalata la vita d’un tempo e finisce, grazie ad amici capaci anche di registrare e mettere in onda falsi telegiornali, per mettere in scena una storia diversa che racconta la vittoria di Lenin sul mondo occidentale per salvare la madre dal vuoto di senso di un’appartenenza assai problematica ma che è stata l’orizzonte di significato della propria identità collettiva e infine anche di quella individuale.
[xiv] Sicché, come rileva J. KRISTEVA, op. cit., fra l’uomo e il cittadino ci sarebbe una cicatrice, lo straniero. Ma forse, a guardare anche dentro le mura della Città, c’è un’altra cicatrice che separa dolorosamente l’uomo e il cittadino e segna il tramonto della Politica, progressivamente sostituita dal dominio, ed è quella che si accompagna alla sostituzione ad un ordine naturale, che è proprio della tradizione classica e ne segna la significativa convergenza con la cultura cristiana, di un ordine artificiale, quello della Modernità. E questa altra cicatrice, come meglio si dirà oltre nel testo esprimendo il senso del desiderio di cittadinanza che mette capo alla ri-abilitazione della categoria della cittadinanza, ha un nome: il suddito.
[xv] Assai incisive su tali temi, e particolarmente a proposito dell’attacco, e della parziale distruzione, dell’azione totalitaria nei confronti della struttura della civiltà europea, dunque della coscienza e della identità europea, le osservazioni di H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, pag. 372: «Le guerre civili scoppiate nel periodo fra i due conflitti mondiali furono più sanguinose e crudeli che in passato; e diedero luogo a migrazioni di gruppi che a differenza dei loro più fortunati predecessori, i profughi delle guerre religiose, non furono accolti e assimilati in nessun paese. Una volta lasciata la patria d’origine essi rimasero senza patria, una volta lasciato il loro stato furono condannati all’apolidicità. Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere senza alcun diritto, la schiuma della terra» (corsivo mio). Va peraltro rilevato criticamente che a tutt’oggi diversa è la garanzia dei diritti umani a seconda di quale sia il pregio della cittadinanza che se ne faccia garante: insomma, essa dipende in definitiva dal diverso peso degli Stati sovrani, sul piano dell’effettività, nell’ordine internazionale costituito. E per converso, le stesse sovranità sono «offese» nella loro valenza concettuale di «superiorem non recognoscens» ogni volta in cui per il riconoscimento della loro statualità nella comunità internazionale sono sottoposte alla verifica del rispetto di certi standards, come avviene per il regime dei diritti umani. Con la conseguenza, in definitiva, che una volta la sovranità è troppo forte e l’altra troppo debole e che in entrambi i casi i diritti del cittadino, e con essi i diritti umani che quelli dovrebbero garantire sono «giuridicamente» esposti alla pura effettività dei rapporti di forza in seno all’ordinamento internazionale. Il diverso peso degli Stati sovrani, sul piano della effettività, nell’ordine costituito, apre peraltro un discorso che andrebbe sviluppato in varie forme anche in relazione alla Organizzazione delle Nazioni Unite e su base regionale anche in relazione alla Unione Europea. Ciò che è certo, tuttavia, è che pochi Stati potessero essere riconosciuti sovrani già prima dell’avvento della globalizzazione se solo si fosse rigorosamente applicato il criterio del «superiorem non recognoscens», come tra l’altro dimostra il veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a disposizione dei membri permanenti e del “sovrano di turno”, esercitato dal pur “depotenziato” Presidente degli Stati Uniti George W. Bush agli ultimi giorni del suo mandato, e destinato ad essere sostituito da un Presidente eletto nelle avverse fila dei democratici, in ordine alla possibilità di discutere una mozione sulla nuova crisi di Gaza e sull’operazione militare «Cast lead» di Israele. E’ dei primi giorni di maggio 2009, la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta creata per questa investigazione (che ora sarà sottoposta al voto del Consiglio di Sicurezza costituendo a sua volta un importante banco di prova per la nuova amministrazione americana Obama), la quale, pur non essendo un organo giudiziario ONU, giunge a formalizzare un’accusa nei confronti di Israele per l’uso sproporzionato della forza e per avere colpito deliberatamente civili e istituzioni Onu, evidentemente in violazione dei diritti umani, in un numero di sei episodi dei nove sottoposti alle indagini della Commissione occorsi tra il 27 dicembre 2008 e il 19 gennaio 2009. Tema che, nella sua alta problematicità, per l’inesistenza di uno Stato palestinese, ripropone quello della continuità tra diritti umani e diritti del cittadino posto dalla Arendt, pure assai sensibile alla vicenda della “sostituzione” del popolo palestinese agli apolidi ebrei laddove osserva: «Dopo la guerra la questione ebraica, che era stata considerata l’unica insolubile, venne in effetti risolta con la colonizzazione e la conquista di un territorio; na, lungi dal risolvere il problema delle minoranze e degli apolidi, e al pari di quasi tutti gli avvenimenti del nostro secolo, tale soluzione produsse una nuova categoria, i profughi arabi, aumentando di altre 700-800 mila unità il numero delle persone senza stato e senza diritti», in H. ARENDT, ult. op. cit., pag. 402.
[xvi] Che è quella della scoperta dell’America da parte degli europei e del primo epocale incontro con l’altro, il quale mette in crisi la coscienza e l’identità europea e con essa la propria antropologia, che solo l’autorità delle sue origini greche e del modello culturale cristiano ed occidentale, cui era informata, giustificavano. Con la scoperta delle Indie, l’uomo occidentale, cristiano, cattolico si trova per la prima volta di fronte ad una diversità così radicale, insieme fisica, linguistica, religiosa, culturale da giungere ad interrogarsi su che cosa sia l’altro e che cosa ci identifichi. E insieme si pone, è costretto a porsi il problema di come governare la diversità antropologica, di come atteggiarsi nei suoi confronti. Domanda che l’anno 1492 ha posto per la prima volta, con radicalità e ambiguità, si pensi al decreto di espulsione degli ebrei non conversos dalla Spagna e all’abbandono dell’ultimo avamposto musulmano nel suolo europeo da parte dell’emiro Boabdil per evitare una ulteriore guerra che si contrappongono negli stessi giorni all’apertura alla diversità che si registra nei diari di Colombo, assai simili a quelle che osserviamo ai nostri giorni in cui i processi di integrazione europea si mischiano alle politiche di pulizia etnica che hanno condotto ai conflitti nella Serbia e nel Montenegro e in Albania. Sulla caduta dell’uomo naturale, provocata dall’impatto con civiltà e culture completamente nuove, e sulla conseguente crisi dei paradigmi di comprensione del mondo, e anzitutto del valore primario della teologia in tale percorso di autocomprensione dell’uomo, nella direzione della nascente antropologia moderna, fondamentale è da ritenere l’accurato studio di A. PAGDEN, La caduta dell’uomo naturale. L’indiano d’America e le origini dell’etnologia comparata, Torino 1982.
[xvii] E dunque, assai significativamente, riguarda tutti gli elementi costitutivi dello Stato nazionale moderno, del suo diritto pubblico e particolarmente del suo modello di ordine sovrano: territorio, popolo, governo. E infatti , parallelamente, la sovranità statuale registra una crisi senza precedenti.
[xviii] Sul tema dell’Unione per il Mediterraneo quale espressione di uno dei tratti costitutivi del progetto politico dell’Unione europea, investimento per il futuro – che è insieme autentico recupero delle proprie radici, storiche, culturali, politiche, giuridiche, religiose e, in senso rigoroso anche se per lo più trascurato e “fuori moda”, antropologico -, si veda anche N. PARISI, L’ “Unione per il Mediterraneo”: nuove prospettive di cooperazione nell’area euro-mediterranea per la tutela dei diritti individuali e della sicurezza collettiva, in questa stesso stessa rivista, laddove l’A. sottolinea dapprima, particolarmente a pag. (1 del manoscritto della professoressa), come il Mar Mediterraneo è sempre stato, fin da un lontanissimo passato, un crocevia fondamentale a motivo della propria posizione geografica, di fattori geo-politici, di interessi economico-commerciali, e come nella attuale temperie storica occorra «riflettere per individuare la dimensione politica necessaria a valorizzare il processo di globalizzazione in atto da tempo anche nell’area mediterranea». E poi evidenzia, particolarmente a pag. (6 del manoscritto della professoressa), la centralità della Unione per il Mediterraneo quale sede istituzionale di riferimento per la politica internazionale dell’Unione europea per il Mediterraneo, all’interno dunque di un progetto che oltrepassa i confini politicamente circoscritti della cooperazione regionale e del consolidamento della buona governance e dello stato di diritto per i paesi del Mediterraneo e tutti li inscrive, insieme allo stesso miglioramento della gestione della migrazione e della sicurezza, nella loro complessa interconnessione, in quel progetto di cui essa è chiamata appunto a divenire il centro propulsivo rappresentativo della intera «strategia delle istituzioni europee in tema di gestione dei rapporti esterni con questa regione del mondo».
[xix] Tema sul quale rimane fondamentale la considerazione critica di Foucalt, il quale osserva che “la teoria politica è rimasta ossessionata dal personaggio del sovrano”, per poi dedurne conclusivamente che «Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non sia costruita intorno al problema della sovranità» e dunque, drasticamente, che “Bisogna tagliare la testa al re: non lo si è ancora fatto nella teoria politica”, M. FOUCALT, Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di A. Fontana – P. Pasquino, Torino 1977, p. 15.
[xx] Che è una complessità per così dire genetica: quali sono le radici dell’Europa? E’, evidentemente, un interrogativo cui non si può certo pensare di risposta in poche considerazioni e per cenni, ma che tuttavia bisogna tenere presente ed evidenziare. Non vi è dubbio, infatti, a tale riguardo che la lettura ed interpretazione del codice genetico dell’Europa segnali la sua singolarità in ognuna dei suoi caratteri e delle dimensioni che essi esprimono. Si tratta, infatti, dal punto di vista geografico, e come pure si è fatto cenno sopra nel testo, di un continente che non ha confini ben delimitati e che anzitutto per tale ragione non si definisce generalmente per se stessa ma in relazione ad altro: così, nel passaggio dal mito alla denominazione geografica, essa è sorella di Asia nel verso 357 della Teogonia di Esiodo, o nipote di Libia, come risulta nelle Metamorfosi di Ovidio (II, 858). E in effetti va rilevato che, se si esclude il confine ad ovest, con l’ oceano Atlantico, ogni altro confine dell’Europa è difficile da definire e particolarmente problematica risulta la definizione del suo “centro”: la storia politica e culturale dell’Europa ha infatti registrato lo spostamento del «centro» dal Mediterraneo, che è stata la culla di quella che definiamo civiltà europea, al centro del continente, la cosiddetta Mittle Europa, che poi è in parte divenuta est dell’Europa.
[xxi] P. HAZARD, La crisi della coscienza europea, Torino 1946, pagg. 481-487, ove in particolare si osserva: «Che cosa è l’Europa? Un accanimento di vicini che si combattono tra loro. Rivalità della Francia e dell’Inghilterra, della Francia e di casa d’Austria; guerra di successione di Spagna. Guerra generale, osservano i trattati di storia, i quali duran fatica a seguire sin nei particolari queste lotte confuse. Gli accordi conducono solo a brevi tregue, la pace non è più che una nostalgia, i popoli sono esausti e la guerra continua […]
Che cos’è l’Europa? Una forma contraddittoria, ad un tempo rigida e incerta. Un groviglio di barriere e, davanti a ciascuna di esse, persone il cui mestiere è di chiedere i passaporti e di far pagare dazi: tutti ostacoli alle comunicazioni fraterne […]
Ora, queste rigide frontiere vengono di continuo rese incerte, perché vengono modificate dalle conquiste, dai trattai o dalle semplici prese di possesso. Le barriere vengono portate avanti, indietro, soppresse, ristabilite … Donde questa contraddizione interna: l’Europa è un composto di forme che essa dichiara intangibili, ma che continua senza posa a modificare. […]
Che cos’è l’Europa? Un pensiero sempre insoddisfatto. Senza pietà per se medesima, essa non cerca mai di cercare la felicità e, cosa ancor più indispensabile e preziosa, la verità. Appena trovi una condizione che sembra soddisfi a tale duplice esigenza, essa si accorge, sa di tenere pur sempre, e in maniera incerta, soltanto il provvisorio, il relativo; e riprende la ricerca che costituisce la sua gloria e il suo tormento. […] in Europa si disfa durante la notte la tela che il giorno ha tessuta; si provano altri fili, si ordiscono altre trame, e ogni mattino risuona lo strepito degli opifici che fabbricano, trepidando, qualcosa di nuovo.».
[xxii] Allo stato attuale non sono stati completati i procedimenti di ratifica di Germania, Irlanda, Polonia e Repubblica ceca. A questo proposito, proprio nei giorni in cui si licenzia questo studio (e in particolare il 30 giugno) è intervenuta la sentenza della Corte di Karlsruhe, al cui giudizio era subordinata la ratifica tedesca, e cui nelle previsioni avrebbe dovuto seguire la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Köhler e il deposito degli strumenti di ratifica a Roma. La primissima lettura che se ne è potuta dare non consente ovviamente, e a maggiore ragione per la complessità dei temi e delle argomentazioni che ivi sono affrontati e sviluppati, di fare alcun commento critico dettagliato alla pronuncia del Giudice costituzionale tedesco. Basti qui evidenziare, limitandoci per lo più a riportare con fedeltà testuale alcuni tratti della decisione, che la sentenza afferma la compatibilità della legge di adesione al Trattato di Lisbona con la Grundgesetz ma insieme muove una censura alla legge tedesca di allargamento e rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat nelle materie dell’Unione europea in relazione all’ art. 38.1 in connessione con l’art. 23.1 della Legge Fondamentale tedesca. Essa infatti non ha provveduto ad accordare al Bundestag e, per gli ambiti di sua competenza, al Bundesrat, sufficienti diritti di partecipazione nelle procedure di formazione legislativa e di modifica dei trattati europei, ragione per cui la Corte conclude che gli strumenti di ratifica del trattato di Lisbona della Repubblica federale tedesca non potranno essere depositati se non dopo che sia entrata in vigore l’elaborazione legale dei diritti di partecipazione delle assemblee parlamentari costituzionalmente richiesta. Sicché sarà necessario procedere al recepimento legislativo delle indicazioni del Tribunale di Karlsruhe, con qualche verosimiglianza ipotizzato per il 18 settembre, prima di potere ultimare il procedimento, in assenza di altri ricorsi, con la promulgazione e il deposito degli strumenti di ratifica. Al solo scopo di prefigurare alcuni ambiti di approfondimento per successivi studi, sembra di qualche utilità, tuttavia, segnalare sommariamente sin d’ora il percorso critico-logico attraverso cui la Corte costituzionale Federale giunge alla decisione. Essa si concentra sul rapporto tra sistema democratico prescritto a livello della Federazione tedesca dalla Legge Fondamentale e grado di indipendenza di governo che è stato raggiunto a livello europeo, rilevando che il grado di libertà di azione dell’Unione si è rapidamente e considerevolmente incrementato, non da ultimo proprio attraverso il Trattato di Lisbona, sicché in certi settori di governo l’Unione europea ha uno spazio che corrisponde a quello di uno stato federale, dunque è analogo a quello di uno stato, ma che tuttavia il suo processo decisionale interno rimane improntato essenzialmente al modello di una organizzazione internazionale. E d’altra parte, rileva la Corte, ove pure si fondasse uno stato federale europeo, l’atto di adesione richiederebbe in Germania una modifica della Costituzione. A questo tema, che è in definitiva quello della individuazione del luogo della sovranità, si legano poi tanto le considerazioni in ordine alla stessa inesistenza di un popolo europeo come soggetto della legittimazione e sulla responsabilità per l’integrazione, che è tuttora, e va garantito rimanga, nelle mani dei corpi rappresentativi dei popoli europei. Ai medesimi fondamenti tematici, l’individuazione del luogo della sovranità nel suo rapporto con la fonte popolare della legittimazione del potere, si riconnette poi la conclusione che pure l’ulteriore sviluppo delle competenze del Parlamento europeo può ridurre ma non colmare il divario tra l’estensione del potere di assumere decisioni da parte delle istituzioni dell’Unione e il potere democratico di azione dei cittadini negli Stati membri, ragione per cui, muovendo da quello che la sentenza definisce un deficit strutturale che non può essere risolto in una associazione di stati qual’è l’Unione, ulteriori progressi del processo di integrazione non possono scardinare il potere politico di azione degli Stati o il principio di assegnazione. In questa direzione, in particolare, la Legge Fondamentale tedesca proibisce il trasferimento della competenza di decidere sulla sua stessa competenza (Kompetenz-kompetenz) altrimenti smarrendosi, oltre allo stesso senso logico di una costruzione improntata al principio di assegnazione, anche il limite fondamentale del rispetto della identità nazionale. Considerazione la quale conduce alla conclusione che il programma di integrazione dell’Unione europea deve perciò essere sufficientemente preciso; e che la revisione dei trattati europei e le leggi nazionali che la codificano negli ordinamenti nazionali devono essere informati a quei principi. In tale prospettiva, e in via di ancora più stringente sintesi, la sentenza sottolinea che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Repubblica Federale di Germania rimarrà uno stato sovrano dal momento che la distribuzione delle competenze dell’Unione e la loro delimitazione rispetto a quelle degli stati membri ha luogo in ragione del principio di assegnazione e alle previsioni in ordine all’esercizio delle competenze (sussidiarietà e proporzionalità); ma poi ritiene di segnalare altresì che la “procedura semplificata” di revisione dei Trattati attraverso la cosiddetta clausola ponte necessita di una esplicita approvazione del Bundestag, non essendo un sufficiente equivalente alla ratifica la possibilità del medesimo di rendere nota la propria opposizione, come prevede il Trattato di Lisbona. Non è opportuno in questa sede che ribadire il doveroso rinvio a esami più ponderati e competenti per una sentenza così complessa e delicata, anche sul piano degli scenari che essa apre ai dibattiti nazionali dei Paesi che non hanno ancora depositato le loro ratifiche, oltre che più in generale alla discussione sul futuro dell’Europa. A titolo provvisorio, mi sembra tuttavia opportuno concludere che la sentenza de qua confermi il grande imbarazzo della scienza giuridica e politica europea, e con esse delle stesse giurisprudenze costituzionali, nel mettere in discussione la figura del sovrano, della quale pure per più versi deve riconoscere la crisi e addirittura predica l’assenza nella civiltà e cultura postmoderna: gli interrogativi centrali sul senso della sussidiarietà nel suo rapporto costitutivo problematico con la politica e con il cittadino-uomo, che entrambe anima, sembrano in tale contesto vivere, nella forse non del tutto indispensabile riaffermazione della sovranità nazionale che si accompagna ai nuovi equilibri politici successivi all’allargamento a 27 e ai tanti dubbi che hanno affondato le speranze di un trattato costituzionale, solo un ulteriore capitolo della storia infinita della crisi della coscienza europea…
Quanto poi alla ratifica polacca, essa è in attesa della firma del Presidente della Repubblica Kaczyński che, con dichiarazioni successive, ha confermato nell’an la propria disponibilità e tuttavia, probabilmente per ragioni più specificamente di politica interna e per la stessa questione del collocamento del cosiddetto scudo spaziale USA, che lo vedono contrapposto al Primo ministro Tusk, ne ha subordinato il quando alla ratifica irlandese. Ancora, la ratifica della Repubblica ceca è ostacolata dalle posizioni euroscettiche del Presidente Klaus, l’unico a dichiarare che il Trattato era morto e a chiederne l’abbandono all’indomani del risultato negativo della consultazione referendaria irlandese; tuttavia, dopo la sentenza della Corte costituzionale ceca, la quale ha affermato il 26 novembre scorso che il Trattato di Lisbona dell’UE non viola la Costituzione nazionale e ha così aperto le porte alla fase della ratifica parlamentare, sono intervenute dapprima, in data 18 febbraio 2009, l’approvazione della Camera bassa del Parlamento ceco e poi, il successivo 6 maggio, l’approvazione del Senato della Repubblica ceca. Manca pertanto solo la firma del Presidente Klaus, che tuttavia ha annunciato che intende per ora apporre la sua indispensabile firma. Infine, il procedimento di ratifica irlandese è stato caratterizzato dallo stop determinato dall’esito negativo della consultazione referendaria del giugno scorso che aveva interrotto il processo di riforma ma il cui rilievo è stato infine superato proprio nei giorni scorsi al recente vertice di Bruxelles, nel corso del quale i ministri dell’UE hanno discusso la nuova tabella di marcia per il Trattato di Lisbona stabilendo che, non appena entrerà in vigore il trattato, verrà adottata una decisione per consentire a ciascuno Stato membro di nominare un commissario europeo – ciò che risponde concretamente ad un primo ordine di timori espressi dall’elettorato irlandese. Secondo quanto riferiva alla fine dello scorso anno una informativa della Commissione, inoltre, l’Irlanda “ha accettato di organizzare un secondo referendum il prossimo anno dopo avere risposto alle preoccupazioni degli elettori irlandesi”, referendum poi programmato entro ottobre 2009. La stessa fonte riferiva inoltre, a tale proposito, che “molti cittadini irlandesi temono che il trattato possa influire sulle politiche fiscali del loro paese, sulla sua neutralità militare e su questioni etiche come l’aborto” e che “il Consiglio ha offerto garanzie giuridiche all’Irlanda che il Trattato non violerà la sovranità del paese in questi settori”, in http://e.europa.eu/news/economy/081212_1_it.htm .
[xxiii] Fondamentale per la sua analisi e sottolineatura del simbolo quale rappresentazione sintetica del processo di integrazione è l’opera di R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, Milano 1988.
[xxiv] E.TRIGGIANI (a cura di), L’Unione Europea secondo la riforma di Lisbona, Bari 2008, pag. 12
[xxv] Osserva G. AMATO, Il futuro dell’Europa fra politica, sovranità e cittadinanza, in http:www.cosmopolisonline.it/amato_st.htm,: «l’equivoco può essere nato da una visione impropria di ciò che i padri fondatori decisero di fare quando si adottò la decisione di costruire l’Europa a partire da un mercato comune.
Partendo da questo equivoco, sarebbe facilissimo fare un’equazione fra mercato comune e Europa come semplice mercato. Questa prospettiva, tuttavia, non tiene conto di un fatto precedente che ipoteca tutti i successivi, e cioè che per i padri fondatori dell’Europa la costruzione del mercato comune altro non era che uno strumento per aggirare le difficoltà incontrate nel dar vita ad una autentica unione dei popoli europei. Questo è il loro intendimento, esplicito in Schumann, ma ancora di più nel nostro De Gasperi quando negli anni ’53-’54 si batté più di ogni altro perché si arrivasse subito alla formazione di un’assemblea parlamentare europea munita di poteri politici. E’ il “no” francese a questa impostazione che determinò il ripiegamento sulla costruzione di un mercato comune senza però far venir meno la stessa aspettativa e la stessa ambizione che portava in sé l’unione politica”.».
[xxvi] Su tali temi, mi sia consentito rinviare a M. ASERO, Una, nessuna, centomila…? Sussidiarietà: la parola che ha salvato Maastricht e l’Europa di Lisbona, op. cit.
[xxvii] J. ORTEGA Y GASSET, Il Medio Evo e l’ «idea» di Nazione, in La civiltà veneziana del Trecento, Firenze 1956, pag. 12.
[xxviii] Sicché, come ho avuto modo di segnalare altrove come ”ipotesi di lavoro”, in M. ASERO, La Riabilitazione della filosofia pratica tra moderno e postmoderno. Un possibile itinerario tra la tradizione della filosofia pratica e il neoaristotelismo di Hannah Arendt, in op. cit., pag. 354-355, la ri-fondazione della prassi posta al di qua di ogni metafisica, che ha dato origine ad alcuni rilievi critici, non costituisce il risultato del disinteresse per l’istanza fondativa, per la ricerca del primale, alla quale peraltro il pensiero tedesco ha sempre prestato particolare attenzione ma semmai è il frutto di un contesto epocale di crisi della razionalità tout court (che ha “travolto” ogni metafisica) e della “strategia” approntata per superarlo: in breve quella di ripartire dalla morale e dal cittadino per tornare a riflettere sull’uomo. Tra moderno e postmoderno… In tale contesto, si colloca e comprende la ricerca genealogico-concettuale, del concetto, quello che per Platone si appropria del suo nome per tutti i tempi, e parallelamente la sottolineatura degli slittamenti semantici che hanno interessato le principali categorie della Politica. Ne deriva, come pure segnala A. C. AMATO MANGIAMELI, «Desiderai essere un cittadino». Oltre il retaggio simbolico della moderna sovranità, Torino 1996, pag. 101-102, che (solo) «Se si traspone e si esaurisce la politica entro l’ordinamento giuridico, in linea con il progetto di spoliticizzazione dello Stato moderno, qualsiasi tipo di relazione finisce coll’essere assoggettata stabilmente al dato immediato positivo. […] Nel nostro caso, il tema della cittadinanza, così come ogni tema il cui spazio è concesso da sistemi normativi autoreferenziali, nasce e tramonta storicamente, è vero in un’epoca storica e privo di significato persuasivo in un’epoca diversa»; al contrario, per riprendere, invertendone il segno, quanto segnalato dallo stesso Autore (alla nota 87, pag. 103), la fatica per qualificare sia il cittadino che il politico non sarebbe utile solo a far gioire i dossografi, né potrebbe tutt’al più costituire solo l’oggetto di una querelle storiografica ma fonderebbe una indagine che non distingue il senso del politico, e con esso della politica, del diritto e dell’economia ma li ritrova unitari nella continuità teoretica del discorso sull’Uomo, che è anzitutto antropologico tout court. Discorso che si specifica nella ricostruzione genetico-concettuale di Platone del politico, secondo la quale il nome di polis è attribuito all’originario insediamento comune di uomini in una città; e in quella di Aristotele, il quale evidenzia la sinonimia di Stato e società civile quale resa proprio dall’idea stessa di cittadinanza come polis vivente.
[xxix] C. SCHMITT, Il concetto di ‘politico’, in «Le categorie del politico», Bologna 1972, pag. 143-144.
[xxx] E il passaggio dall’uno all’altro segna, come è noto, la nascita delle teorie della sovranità e della teoria dello stato moderna. Queste, come è noto, segnano infatti il passaggio da un ordo naturalis, oggettivo, ad un ordo artificialis, convenzionale, che proprio nella loro elaborazione trova la sua formalizzazione – per la cui ricostruzione si veda specialmente F. BORKENAU, Der Ubergang vom feudalen zum burgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, trad. it., Bologna 1984, ma anche G. MARRAMAO, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica, Torino 1995.
[xxxi] T. MOMMSEN, Clausola testamentaria, traduzione dall’originale tedesco di G. PASQUALI, in Rivista stor. Ital., LXI, 1949, pp. 337-338.
[xxxii] D. STERNBERGER, “Ich wünschte ein Bürger zu sein”. Neuen Versuche über den Staat, Frankfurt a. M. 1967; idem, Aspetti del carattere borghese, in Immagini enigmatiche dell’uomo, Bologna 1991.
[xxxiii] In particolare si richiama sin dal titolo alla clausola testamentaria di Mommsen, A. C. AMATO MANGIAMELI, «Desiderai essere un cittadino». Oltre il retaggio simbolico della moderna sovranità,op. cit. , la quale costruisce un itinerario che muove dalla consapevolezza che al quesito se la politica abbia ancora un senso si può rispondere semplicemente che “il senso della politica è la libertà”, ma sottolinea come ciò non soddisfa l’interrogativo più radicale, legato appunto agli sviluppi della modernità: la politica ha ancora un senso? In tale direzione, l’A. per un verso recupera la naturale identificazione tra società e governo degli antichi a partire da una concezione della libertà come partecipazione all’attività politica, ad un tempo evidenziando anche il «sacrificio» della «libertà individuale», e con essa dei diritti dell’individuo, alla comunità politica. Per l’altro, ripercorrendo la concezione moderna, segnala come essa abbia «per così dire il torto di invertire la relazione diritti-doveri e di liberare gli individui dalla politica» (p. 27), sino a giungere ad alimentare il dubbio radicale sulla stessa, espresso dalla Arendt. Infine la prospettiva contemporanea si trova da un lato a dover fronteggiare il fenomeno della «rifeudalizzazione» della comunità politica da parte del cittadino, così come prospettato da Dahrendorf, dall’altro, e ad aggravarne la problematicità, ha un rapporto difficile con il soggetto tout court: al di là di ogni cittadinanza.
[xxxiv] D. STERNBERGER, Il vocabolo politica e il concetto del politico, in Immagini enigmatiche dell’uomo, op. cit., pag. 149.
[xxxv] Così D. STERNBERGER, op. ult. cit., pagg. 152-153: «Ma prima di cercare il concetto vogliamo ricapitolare il vocabolo «politica» e la storia del suo significato, per lo meno in qualche tratto. Vogliamo comunque conoscere il nome di cui il concetto deve appropriarsi, secondo l’espressione di Platone. La storia del vocabolo «politica» è una storia avventurosa, piena di casi strani e di svolte sorprendenti. Nell’alto Medioevo il vocabolo è comparso in Europa come una parola straniera, si potrebbe quasi dire come un disguido. La sua trionfale carriera moderna, che lo ha inserito in tutte le lingue dell’occidente, inizia con il ritorno della Politica di Aristotele e con la sua traduzione in latino, compiuta intorno all’anno 1260 dal domenicano fiammingo Wilhelm von Moerbeke, probabilmente su ispirazione di Tommaso d’Aquino. […] Nel suo testo di traduzione, per il resto totalmente latino, Wilhelm ha conservato appunto queste parole straniere, in forma leggermente latinizzata: politicus, politica, politicum. Non in tutti i casi, certo, talvolta le ha anche tradotte. Il celebre zoon politikon, per esempio, qui suona animal civile. Di regola, il vocabolo di base polis ricorre soltanto in latino come civitas, il polites come civis. Per questo è vero che nelle lingue moderne abbiamo la city e i citizen, il citoyen e la cité, la città e il cittadino, ma gli affari di questi citizen e citoyens, gli affari, le istituzioni e le aspirazioni, ciò che li riguarda e che essi esercitano, ciò non si chiama Zivik (la «civiltà») come avrebbe anche potuto chiamarsi e avrebbe potuto svilupparsi, bensì Politik, Politics, politica. […] Questo è il primo caso, la prima curiosità in questa storia del vocabolo, gravido al massimo di conseguenze, tra l’altro perché in questa maniera il legame linguistico tra lo Stato, i cittadini e gli affari e le istituzioni statali-civili – polis, polites, e ta politika – nella versione latina e in tutte le lingue europee senza eccezione era ora spezzato: la politica, il politico, l’uomo politico rimasero greci, lo Stato e i cittadini diventarono latini e in questo modo anche inglesi, francesi, italiani, spagnoli. Il tedesco fa eccezione, noi non abbiamo derivato i nostri concetti corrispondenti da questa radice romana, latina, bensì il Bürger (cittadino) da Burg (rocca, cittadella), e lo Staat (Stato) da status. Ciò significa che linguisticamente non era più immediata l’origine civile o di cittadinanza della politica; non era più distinta né percettibile e sono convinto che questa separazione della politica dalla sua originaria famiglia di vocaboli abbia contribuito moltissimo al fatto che la storia semantica del vocabolo politica presenti salti così fantastici, che la «politica» assuma significati che non mostrano più la minima connessione con il suo mondo originario, vale a dire della polis e della sua politeia, della sua costituzione nell’intendimento aristotelico».
[xxxvi] In un assai approfondito studio sul filosofo greco condotto da O. HÖFFE e nello scenario più ampio e teoricamente pregnante del dibattito tedesco sulla riabilitazione della filosofia pratica, si rinviene la definizione della «Politica» come insuperato capolavoro della scienza politica ed insieme quale contenitore di dottrine – la formulazione centrale di una antropologia politica (I,2), gli inizi di una teoria economica (I ,3-13), i lineamenti di una sociologia politica, inclusa una patologia del politico, una teoria della democrazia che considera anche le conseguenze, in Aristotle, New York 2003, pag. 163.
[xxxvii] Analogamente O. HÖFFE, Aristotle, op. cit., pag. 167, trad. it. mia.
[xxxviii] Appare concludente richiamare in questo contesto quanto rilevato da Höffe nel suo studio su Aristotele in relazione all’amicizia e agli altri prerequisiti e limiti del politico, laddove l’insigne autore osserva come, dopo avere dato una risposta sorprendente alla domanda su chi uno dovrebbe amare di più, se se stesso o un altro – affermando che l’uomo buono dovrebbe amare se stesso ma l’uomo cattivo non farebbe così – Aristotele prosegue, con argomentazione che possiamo ritenere assai acuta e di perenne attualità e insieme scarsa comprensione, affermando che per l’uomo buono la propria felicità forma un’unità con quella degli altri; l’amico è un altro sè”, in O. HÖFFE, Aristotle, op. cit., pag. 171.
[xxxix] Esemplarmente, può essere richiamata l’argomentazione di Aristotele contro la tesi di Platone dell’anonimato delle relazioni per il conseguimento dell’unità come sommo bene, che, tratteggiata nel secondo libro della Politica evidenzia la naturalità della formazione delle comunità e dello stato quale molteplicità, specificando ulteriormente il senso dell’affermazione, compiuta nel primo libro, che «ogni città è un’istituzione naturale, se lo sono anche i tipi di comunità che la precedono», all’interno di un orizzonte volto definitivamente a conseguire lo scopo ed il fine dell’autosufficienza dell’individuo. In particolare, Aristotele afferma che la città «diventando sempre più unitaria, finirà con il non essere più nemmeno una città. Essa è per natura una molteplicità e procedendosi sempre di più sulla strada dell’unità diventerà da città famiglia e da famiglia uomo singolo, perché appunto si potrebbe dire che la famiglia è più unitaria della città e l’individuo più della famiglia. Sicché … questo processo non andrebbe intrapreso perché distruggerebbe la città». Parole che appaiono assai illuminanti anche in relazione all’attualissimo discorso sulla integrazione europea e allo stesso brano di Ortega Y Gasset, citato nel testo a conclusione del primo paragrafo, sulla coesistenza fin da principio di due dimensioni nelle nazioni e società europee, quella particolare e quella condivisa all’interno della cosiddetta civiltà europea.
[xl] Tra tanti, V. GOLDSCHMIDT, La théorie aristotelicienne de l’esclavage et sa méthode, Anversa 1973, rileva che «C’è una priorità naturale della Città sull’individuo, sebbene ci sia una genesi storica della Città a partire dall’individuo».
[xli] E’ questo il significato più profondo della libertà, e con esso, aggiungiamo noi, della stessa sussidiarietà che trova espressione e compimento ultimo nella cittadinanza, nel pensiero aristotelico, quale è evidenziato specialmente nelle pagine di Hannah Arendt, Leo Strauss, Eric Voegelin, primi teorici del movimento della Riabilitazione della filosofia pratica, particolarmente del già richiamato nucleo originario. Nelle magistrali pagine della Arendt, quella che ai fini della nostra ricerca possiamo definire l’originaria valenza naturalmente ascensionale della sussidiarietà si riconnette in particolare alla distinzione delle tre articolazioni della vita activa, l’attività lavorativa, l’operare e l’azione, a ciascuna delle quali corrisponde un aspetto della condizione umana: rispettivamente l’animal laborans, lo homo faber, lo zoon politikòn. Il passaggio, che è proprio del percorso della modernità, da un ordine naturale ad un ordine artificiale, si accompagna e contraddistingue per l’inversione della gerarchia all’interno delle articolazioni della vita activa. Sicché, il primato del soggetto si accompagna alla convinzione dell’uomo, in quanto homo faber, che la propria capacità di creare un mondo artificiale significhi che non c’è bisogno di nihil alterum, niente e nessun Altro, persino del Dio cristiano. Come segnala ancora la filosofa di Hannover, nel permanere del presupposto cristiano per cui «la vita, e non il mondo, è il bene più alto per l’uomo» ma nel contestuale smarrimento della fede, quale conseguenza della illimitata fiducia nelle proprie capacità, si determina la perdita di quel carattere di sacralità attribuita alla vita dell’uomo dal cristianesimo, sicché il bene più alto non è l’immortalità della vita ma la vita in sé. Questa nuova interpretazione pone le basi per la definitiva affermazione dell’attività lavorativa (animal laborans), cioè di quella sfera che non consente alcuna distinzione dagli animali e permette di realizzarsi solo in quanto organismo biologico, appunto attraverso la conservazione del bene ritenuto più prezioso: la vita nel suo ciclo biologico.
Agire non ha più il significato originario di dare inizio (dal greco archein che ha tale significato), l’uomo che ha di mira la sola conservazione e riproduzione della vita, si ripiega su sé stesso e determina progressiva estraneazione sociale e isolamento politico. Il capovolgimento dell’orizzonte della libertà, da libertà nella polis a libertà dalla polis, consente di affermare ancora con la Arendt, che oggi la «politica consiste in effetti nel pregiudizio verso la politica» ed è questo uno dei più radicali fattori di crisi dello stato moderno ed insieme il pericolo della democrazia. Ora, a ben guardare, è possibile parlare di sussidiarietà, quale tecnica di distribuzione di poteri e competenze, avendo riguardo a ciascuna delle dimensioni dell’esistenza, delle possibili scelte di vita individuate da Aristotele, e così anche della condizione di animal laborans. Ma il prezzo dell’abbandono della dimensione concettuale originaria è lo smarrimento della politica, la riduzione dell’individuo ad un simulacro e la costruzione di una sussidiarietà che non ha di mira se non la mera sopravvivenza terrena e così è depotenziata a una delle tante forme di mera socialità esistenti in natura, come quella delle api. E naturalmente ha perso ogni dimensione di valorizzazione della persona che è propria di ogni metafisica cristiana e con essa di ogni dottrina filosofica sociale della Chiesa e prelude al dono del passaporto per la Gerusalemme celeste.
[xlii] Così Aristotele: «Ammetto che l’unità di tutta una città nella sua totalità è il suo sommo bene – e anche Socrate assume questo principio -, per quanto sia evidente che essa, diventando sempre più unitaria, finirà con il non essere neppure più una città. Essa è per natura una molteplicità […] Sicché, se anche fosse possibile, questo processo non andrebbe intrapreso, perché distruggerebbe la città.
Per natura non esiste una città che abbia un’unità così stretta quale alcuni vogliono riscontrare in essa, e ciò che è presentato come il massimo bene delle città distrugge le città stesse in quanto tali, mentre il bene dovrebbe salvaguardare ciò di cui è bene. E d’altra parte è evidente che il tentare di ridurre troppo la città all’unità non è il partito migliore. La famiglia è più autosufficiente che l’individuo e la città più che la famiglia; e la città è veramente tale solo quando una massa di individui costituisce una comunità autosufficiente. Se dunque è preferibile ciò che può bastare a se stesso, allora anche ciò che è meno unitario è preferibile a ciò che lo è di più.».
[xliii] Obiezione contro Aristotele che tuttavia è superata da quanto lo stesso filosofo greco afferma in ordine all’origine della città in una concezione della natura che non è statica, come sembra ritenere Hobbes, ma dinamica: «Per natura, dunque, c’è in tutti lo stimolo a costruire una siffatta comunità: chi per primo l’ha fondata è stata la causa dei maggiori beni», in Aristotele, La Politica, I, 2.
[xliv] Per i quali si rinvia particolarmente sin d’ora alle considerazioni svolte da Höffe nel suo studio su Aristotele, laddove si segnala similmente a quanto qui sostenuto che: «L’obiezione più netta è quella di Hobbes. Dato che egli considera l’uomo meno un animale sociale che uno pronto al conflitto, egli vede le comunità politiche come “non semplici assemblee ma anche alleanze per la conclusione delle quali la lealtà e i contratti sono necessari” (De cive, I,1). Da ciò egli deduce la tesi opposta che lo Stato è creato non per natura ma per arte (Leviatano, Introduzione). […] – e proseguendo tra l’altro affermando che – l’uomo non poteva essere un animale politico perché le comunità politiche nascono solo in un momento relativamente più tardo nella storia. L’ultima, storica, obiezione è relativamente semplice da invalidare: essa imputa un concetto statico di natura mentre Aristotele usa un concetto dinamico. […] Aristotele non asserisce che gli uomini si sono sempre organizzati in città-stato […] Parlando di un uomo che fondò la polis, egli lo chiama origine di grandi beni. Così facendo egli procede in qualche modo verso la posizione di Hobbes. Aristotele concorderebbe con Hobbes che c’è un momento di arte, ma rigetta la nozione che la politica è artificiale nel senso di essere innaturale», in O. HÖFFE, Aristotle, op. cit. pag. 165-166.
[xlv] E’, come è noto, il tema del rapporto tra la libertà degli antichi e quella dei moderni su cui restano fondamentali per il pensiero moderno le analisi di A. TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Torino 1968 e J. STUART MILL, Saggio sulla libertà, Milano 1999, il quale in particolare evidenzia la preoccupazione per la libertà individuale di fronte alla progressiva uniformità delle masse cui condurrebbe la democrazia giacché: «Se tutti gli uomini, meno uno, avessero la stessa opinione, non avrebbero diritto di far tacere quell’unico individuo più di quanto ne avrebbe lui di far tacere, avendone il potere, l’intera umanità.»
[xlvi] E’ questo il segno del capovolgimento tra sfera privata e sfera pubblica; la modernità giunge progressivamente a ritenere che garantire la libertà dell’individuo significasse proprio tutelarne la sfera privata dalla non dovuta ingerenza del pubblico – convinzione che ha trovato forma costituzionale nella teoria delle libertà negative e che soprattutto è il segno della perdita di ogni prioritaria dimensione di dovere insita in una necessità di subsidium che giustifica e fonda la Polis nell’ordine naturale del pensiero filosofico e politico classico e nel pensiero cristiano – e che come rileva D. STERNBERGER, Il diritto dell’uomo ad aspirare alla felicità, in Immagini enigmatiche dell’uomo. Saggi di filosofia politica, op. cit., pag. 124 (nota 15) è significativamente presente già nei Commentaries di William Blackstone in un passo che deve essere annoverato tra le più importanti fonti dirette di Mason e di Jefferson.
[xlvii] Radici che, nel millenario albero che rappresenta il sistema filosofico e teorico politico e giuridico europeo, si innestano sulle antiche e sviluppano istanze di rivendicazione di spazi di autonomia ora individuali ora anche di associazioni e comunità minori – basti pensare al caso dei comuni in Italia.
[xlviii] Ragione per la quale ha luogo la considerazione critica di Foucalt che «la teoria politica è rimasta ossessionata dal personaggio del sovrano», deducendone conclusivamente l’illustre Autore che «Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non sia costruita intorno al problema della sovranità» e dunque, drasticamente, che «Bisogna tagliare la testa al re: non lo si è ancora fatto nella teoria politica», M. FOUCALT, Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di A. Fontana – P. Pasquino, Torino 1977, p. 15.
[xlix] Sicché, come ricorda anche M. MISTO’, La sussidiarietà quale principio ipotattico, op. cit., pagg. 67-68, a proposito del ruolo della sussidiarietà nella dottrina liberale dello Stato: «Il contributo del liberalismo alla teorizzazione del principio di sussidiarietà è stato valutato in modo differente, spesso antitetico, da parte degli interpreti: talora si è sostenuto che, in un sistema sociale razionalistico ed individualistico come quello liberale, il principio di sussidiarietà non può avere cittadinanza – come fa E. LINK, Das Subsidiaritätprinzip. Sein Wesen und seine Bedeutung für die Sozialethik, Friburgo 1955, p. 44; talaltra che il principio di sussidiarietà affonda le sue radici nella filosofia politica liberale, con la sua concezione negativa dello Stato e con la sua caratteristica Staatszwecklehre – come fanno tra gli altri, proprio in riferimento al discorso che riguarda l’Unione europea, H. LECHELER, Das Subsidiaritätprinzip: Strukturprinzip einer europäischen Union, Berlino 1993 e T. STEIN, Das Subsidiaritätprinzip als Strukturmerkmal der Europäischen Union, in W. HUMMER (a cura di), Die Europäische Union and Österreich, Vienna 1994, pag. 48 e ss. – sicché la dottrina sociale della Chiesa, e segnatamente l’enciclica papale Quadragesimo Anno, non avrebbero inventato, ma solamente riscoperto il principio di sussidiarietà – autorevolmente R. HERZOG, Subsidiarität, in H. Kunst (a cura di), Evangelisches Staatslexikon, Stoccarda 1966, pag. 3566 e ss.; R. HERZOG, Subsidiaritätprinzip und Staatverfassung, in Der Staat, 1963, 39, pag. 399 e ss; R. HERZOG, Allgemeine Staatslehre, Francoforte 1971, pag. 148 – talaltra ancora che “liberalismo e dottrina sociale della Chiesa s’incontrano proprio nel principio di sussidiarietà” – G. DAHM, Deutsches Recht: die geshichtlichen und dogmatischen Grundlagen des geltenden Rechts, Stoccarda 1963, p. 161 – e prosegue osservando infine che – A contrapporsi nettamente al cattolicesimo sociale, infatti, non è il liberalismo tout court, ma il liberalismo classico, che ammette in genere una sussidiarietà rigida dell’azione statale: così intesa, la sussidiarietà vincola lo Stato a garantire la sicurezza pubblica e la difesa dei consociati e si pone come un principio di libertà degli individui contro lo Stato stesso.».
[l] Sul tema, con specifico riferimento all’art. 4, paragrafo 2, e alle stesse disposizioni in materia di politica di coesione economica, si veda particolarmente N. PARISI, Identità europea e cittadinanza sociale nell’Unione europea. Alcune considerazioni sull’intreccio di fonti in materia di tutela dei diritti fondamentali, in L’Europa dopo Lisbona, op. cit., particolarmente pag. 142-143.
[li] Tra Nòmos e Lògos, tra Aristotele e s. Tommaso d’Aquino, se l’uomo fosse Dio starebbe ai margini della Polis terrena e attribuirebbe agli uomini la ben diversa cittadinanza della Propria Città celeste…
[lii] Come segnala J. KRISTEVA, Stranieri a se stessi, op. cit., pag. 87. Ora sembra legittimo interrogarsi a tale proposito, e rileva la non lieve problematicità del tema A.C. AMATO MANGIAMELI, ult. op. cit., pag. 165, su quale sia il legame che ci rende figli di una Patria anzitutto in dipendenza della nascita in un luogo piuttosto che in un altro, giustificando ciò stesso i vincoli che la comunità politica impone. Che il mero evento della nascita in un luogo debba essere considerato come criterio dell’appartenenza mi sembra peraltro assai dubbio ove solo si considerino le ipotesi estreme, e solo relativamente meramente teoriche, del concepimento in un luogo, della gestazione prevalente in un altro luogo, della nascita in un terzo e infine della vita in un altro ancora. O ancora, per altro verso, e al di là di ogni disciplina giuridica positiva e di ogni rapporto tra gli ordinamenti giuridici e le rispettive sovranità nazionali interessate, al caso della nascita in treno cinque minuti o dopo il passaggio di una frontiera e magari partorendo un gemello prima del passaggio e uno dopo lo stesso, anche in conseguenza di un passaggio a livello chiuso e quant’altro e in relazione alla possibilità di considerare, sul piano teorico, il treno stesso (o la nave o l’aereo) prolungamento del territorio dello stato – ma per l’aereo, ad esempio, si deve tenere presente che in alcuni stati vige il diritto del suolo. Sicché torna in mente a tale riguardo, e a sottolineare l’esigenza che sulle tematiche legate all’istituto della cittadinanza riprenda il dialogo tra i due fratelli nemici, a volere battezzare al modo di A. Kaufmann diritto positivo e diritto naturale, anche il caso descritto in un celebre film interpretato da Totò e Fernandel, La legge è legge (1958), per la regia di Christian-Jacque, nel quale la nascita del finanziere interpretato da Fernandel nella cucina di una casa posta al confine tra Italia e Francia ne fa un cittadino francese o italiano in dipendenza della linea di confine che per l’appunto passa per la cucina. E in dipendenza di tale incertezza, in fondo possibile nel paesino di confine di Assola dove il film è girato, deriva la perdita della cittadinanza, lo stato di diserzione e bigamia e la crisi esistenziale risolta dal lieto fine, che però è possibile solo perché la nascita era avvenuta alcuni metri più in là! Sul piano poi del diritto secondo il sangue, basti pensare alle nuove frontiere, per così dire aperte dalla tecnica, che si traducono in altrettanti dubbi. Penso al cosiddetto utero in affitto, per il quale ad esempio si ha notizia, in La Repubblica, 25 gennaio 2002, del caso di due gemelli, un maschio e una femmina, «concepiti» in Italia nel 1995, essendo… «italiani» tanto gli ovuli che gli spermatozoi , racchiusi in un contenitore a 200 gradi e tutti restituiti nel 2000, quando la coppia ha deciso di fare ricorso alla pratica dell’utero in affitto negli Stati Uniti; sicché i due bambini avranno diritti e doveri di cittadinanza tanto nei confronti degli Stati Uniti, dove vige notoriamente il diritto secondo la terra, che verso l’Italia, paese a prevalenza del diritto secondo la terra.
[liii] Come è noto, nella teoria politica di Carl Schmitt, la cittadinanza è legata alla decisione che fonda e costituisce l’unità politica dello stato rispetto alla quale, poi, straniero è ogni altro, che nel caso estremo di massimo grado di dissociazione è nemico ma comunque appartiene sempre alla comunità umana; però, è pure vero che affermando il fondamento personale dell’ordine Schmitt lascia poi alla decisione sovrana, quella che viene assunta nello stato di eccezione, e proprio per questo è sottratta in quanto tale ad ogni previa norma giuridica, il potere di decidere liberamente della stessa umanità di apolidi e appartenenti a minoranze: la legittimità di una norma giuridica trova infatti solo nell’ordine del nòmos basileus posto dal «re giusto» il proprio fondamento. Sicché torna in mente a tale proposito quanto suggerito da Platone per il quale invece «non l’uomo, ma un dio deve essere la misura di tutte le cose». Per altro verso, il normativismo kelseniano riduce anche il dato dell’appartenenza alla comunità a quello giuspositivistico di una dottrina pura del diritto, prescindendo dal dato antropologico che vorrebbe invece la comune identità civica all’interno di una medesima comunità politica discendere da una storia, un nucleo di valori, una cultura, una lingua e dall’esistenza di un progetto condiviso nelle linee fondamentali: «Un secondo “elemento” dello Stato, secondo la dottrina tradizionale, è il popolo, cioè gli esseri umani residenti nel territorio dello Stato. Essi vengono considerati una unità. Come lo Stato ha soltanto un territorio, così ha soltanto un popolo, e come del territorio è giuridica e non naturale, tale è pure l’unità del popolo», in H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, pag. 237-238. Si ha dunque una specificazione dell’elemento personale di validità dell’ordinamento solo in dipendenza della sfera territoriale di validità dell’ordinamento giuridico statale quale definita dall’ordinamento internazionale, il popolo coincidendo con i residenti nel territorio dello stato. Secondo quanto afferma E. RESTA, Contro la sovranità, in Sociologia del diritto, 1993, 1, pag. 200, Kelsen ha il merito di avere individuato: «il vero ‘compito infinito’ del giurista nel liberarsi con pazienza ed intelligenza proprio dell’idea di sovranità. Sullo sfondo di quel pacifismo non vi era soltanto l’idea di questo diritto internazionale, ma il modello di una civitas maxima; di una comunità, appunto, che mai come in questo caso attraversa e supera, ‘trascende’, le strutture politiche nazionali; sicché la cittadinanza intesa come elemento essenziale dello stato è un obbiettivo critico della costruzione kelseniana.». Ed è certo vero che l’illustre Autore segnala il fatto che vi sono istituti del diritto internazionale che la presuppongono (extraterritorialità) e ordinamenti che dalla attribuzione dello status di cittadino fanno discendere diritti e doveri specifici ma lega e subordina tale mera eventualità all’esistenza di una norma di diritto positivo in quel certo ordinamento, non essendo per contro la cittadinanza un istituto di alcuna importanza «quando un ordinamento giuridico statale non contiene alcuna norma che, secondo il diritto internazionale, sia applicabile ai soli cittadini», in H. KELSEN, op. ult. cit., pag. 246. E’ evidente, tuttavia, che proprio un tale procedere provoca anzitutto di fatto la con-fusione dello straniero e dell’apolide, del cittadino di uno stato straniero e di colui che non è cittadino di alcuno stato: vero è ancora che d’altra parte il giurista austriaco sottolinea che gli stessi diritti politici «non devono essere necessariamente riservati ai soli cittadini» e che quanto alla protezione, che sarebbe oggetto di un diritto del cittadino esigibile nei confronti dello stato di appartenenza, il fondatore della Scuola di Vienna sostiene che «il diritto del cittadino alla protezione non ha altro contenuto all’infuori dei doveri che l’ordinamento giuridico impone agli organi dello Stato nei confronti dei cittadini» (pag. 242). Ma questo lascia il suddito e il suo sentimento di appartenenza in balia della norma e quest’ultima in balia della decisione legislativa che le sta dietro. A nulla vale in tale senso, e nella coerenza formale della costruzione kelseniana, osservare che i diritti politici, e si potrebbe ritenere anche la possibilità giuridica di partecipare alla creazione o all’esecuzione delle norme giuridiche, vale a dire alla formazione ed espressione della volontà dello Stato, «non devono essere necessariamente riservati ai soli cittadini [e che l’ordinamento giuridico nazionale] può concedere i diritti politici a non-cittadini». Perché è altrettanto vero, così ragionando, che è ben possibile che i diritti politici siano riservati a certe classi di cittadini più o meno ampie, come pure kelsen ricorda a proposito della legge germanica del 15 settembre 1935, laddove si distinguono cittadini e nazionali: «Secondo la legge germanica del 15 settembre 1935 godono di pieni diritti politici soltanto le persone di “sangue germanico o affine”. Queste persone sono dette «cittadini» (Staatsbuerger), mentre le altre sono dette “nazionali” (Staatsangehorige)». E che la decisione sovrana nello stato di eccezione o quella legittimata da una costruzione a gradi dell’ordinamento ben possono condizionare ogni successiva formazione della volontà dello Stato modificando la composizione del popolo di cittadini con provvedimenti di snaturalizzazione adottati per emarginare dai confini della Polis dissidenti e minoranze, così impossibilitati a partecipare al processo di formazione decisionale. Come ricorda Hannah Arendt a proposito dell’anomalia giuridica degli apatridi e dell’attenzione tardivamente dedicatale: «la privazione in massa della cittadinanza era una cosa assolutamente nuova e imprevista. Essa presupponeva una struttura statale che, se non ancora completamente totalitaria, non tollerava alcuna opposizione e preferiva perdere dei cittadini piuttosto che albergare nel suo senso dei dissenzienti.»
[liv] Ferite che peraltro rivelano qualcosa di latente nella storia della sovranità nazionale, come rileva Hannah Arendt: «le sovranità dei paesi limitrofi potevano entrare in un conflitto implacabile anche in tempo di pace … la piena sovranità nazionale era possibile solo finché sussisteva il concerto delle nazioni europee; era infatti questo spirito di spontanea solidarietà e tacita intesa che vietava ad ogni governo il pieno esercizio del suo potere sovrano. Teoricamente, nella sfera del diritto internazionale, allo stato era sempre stata riconosciuta una sovranità assoluta in materia di “emigrazione, naturalizzazione, nazionalità ed espulsione”; ma considerazioni pratiche e la constatazione della comunanza di interessi ne avevano frenato l’esercizio fino all’avvento dei regimi totalitari. Si è quasi tentati di misurare il grado d’infezione totalitaria di un governo dall’uso fatto della privazione della cittadinanza … Va tuttavia ricordato che quasi tutti i paesi del continente adottarono nel periodo fra le due guerre una legislazione formulata in modo da consentire l’espulsione dei cittadini sgraditi al momento opportuno. … Quel che è peggio … ora si è giunti al punto in cui persino dei paesi democratici come gli Stati Uniti hanno a un certo momento esaminato la possibilità di privare della cittadinanza gli americani comunisti», in H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, op. cit., pag. 387-389.
[lv] Osserva ancora a tale riguardo H. ARENDT, in ult. op. cit., pag. 389: “«Ma, per rendersi conto delle vere implicazioni dell’apolidicità, basta ricordare l’estrema cura con cui i nazisti insistevano affinché gli ebrei non tedeschi perdessero “la loro cittadinanza prima del trasporto o al più tardi il giorno della deportazione!” (nota 26: la citazione proviene da un ordine del Hauptsturmführer Dannecker, datato 10 marzo 1943 e concernente la «deportazione di 5.000 ebrei dalla Francia, quota 1942». Il documento … fa parte dei «Documenti di Norimberga», RF 1216. Analoghe disposizioni vennero emanate per gli ebrei bulgari). Per gli ebrei tedeschi ciò non era necessario perché nel Terzo Reich una legge li privava automaticamente della cittadinanza appena lasciavano il territorio nazionale, anche se naturalmente perché deportato in un Lager polacco.». I giorni a noi più vicini, peraltro, ci suggeriscono di considerare come la disciplina positiva e la maggiore disponibilità nei confronti dell’apolidia induca a superare le barriere dell’estraneità proprio attraverso una strumentale acquisizione dello status di apolide: basti a tale riguardo fare riferimento agli anni Novanta, quando molti cittadini romeni rinunciavano alla cittadinanza per potere, in Germania, godere dello status di apolidi, assai più conveniente perché li salvaguardava da provvedimenti di espulsione sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto degli apolidi che subordinava la possibilità di simili provvedimenti alla esistenza di motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
[lvi] H. ARENDT, ult. op. cit., pag. 374.
[lvii] Se poi, in definitiva, è cittadino chi viene qualificato come tale da parte dello stato nazionale e dunque la cittadinanza è rimessa alla volontà di ciascun sovrano o di ciascun ordinamento giuridico nazionale, allora si può dare il caso del “cittadino conteso”, vale a dire di chi sia cittadino secondo più ordinamenti giuridici ma anche quello di chi non si veda attribuita alcuna cittadinanza. E se, in definitiva, è proprio la volontà sovrana a testimoniare, o meglio ad affermare, una appartenenza alla comunità umana altrimenti discutibile, allora ben si comprende che un progetto perverso come quello nazista potesse trovare attuazione attraverso una snazionalizzazione che affidasse agli altri stati nazionali europei l’onere di garantire i diritti umani a quanti, significativamente, vennero definiti non più semplicemente apolidi – termine che significativamente e più di ogni altro termine del vocabolario politico mantiene il collegamento semantico-concettuale con la polis – ma indesiderabili: «Gli apolidi e le minoranze, giustamente definiti “primi cugini”, non avevano un governo che li rappresentasse e li proteggesse, e perciò erano costretti a vivere o sotto la legge eccezionale dei trattati sulle minoranze … o fuori di qualsiasi legge, alla merce della tolleranza altrui. … La snazionalizzazione divenne un’arma efficace della politica dei governi totalitari, e l’incapacità costituzionale degli stati nazionali europei a garantire ai perseguitati i diritti umani più elementari consentì a quei governi di imporre all’estero i loro criteri. Quelli che i persecutori cacciarono dal paese come schiuma della terra – ebrei, trockisti, ecc. – vennero dovunque ricevuti come tali; quelli che erano stati definiti indesiderabili divennero gli indésiderables d’Europa. L’organo ufficiale delle SS, lo “Schwarze Korps”, affermò esplicitamente nel 1938 che, se il mondo non era ancora convinto che gli ebrei erano la feccia dell’umanità, si sarebbe ricreduto quando una schiera di mendicanti non i dentificabili, senza nazionalità, senza denaro, senza passaporto, avrebbe ben presto attraversato i confini», in H. ARENDT, ult. op. cit., pag. 374-375
[lviii] Assai significativo, a tale proposito, quanto osserva N. PARISI, Identità europea e cittadinanza sociale nell’Unione europea. Alcune considerazioni sull’intreccio di fonti in materia di tutela dei diritti fondamentali, in L’Europa dopo Lisbona, op. cit., pag. 140, la quale sottolinea come proprio grazie a tale allentamento del «rapporto di cittadinanza (segno distintivo dello Stato-nazione) a motivo dell’appannarsi del collegamento persona-territorio nazionale, si è … affiancato ad esso e si va irrobustendo un rapporto di cittadinanza fondato sulla qualità di persona, un rapporto dunque capace di prescindere dai tradizionali momenti di collegamento (il sangue, il territorio), per avere invece a baricentro un fascio di diritti inerenti alla dignità della persona, costruiti intorno al principio di eguaglianza».
[lix] Al punto che J. HABERMAS segnala come «A comandare ora non è più chi ha la “sovranità sul territorio” bensì chi dispone della “velocità superiore”», in La costellazione postnazionale, Milano 2002, pag. 40.
[lx] Per le quali pure è confermata la profonda attualità dell’analisi di H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Milano 1964. Sul tema si veda anche H. JONAS, Il principio responsabilità, Torino 1990, con particolare riferimento alle nuove dimensioni della responsabilità di fronte ad una tecnica che è potenzialmente capace di condurre alla distruzione della vita sul nostro pianeta.
[lxi] C. SCHMITT, La condizione della scienza giuridica europea, Roma 1996, pagg. 57 ss. .
[lxii] Cfr. T. HELD, Democrazia e ordine globale. Dallo stato moderno al governo cosmopolitico, trad. it., Trieste 1999, pag. 126 ss., per il quale anche se ciò non incide in maniera diretta sul diritto di uno stato di governare sul proprio territorio, cioè sul diritto di sovranità, tuttavia «lascia comunque gli stati nazionali esposti e vulnerabili nei confronti delle reti di forze e rapporti economici che si estendono entro gli stati e tra una nazione e l’altra, ridefinendone la forma e la capacità». Così che l’idea e la logica della democrazia sono minacciate «dall’interdipendenza nazionale e internazionale delle decisioni e dei risultati politici» e «dai limiti imposti dalla rete di organizzazioni regionali e globali emergenti al controllo che una nazione esercita sul proprio destino.».
[lxiii] Secondo la definizione di Z. LAÏDI, Malaise dans la mondialisation, Paris 2001.
[lxiv] E incidono profondamente, lo si ribadisce e sottolinea, sull’istituto della cittadinanza quale linea di confine che definisce (o definiva…?) le identità attraverso i «contrassegni» dell’appartenenza e dell’estraneità.
[lxv] Certo, si potrebbe dire, che anche qui si scopre il cosiddetto segreto di Pulcinella, la nota ipocrisia su cui si costruisce la teoria della sovranità del teorema di S. KRASNER, Sovereignty: organised hypocrity, Princeton, NJ 1999, il quale prevede quattro accezioni della sovranità statale, che individuano altrettante dimensioni del potere sovrano unitario dello stato: sovranità internazionale legale, caratterizzata dal mutuo riconoscimento di indipendenza degli stati; sovranità di Westfalia, contraddistinta dall’esclusione dell’influenza di attori esterni negli affari interni di uno stato; sovranità domestica, consistente nella organizzazione dell’autorità politica all’interno del territorio; sovranità interdipendente, quale capacità di regolare tutti i flussi transfrontalieri. Emerge chiaramente un dato fondamentale: il modello di sovranità esclusiva, quale si sostanzia nella compresenza di queste varianti della sovranità, è di assai problematica individuazione nella storia. La sovranità secondo Westfalia e la sovranità internazionale legale in particolare hanno subito violazioni tanto crude (invasioni) che più sottili (per esempio proprio l’imposizione del rispetto di certi standards, come avviene per il regime dei diritti umani, per il riconoscimento della propria statualità nella comunità internazionale); ragione per cui di sovranità deve parlarsi, come denuncia lo stesso sottotitolo del lavoro di Krasner, come di una ipocrisia organizzata.
[lxvi] Ma, verrebbe da domandarsi, tutto questo non è in fondo già accaduto in luoghi più ristretti, conosciuti, a velocità ridotte e dove l’identità dello homo oeconomicus non interagiva con quella tecnologica postmoderna? E Bretton Woods, non è il luogo di una decisione sovrana, quella americana, che garantisce l’ordine del mercato monetario internazionale e con essa prova a ricondurre ad unità le dinamiche identitarie del liberalismo economico e delle stesse politiche nazionali occidentali, assumendo il dollaro come valuta di riferimento per il sistema di produzione capitalistico internazionale e così in fondo intervenendo pure se con finalità garantiste negli affari interni di tutti gli altri stati sovrani del sistema. E’ chiaro infatti che tale ordine vedeva di fatto negli Stati Uniti il punto di riferimento delle decisioni economiche sovrane. Tanto da permettere, pure tra le proteste di Francia e Germania, una incontrollata emissione di moneta da parte degli stessi ed importare così le dinamiche inflattive dell’economia statunitense, ripartendole sugli altri sovrani…
Solo che ora, come ha chiaramente evidenziato da ultimo in maniera assai efficace, e insieme già ad oggi divenuta drammatica, la recente vicenda dei mutui subprime americani, allo stato sovrano sono state sottratte, come si accennava, non solo la leva della fiscalità, per la impossibilità di colpire i grandi patrimoni sovrannazionali delocalizzati, con evidente ricaduta in termini di crisi della forma di stato sociale; ma anche, e per lo più conseguentemente, quella della capacità di elaborazione di politiche economiche che garantiscano gli equilibri sociali e con essi le dinamiche identitarie individuali e collettive all’interno dei processi integrativi. Delle quali avanza invece una nuova dimensione virtuale che rischia di ridurre la libertà del Politico ad un codice binario…!
[lxvii] Tema che, pure nella sua connessione con gli argomenti che sono oggetto di questo studio, resta ai margini della mia trattazione e cui si può dunque solo accennare. Appare comunque da affidare a specifici approfondimenti, in particolare, il problema della possibilità di con-fusione tra realtà e virtualità in relazione alla accelerazione che le tecnologie informatiche e cibernetiche per un verso permettono ma per l’altro impongono alle decisioni. Penso, esemplificativamente, alle indicazioni che le banche fanno presenti alla loro clientela abilitata al trading on line, più o meno nei termini che seguono e che fanno riferimento alla comunicazione Consob n. 30396 del 1 aprile 2000 a tutela della libertà e consapevolezza degli operatori del mercato finanziario: «la modalità di esecuzione “on line” può indurre a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva “intraday”». Non vi è dubbio, infatti, che assumere decisioni il cui contesto procedurale virtuale è dato dal passaggio da una schermata all’altra solleciti i tempi di definizione del contesto di riferimento e di scelta della opzione, della quale peraltro tante volte si registra la riduzione della complessità attraverso la predisposizione di opzioni alternative che la riducono significativamente secondo la logica del si/no che pare riprodurre l’elementare codice binario che fonda la logica dei sistemi informatici. Sicché ne risulta posta a rischio la prudenza (phronesis, come attitudine pratica a stabilire secondo ragione ciò che è bene e male nell’agire concreto) che dovrebbe orientare delle decisioni informate a quel principio di responsabilità che secondo l’insegnamento di Jonas deve accompagnarsi all’agire umano nella società tecnologica postmoderna. Secondo dinamiche che sembrano in grado di ridurre significativamente la razionalità umana anche nel caso di (mere) decisioni a carattere operativo, che pure richiederebbero una preliminare decisione sull’an, in una successione che tuttavia è anch’essa influenzata dalla contrazione dei tempi della fase decisionale.
[lxviii] Sul tema si vedano ex multis: U. DRAETTA, Diritto dei contratti internazionali, Padova 1984 e F. GALGANO, Lex Mercatoria, Bologna 1993.
[lxix] Che è simbolo metaforico del movimento continuo, quale trova peraltro segno concreto nelle leggi della fisica e della geografia astronomica nei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra, intorno a se stessa e all’altro ( il sole).
[lxx] E insieme le moderne forme di comunicazione propongono persino nuove dinamiche integrative ai confini tra reale e virtuale che sovrappongono alle separate Poleis nazionali quella, unita, nella sola diversità dei luoghi da cui vi si accede, dalla comune e condivisa umanità dei «visitatori-cittadini», di Second life. Sino a che punto è possibile che attraverso la techne il globale sia addivenuto alla costruzione di una nuova forma, di una nuova idea di cittadinanza? … Una Neapolis nella quale la porta sia aperta a tutti ma qualsiasi definizione di identità è… virtuale? E quali problemi ciò pone, pure solo nella interazione tra processi identitari individuali e collettivi virtuali e formazione di nuove dinamiche identitarie globali, all’idea della politica quale espressione naturale della capacità dell’uomo di agire e di fare discorsi, lungo quel filo che connette tali capacità al senso autentico della libertà? E quali orizzonti apre, ancora, nell’adozione progressiva di un linguaggio unico, la costruzione di un popolo unito, secolarizzato e tuttavia come quello che la genesi descrive prima della confusione delle lingue? Ma è un’antropologia… virtuale…
[lxxi] In questo senso, anche in relazione all’interrogativo se l’Europa abbia una propria identità, v. G. CARELLA, La famiglia transnazionale fra conflitti di civilizzazione e diritti umani, Relazione al XIV convegno SIDI, Bari 19 giugno 2009, in corso di pubblicazione per i tipi dell’Editoriale scientifica, Napoli.
[lxxii] Su tale tema, si veda il fondamentale studio realizzato da T. TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’ «altro», Torino 1992, sulla scoperta che l’io fa dell’altro e sulla forbice che descrive l’approccio europeo alla diversità: tra differenza che si traduce in ineguaglianza e uguaglianza che si trasforma, appunto attraverso l’assimilazione, in identità.
[lxxiii] Che si sono tradotte in altrettanti limiti e ferite alla sovranità nazionale degli stati, la cui adesione all’Europa è stata sottoposta alla condizione di un pre-giudizio da parte del sovrano ordinamento europeo e della decisione per esso espressa a livello intergovernativo da esponenti politici ciascuno portatore di interessi nazionali. E basti pensare all’esempio dell’adesione della Turchia, oggetto di tante discussioni e certo fortemente condizionato dal benestare degli Stati Uniti affermato agli alleati europei o, prima ancora, alla vicenda polacca. Ne risulta confermata la tesi della sovranità come ipocrisia organizzata, già richiamata precedentemente, rispetto alla quale lo stesso istituto della cittadinanza ed il senso del problematico rapporto tra ordinamento giuridico e volontà politica sono ampiamente condizionati. Basti a tale riguardo porre mente ai casi in cui, pure muovendo da vicende di diritto privato quali separazioni tra coniugi di diversa cittadinanza, il sostegno della comunità politica di rispettiva appartenenza diventa decisivo ai fini della definizione dell’ordine per il caso concreto.
[lxxiv] Sul tema, è interessante il documento di lavoro sull’elezione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2008 predisposto dalla Commissione per gli affari costituzionali (relatore l’on. Andrew Duff) nel quale si sottolinea la mancanza di una definizione unitaria di cittadinanza europea e invece l’esistenza di ventisette varianti nazionali e si segnala il fatto che l’Unione europea non ha compiuto alcun tentativo di armonizzare tali leggi. Tuttavia, proseguendo, lo stesso documento segnala che «la Corte di giustizia europea ha affermato che il diritto degli Stati membri di definire regole proprie in merito all’acquisizione o alla perdita della cittadinanza incontra il limite della necessità di rispettare il diritto UE. (cfr., per esempio, la causa C-369/90 Micheletti [1992] Racc. I-4239)», con evidente riferimento anzitutto al principio di non discriminazione in relazione alle disparità tra le normative in materia di acquisto della cittadinanza tra i residenti aventi la cittadinanza di paesi terzi o gli apolidi a seconda del loro stato di residenza. Per quanto poi riguarda in particolare la materia di diritti elettorali, la Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, relazione che come è noto la Commissione deve presentare ogni tre anni al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo a tenore dell’art. 22 del trattato CE in merito all’applicazione delle disposizioni della parte seconda del trattato CE relativa alla cittadinanza dell’Unione, rileva che nella sentenza del 12 settembre 2006 (Cause C-145/04 Spagna/Regno Unito e C-300/04 Eman e Sevinger) la Corte di Giustizia ha sottolineato che in atto spetta agli Stati membri disciplinare gli aspetti della procedura elettorale non armonizzati a livello comunitario e specialmente indicare i titolari del diritto di voto e di eleggibilità; tuttavia, si precisa che essi sono tenuti nell’adempiere a tale obbligo a rispettare il diritto comunitario, inclusi i principi generali e quindi anche qui di evitare disparità di trattamento, salvo che tale disparità sia giustificato obiettivamente.
[lxxv] Che possono muovere semplicemente da contingenti logiche elettoralistiche, per l’orientamento politico progressista o conservatore delle maggioranze di governo e la conseguente considerazione dei postulanti la cittadinanza come potenziali votanti a proprio favore o sfavore. Su altro piano, poi, si pongono, ma mi pare opportuno segnalarlo, le naturalizzazioni di atleti la cui appartenenza alla comunità politica e relativa identificazione sostanziale con la storia e l’identità nazionale di riferimento è per lo più sacrificata al valore simbolico politico, di unificazione nazionale, delle prestazioni sportive nelle competizioni internazionali.
[lxxvi] Documento nel quale si legge tra l’altro, nei considerando: «l’Unione europea e le sue istituzioni hanno un interesse legittimo ad avanzare proposte concernenti l’acquisizione della cittadinanza degli Stati membri, nel rispetto della loro sovranità in materia, dato che, quando uno Stato membro concede o nega la cittadinanza a una persona, concede o nega anche la cittadinanza dell’Unione»
[lxxvii] M. ASERO, Una nessuna o centomila…? Sussidiarietà: la parola che ha salvato Maastricht e l’Europa di Lisbona, op. cit., pag. 170-171.
[lxxviii] E’ altresì risaputo che proprio per questa ragione l’Italia ha protestato alla Conferenza intergovernativa di Lisbona, ottenendo in definitiva l’assegnazione di un seggio residuo (e passando così ad avere assegnati da 72 a 73 seggi).
[lxxix] Se si tiene presente quanto abbiamo cercato di sostenere in relazione alle implicazioni più profonde della tematica delle radici cristiane in ordine al rapporto tra io e l’altro, tra identità individuali e collettive, che nella sensibilità e nel disegno cristiano non conoscono fratture ontologiche (per le quali si rinvia a quanto osservato sopra nella nota 7), sembra doveroso fare riferimento in particolare alle affermazioni dell’attuale Presidente del consiglio, on. Silvio Berlusconi, il quale dopo avere affermato nell’attuale campagna per le europee che «Roma è sporca, sembra l’Africa» ha sottolineato pochi giorni dopo a Milano a chiusura della campagna per le Provinciali (per le quali, com’è noto, si voterà lo stesso giorno delle europee) del centro destra «Non posso accettare che quando circoliamo nelle nostre città ci sembra di essere … in una città africana e non in una città europea per il numero di stranieri che ci sono… C’è chi vuole una società multietnica e multicolore ma noi non siamo certo tra questi», R. SALA – Z. DAZZI, Repubblica, 4 giugno 2009. A parte il curioso dato che le amministrazioni di ambedue le città sono attualmente del Partito delle libertà, va sottolineato come entrambe le espressioni non sembrano in linea con quel rispetto della dignità di ogni uomo che è radice europea in Cristo e con Lui anche nelle altre delle quattro colonne che fondano Roma… e l’Europa. E, invece, paiono perfettamente in linea con quelle logiche propagandistiche, e nella specie in particolare di competizione con l’elettorato della Lega, e le abituali affermazioni di analogo tenore del suo leader Bossi, per una competizione ulteriore, tutta interna alla attuale maggioranza politica nazionale, che davvero poco, se non proprio nulla, ha a che fare con l’Europa e con l’interesse dei cittadini europei, non solo italiani… Sui temi della dignità che è di ogni uomo che portano ad individuare nell’integrazione l’unica strada veramente umana nelle politiche migratorie, peraltro, appare assai autorevolmente concorde il cardinale D. TETTAMANZI, Repubblica, 7 giugno 2009.
[lxxx] Vale a dire tra il suggerimento che «non l’uomo, ma un dio deve essere la misura di tutte le cose» e il re che invece è egli stesso misura delle cose…
[lxxxi] O del dissenso… Circostanza quest’ultima che non è estranea, ad esempio, all’evento dei referendum popolari svoltisi in Francia e in Olanda in ordine al futuro trattato europeo e che non sembra avere tanto avuto di mira lo stesso quanto piuttosto l’attuale Unione e certa sua politica economica, secondo quanto osserva P. BILANCIA, Principio di sussidiarietà e ruolo delle autonomie nell’Unione europea, in Nomos 2005, pag. 286. Tanto ci sarebbe in tal senso da considerare sulla «democraticità sostanziale» di tali consultazioni in relazione al livello di informazione dei «cittadini europei» della Francia e dei Paesi Bassi, chiamati ad esprimere il loro voto, ed alla strumentalizzazione che attraverso l’uso del potere di informare, o meglio di orientare l’informazione, sarebbe stata fatta tanto dei votanti che di quanti hanno conseguentemente optato per l’espressione «politica» del dissenso attraverso l’astensione, secondo una prospettiva critica non del tutto infondata e come potrebbe peraltro rilevarsi problematicamente in genere in relazione allo strumento referendario. Questo esprimerebbe allora l’esercizio di una sovranità per più versi solo “apparente”… Su tali temi, resta di grande utilità, per un’adeguata costruzione dello strumentario concettuale indispensabile per una analisi critico-scientifica, la lezione sui presupposti teorici che conducono alla tecnicizzazione della prassi attraverso la disciplina scientifica dei mezzi della comunicazione pubblica nell’età della sofistica, su cui si veda R. BUBNER, Azione linguaggio e ragione. I concetti fondamentali della filosofia pratica, Bologna 1985.
[lxxxii] Va peraltro rilevato che già con documento n. 14615/04, il Consiglio aveva adottato i principi fondamentali comuni della politica di integrazione allo scopo di aiutare gli Stati membri a formulare le politiche di integrazione. In particolare, uno di tali principi affermava che la partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle misure di integrazione ne favorisce l’integrazione. Ancora, va ricordato che nel 2005 la Commissione ha adottato una «Agenda comune per l’integrazione», la quale propone una serie di misure per mettere in pratica i principi fondamentali comuni, in COM(2005) 389. In particolare, come pure ricorda la Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, la Commissione vi suggeriva proprio la elaborazione di programmi nazionali di naturalizzazione e di preparazione alla cittadinanza e comunque l’incentivazione, a livello dell’Unione, della ricerca e del dialogo sulle questioni di identità e cittadinanza. Cosa che in qualche misura anche questo studio intende in fondo fare…
[lxxxiii] Opportuna appare in tale ambito il prudente suggerimento del documento di lavoro sull’elezione del Parlamento europeo predisposto dalla Commissione per gli affari costituzionali (relatore l’on. Andrew Duff) già richiamato a tenore del quale: «Indipendentemente dall’esito delle deliberazioni del Parlamento in merito alla scelta tra abitante e cittadino quale base statistica per la distribuzione dei seggi in Parlamento, potrebbe essere prudente aggiungere una clausola all’Atto, che preveda un riesame regolare dell’effettiva distribuzione nel corso di ogni legislatura parlamentare.». Una tale preoccupazione sembra in grado di procedere nella duplice direzione di rendere effettiva la rappresentatività nazionale in seno all’organo rappresentativo dell’Unione e insieme promuovere virtuosi percorsi di integrazione all’interno delle frontiere dell’Europa, secondo logiche che potranno essere aperte ad un più pieno recupero dell’identità europea oltre ogni frontiera e facendo riferimento alla cittadinanza come progetto comune di collettività umane aperte all’inclusione – come si dirà meglio nel testo in sede di prospettazione delle conclusioni di questo studio.
[lxxxiv] Fenomeno dell’apolidia che a tutt’oggi è però lungi dall’essere risolto. Eppure la Convenzione europea sulla nazionalità di Strasburgo (1997), che conteneva all’art. 4 le proclamazioni dei principi generali in materia, il diritto alla cittadinanza, il conseguente divieto di privare arbitrariamente chiunque della propria cittadinanza e la proclamazione che l’apolidia deve essere evitata, e la successiva Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta all’apolidia in relazione alla successione statale hanno costituito un quadro giuridico per evitare l’apolidia. Tuttavia, per quanto in diminuzione, l’Unione europea continua ad ospitare un numero consistente di apolidi i quali sono dovuti principalmente alla dissoluzione dell’Unione sovietica e della ex Iugoslavia. Casi nei quali, a seguito del riconoscimento da parte della comunità internazionale di uno o più nuovi Stati, si sono create situazioni di apolidia derivata per il mancato riconoscimento automatico della cittadinanza da parte delle istituzioni del nuovo Stato. Basti pensare in proposito alla nuova legge della Repubblica dell’Azerbaijan, ex Repubblica Socialista Sovietica Azera, sulla cittadinanza, per la quale sono cittadini le persone registrate come residenti nel territorio dello Stato al momento della sua entrata in vigore (1998); e le persone che non erano cittadini azeri, né di altro Stato, ma risiedevano all’1 gennaio 1992 nel territorio dello Stato. E’ pertanto divenuto apolide, ha perso la propria appartenenza alla Polis e insieme la propria identità, nei processi nomodinamici che hanno descritto il passaggio dall’ordinamento sovrano della Repubblica Socialista Sovietica Azera a quello della Repubblica dell’Azerbaijan e in particolare dall’unità personale dell’uno a quella dell’altro, chi pur nato nel territorio dell’Azerbaijan ed essendo stato cittadino azero, non soddisfi i requisiti sopra richiamati.
E va ricordato che la Commissione afferma esplicitamente, da ultimo nella Quinta relazione sulla cittadinanza dell’Unione del 15 febbraio 2008, pag. 3, di essere «consapevole delle questioni riguardanti gli appartenenti alla minoranza russofona in Estonia e in Lettonia, considerati “non cittadini”, e della situazione delle persone “cancellate” in Slovenia», ciò che evidentemente conferma la perenne attualità di una seria indagine sul senso della cittadinanza e dell’apolidia all’interno di quella, più ampia, che è politica, giuridica, culturale e in una parola antropologica sull’identità dell’uomo tout court..
[lxxxv] E quanto sa di sale, per completare la citazione di DANTE, La Divina Commedia, Paradiso, XVII, 58-60.
[lxxxvi] Secondo quanto contenuto nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, cit., pag. 5. Lo stesso documento, pag. 6, invita peraltro la Commissione ad «elaborare un libro bianco sulle possibili evoluzioni della cittadinanza dell’Unione e sull’armonizzazione delle varie norme vigenti negli Stati membri». A questo proposito, si devono ricordare le perplessità espresse particolarmente da Green in ordine alla debolezza dell’ipotesi della costruzione di uno spazio pubblico europeo, che è evidentemente momento dinamico di integrazione personale, per la mancanza di una lingua comune. Sicché a tale proposito, ci sarebbe da richiamare quanto pure sopra (in particolare alla nota 7) si è detto sulla confusione delle lingue narrata nel racconto della Genesi e sul momento della Pentecoste in cui, pure nella perdurante diversità dei linguaggi, il messaggio veniva inteso dagli uomini di tutti i popoli (e lingue) per virtù dello Spirito Santo. In altre parole, la diversità linguistica è presupposte perché la percezione della stessa essenza delle cose e l’esperienza di vita abbiano nomi e con essi percorsi di identificazione a quelli sottesi diversi. La riduzione delle lingue condurrebbe pertanto ad una omologazione e dunque il suggerimento andrebbe correttamente inteso nella direzione della elaborazione di una nuova lingua comune, frutto delle valenze semantiche e concettuali, delle esperienze ed identità culturali, giuridiche, politiche e antropologiche tout court di tutti i popoli che la fondassero. In questa direzione, appare opportuno ricordare, anche a prescindere dall’ipotesi di una lingua comune per la cui diffusione potrebbe essere funzionale, il ruolo fondamentale della televisione nella creazione e formazione di identità collettive. L’esperienza italiana è emblematica in tale direzione, giacché fatta l’Italia si è probabilmente dovuto attendere sino all’avvento della televisione per fare gli italiani, unificando i dialetti e progressivamente le tradizioni e i valori collettivi. Sicché sembrerebbe opportuno realizzare anche una televisione dell’Unione la quale possa procedere nella stessa direzione, promuovendo la diffusione dei valori e delle identità che compongono nella loro diversità il patrimonio europeo. Infine, e a riprendere opportunamente l’insegnamento di R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, Milano 1988, in ordine alla concorrenza delle tre forme di integrazione attraverso cui si realizza l’integrazione politica statale, si segnala l’opportunità di alimentare le dinamiche integrative dell’Unione in tutte e tre le direzioni. Assai rilevante è in tale direzione che la logica anticostituzione che ha animato il trattato di Lisbona abbia prodotto la cancellazione del riferimento alla bandiera con le 12 stelle d’oro in campo blu, dell’Inno alla gioia e del motto Unità nella diversità! quali simboli ufficiali e che, nella consapevolezza più matura del significato delle rappresentazioni simboliche all’interno dei processi integrativi e dei connessi percorsi di maturazione delle identità collettive, la Germania si sia fatta promotrice di una dichiarazione allegata al testo del trattato (la numero 52), con la quale 16 Stati membri, tra i quali l’Italia, hanno affermato che per essi la bandiera con le 12 stelle d’oro in campo blu, l’Inno alla gioia e il motto Unità nella diversità! «continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all’Unione europea e del loro legame con la stessa». Sicché, anzi, mi pare che la stessa realizzazione di una televisione europea costituirebbe una nuova forma cui affidare la prosecuzione del processo di integrazione e ad un tempo la sua rappresentazione simbolica; ma altre forme le si dovrebbero accostare, avvicinando progressivamente le diverse manifestazioni della cultura, dell’arte, dello sport, dell’estetica degli uomini europei. E così, mi sembra, si dovrebbero promuovere un campionato di calcio europeo, che probabilmente potrebbe essere assai utile ad una così nobile e importante causa di formazione e aggregazione del demos europeo, ma anche festivals canori e letterari, cui dare massimo rilievo, e ancora concorsi di bellezza per l’elezione di una miss Europa e di un mr. Europa, i quali poi dovrebbero rappresentare l’Unione ai concorsi mondiali, realizzando una rappresentazione simbolica dell’Unità…
[lxxxvii] Si pensi a tale proposito al diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e al diritto di rivolgersi al Mediatore europeo.
[lxxxviii] In particolare si veda: D. ARCHIBUGI, Cittadini del mondo. Verso una democrazia cosmopolitica, Milano 2009, nel quale pure si discute della necessità di introdurre la cultura del dialogo e dell’inclusione a partire dalla domanda iniziale sulla possibilità di una regina per il mondo, cultura rispetto alla quale assume un ruolo centrale il problema della lettura teorica e pratica dell’istituto della cittadinanza nella direzione di una prospettiva cosmopolitica all’interno della democrazia globale.
[lxxxix] Basti qui ricordare che in materia di acquisto della cittadinanza nei paesi europei a forte immigrazione l’acquisto della cittadinanza per ius soli varia notevolmente: così in Spagna, la cittadinanza si acquista per nascita da padre o madre spagnola, oppure per nascita sul territorio anche da cittadini stranieri, di cui però almeno uno nato anch’esso in Spagna; in Germania, in generale la cittadinanza si acquista per ius sanguinis ma, a partire dal primo gennaio 2000, i bambini nati sul territorio tedesco da genitori non tedeschi acquisiscono la nazionalità se almeno uno dei genitori ha il permesso di soggiorno permanente da non meno di tre anni ed è residente in Germania da non meno di otto, sempre a condizione che facciano richiesta per ottenere la cittadinanza entro i 23 anni. In Gran Bretagna, acquista la cittadinanza chi nasce sul territorio britannico anche da un solo genitore che sia cittadino al momento della nascita o che è residente legalmente nel paese e abbia l’ «Indefinite leave to remain» oppure il «Right of Abode». Ancora, in Francia, si è francesi per nascita sul territorio se i genitori sono entrambi francesi, anche se naturalizzati, mentre chi è nato da cittadini stranieri può acquisire la cittadinanza se ha risieduto almeno cinque anni in Francia dall’età di 11 anni e ne fa richiesta alla maggiore età (18 anni); in Olanda, la nascita sul territorio non garantisce in generale la cittadinanza; in Svizzera, infine, il diritto secondo la terra non conferisce il diritto di cittadinanza.
[xc] La complessità del processo di autocomprensione dell’individuo appare oggi da sviluppare sia sul piano del conscio che su quello dell’inconscio. Quanto al primo: non solo co-esistiamo volenti o nolenti con altri uomini ma non nasciamo solo come Io separati ma, e paradossalmente innanzitutto, anche per un altro. In questo senso, la strutturale insufficienza a se stessi, alla propria realizzazione, di ogni individuo, che si è detto essere alla base di ogni ontologia della Polis come di ogni concezione sussidiaria della Politica nell’accezione classica, trova espressione per le grandi religioni monoteiste in una prospettiva anzitutto metafisica: nella specie per i cristiani, ogni uomo è creatura di un Altro, a immagine del quale siamo tutti fatti nell’unità del genere umano, e creatura al pari degli altri uomini, di ogni altro singolo uomo e di tutti gli uomini, nei quali peraltro si specchia e trova il volto di Cristo, Figlio dell’Uomo e prova della comune umanità. Ma insieme, anche a lasciare da parte per così dire il cielo e la Gerusalemme celeste, la strutturale apertura all’altro si può cogliere facilmente a partire dalla consapevolezza che ciascuno non è frutto di una propria e autonoma cellula bensì è unione di due cellule, maschile e femminile, ciascuna altra rispetto all’una e da sola destinata a non diventare vita umana, persona, se non attraverso l’Unione, generatrice di diversità nel nascituro. Il legame indissolubile con ciò che è altro da noi, geneticamente inscritto in quella unione di cellule, è reso manifesto anche dalla «ospitalità» che ciascuno riceve nel grembo materno da colei che è altra da noi ma che sola può permettere o anche impedire (chiudendo con l’interruzione di gravidanza quell’altra porta dell’amore e della integrazione dinamica, che fonda lo stesso venire in essere di nuove identità individuali a partire da preesistenti identità comunitarie, del padre e della madre nella famiglia, e così recidendo un proprio «alter ego») prima lo sviluppo nel proprio ventre e poi, con la nascita, la venuta al mondo. E pertanto anche in questa evidente manifestazione è possibile verificare il legame tra l’Io e l’altro, il quale ultimo è condizione essenziale del nostro venire in essere e insieme prima sede della nostra ontologica, strutturale co-esistenza con esso.
Quanto poi al secondo, è possibile attraversare i percorsi dell’autocomprensione e con essa dell’estraneità fino a giungere, per così dire, a Freud e andando ancora oltre alla virtualità delle tecnologie informatiche postmoderne. Anzitutto, l’illustre padre della psicanalisi ri-conduce in noi stessi, nel nostro inconscio, quella inquietante estraneità che costruisce porte e frontiere e spesso induce pure a tenerle chiuse a tanti altri, attraverso i meccanismi di formazione delle identità individuali e collettive che definiscono l’esclusione insieme all’appartenenza. Tra etica (della psicanalisi) e politica, come rileva J. KRISTEVA, op. cit., che pure poi rileva in particolare, pag. 174: «Nel rifiuto affascinato che suscita in noi lo straniero, c’è una parte di inquietante estraneità nel senso della depersonalizzazione che Freud ha scoperto e che si ricollega ai nostri desideri e alle nostre paure infantili dell’altro – l’altro della morte, l’altro della donna, l’altro della pulsione incontrollabile. Lo straniero è dentro di noi. E quando fuggiamo o combattiamo lo straniero, lottiamo contro il nostro inconscio – questo “improprio” del nostro impossibile “proprio” … Freud non parla degli stranieri: egli ci insegna a scoprire l’estraneità dentro di noi. E questo è forse il solo modo di non perseguitarla fuori». E nella dis-integrazione che si accompagna alle dinamiche della globalizzazione e della crisi delle identità individuali, secondo quanto ho già rilevato nel corso di questo studio, appare interessante, anche solo in forma di suggestione, percorrere l’ipotesi delle esperienze estreme della virtualità, e particolarmente la costruzione di una vita parallela, una città aperta a tutti gli utenti-iscritti, quali «realtà» nelle quali trova espressione in parte quella spinta del nostro alter ego, che Freud era sembrato inquadrare per l’appunto nel tema dell’inquietante estraneità a noi stessi.
[xci] Jalal ad-Din Rumi